

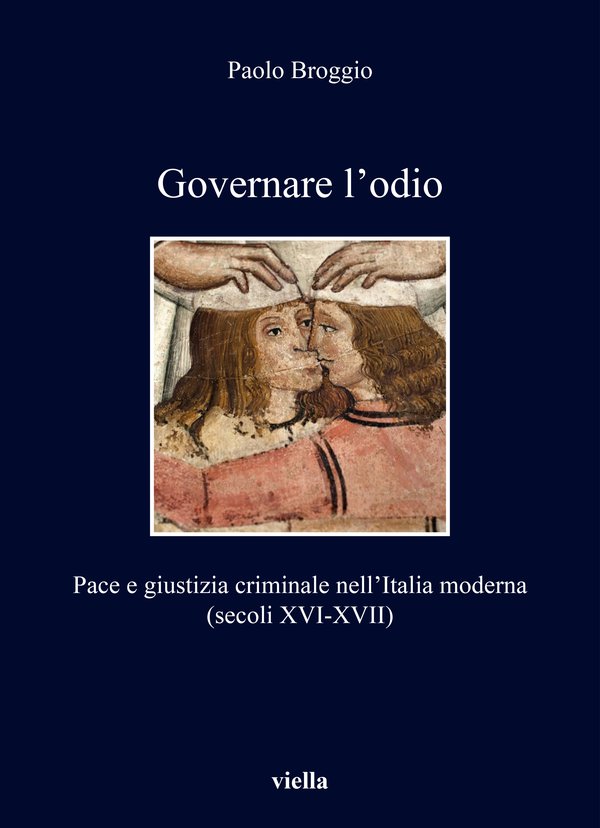
Reviewer Pasquale Palmieri - Università degli Studi di Napoli Federico II
CitationLa storiografia è ormai solita legare l’idea di giustizia in età moderna ai processi di costruzione dello Stato, all’avanzamento politico della sovranità, alla capacità dei poteri costituiti di definire norme e procedure valide per l’intero corpo dei sudditi. Secondo questa prospettiva, l’istituzione di nuovi organi giudicanti slegati da interessi particolaristici avrebbe permesso di disegnare nuove mappe della morale, individuare i nemici della comunità, tracciare la linea di separazione fra il bene e il male, distinguere le condotte giuste da quelle sbagliate. Queste letture sono tuttavia il frutto di una concezione del potere giudiziario che ha trovato la sua piena realizzazione solo negli ultimi tre secoli, in virtù dei cambiamenti stimolati dal pensiero illuminista, dalle rivoluzioni e dalle riforme napoleoniche. Esercitare la giustizia significherebbe quindi detenere il diritto di sorvegliare, sanzionare, punire e perdonare: su questo terreno tendiamo a proiettare – almeno per quanto riguarda lo scenario europeo – i rapporti fra i governi centrali e le altre giurisdizioni territoriali, nonché le interazioni fra magistrature cittadine, enti ecclesiastici e signorie feudali.
Una minore attenzione è dedicata alla tendenza a risolvere i conflitti per via arbitrale o pattizia, talvolta considerata come un semplice residuo dell’età medievale e non come una caratteristica dirimente degli scenari successivi al XV secolo. Di questo tema si occupa un recente libro di Paolo Broggio: Governare l’odio: Pace e giustizia criminale nell’Italia moderna (Roma, Viella, 2021). L’autore si concentra sulla cultura della negoziazione e della transazione, che fra Quattro e Seicento riuscì a fare in modo che il contenzioso giudiziario non fosse il principale strumento di ristabilimento dell’ordine. Si commetterebbe infatti un errore nel credere che le logiche dello scontro riuscissero a permeare la vita sociale. Al contrario, esse erano spesso disinnescate prima ancora di entrare in funzione. In parecchie circostanze il giudizio dei tribunali risultava inutile, poiché si preferiva ricorrere ad accordi o accomodamenti, grazie ai quali le vittime acquisivano il diritto ad avere risarcimenti e gli aggressori erano sollevati dai loro debiti. Nella tessitura di queste riconciliazioni giocavano un ruolo importante anche le motivazioni religiose: attraverso la stipula di un patto, gli attori in causa potevano non solo evitare di oltrepassare la soglia dei tribunali, ma anche pretendere di preservare la collettività dai pericoli del peccato.
Tutti questi indizi potrebbero far pensare a un predominio delle continuità sulle discontinuità, che si sarebbe reso visibile nella persistenza di privilegi e particolarismi tipici dell’età medievale. Il lavoro di Broggio cerca di sovvertire questo luogo comune, chiarendo che le paci non furono un fenomeno meramente «privato» o un modo per aggirare la legge, bensì uno strumento nelle mani delle autorità per controllare le asimmetrie del corpo sociale e ricomporre le ostilità che lo laceravano. In altre parole, le paci non avevano una funzione incidentale nel sistema repressivo: al contrario, si configuravano come parte strutturante dello stesso sistema, riconnettendosi a ideali di «speditezza e brevità, di rigetto delle cavillosità, in grado di definire non solo le aspirazioni degli attori sociali, ma anche le concrete modalità di governo del crimine e della conflittualità» (p. 358). Per queste ragioni, gli accomodamenti erano obiettivi concreti, perseguiti in maniera consapevole da chi muoveva le leve del potere.
La cultura della negoziazione riuscì quindi a convivere con il rafforzamento della giustizia sovrana, rendendo quest’ultima più adattabile alle situazioni concrete di gestione dei territori. Le istituzioni cooperarono al perfezionamento di questo connubio, finalizzando il loro operato al raggiungimento della concordia sociale. Usarono la coercizione per indurre i litiganti a trovare degli accordi, minacciandoli talvolta di incorrere in pene severe, che oscillavano dalle ammende economiche fino alla prigionia. Sarebbe quindi un errore pensare che le parti in causa desiderassero la pace al solo scopo di evitare il giudizio dei tribunali competenti: essa era infatti sancita davanti ai notai, ed era accompagnata da un marchio di ufficialità che comportava l’assunzione di impegni gravosi per il futuro. I documenti che la ratificavano tendevano a sottolineare la spontaneità della scelta compiuta dai contraenti e includevano anche motivazioni religiose a suggello del patto raggiunto. Ma la realtà nascondeva una corposa serie di coercizioni, che fanno apparire l’intesa finale – leggiamo in Governare l’odio – come «un tassello di un sistema integrato di pressione degli apparati giudiziari sulle comunità …» (p. 25).
Nel primo capitolo, l'autore si concentra proprio sul chiarimento della «rilevanza processuale» della pace (p. 61), che si configura come conseguenza di pressioni multiple esercitate da operatori dei tribunali e da rappresentanti del potere centrale. Le pratiche di conciliazione non mettono radicalmente in discussione il sistema di giustizia egemonica o «di apparato» – seguendo le fortunate definizioni di Mario Sbriccoli – perché a emergere sono le complementarità delle diverse modalità di ricerca della concordia sociale. È difficile pensare a «una giustizia negoziata/comunitaria» capace di rimanere incontaminata «dall’invadenza degli apparati pubblici, statali o signorili» (p. 24): gli organismi istituzionali, in tutte le loro ramificazioni, erano capaci di far percepire la loro presenza e la loro guida ai soggetti in conflitto. Trovavano inoltre un consistente sostegno normativo nella trattatistica giuridica, nella teologia morale, nella predicazione: più che ampio era il ventaglio di atti comunicativi finalizzati a promuovere la necessità di cercare soluzioni diverse dal semplice ricorso alla violenza.
Il secondo capitolo restringe il fuoco allo Stato Pontificio, facendo leva sulla documentazione del Tribunale Criminale del Governatore di Roma e del Tribunale del Torrone di Bologna. Basterebbe un semplice dato statistico per avere degli spunti di riflessione rilevanti: i processi sfociati nel pronunciamento di una sentenza sono in quantità inferiore rispetto a quelli interrotti da un accordo fra i soggetti in conflitto. Questi esiti non danno tuttavia un’idea esaustiva degli sforzi che i giusdicenti producevano al fine di abbreviare i tempi delle procedure. Le parti in causa finivano per convincersi del fatto che varcare la soglia del tribunale significava andare incontro a impegni economici gravosi, esporsi a incertezze enormi, rischiare di farsi sfuggire di mano gli sviluppi della contesa. Un ruolo importante era giocato anche dal progressivo inasprimento delle punizioni per coloro che rompevano i patti di pacificazione, venendo meno agli impegni presi con le autorità. Più che uscire indebolita da questa prassi, la giustizia egemonica finiva per esserne rafforzata, riuscendo ad abbracciare in maniera pervasiva i comportamenti individuali e collettivi.
Nel terzo capitolo, Paolo Broggio guarda ai rapporti fra centri e periferie nello Stato Pontificio, valutando il peso della presenza feudale. Le famiglie aristocratiche erano inclini a difendere le proprie prerogative, continuando a definire i territori di loro pertinenza come «stati» ed ergendosi a prime (se non addirittura uniche) elargitrici di pace. Roma cercò di reagire a queste tendenze attraverso la creazione di organismi come la Congregazione della Concordia, istituita dal legato Gabriele Paleotti nel 1574, e chiamata a risolvere le liti prima che le parti scegliessero di rivolgersi alla giustizia. L’iniziativa – assimilabile per significativi tratti comuni alla Confraternita della Concordia di Milano e della Compagnia della Pace di Palermo – si configurava come un tentativo di intrecciare l’esortazione evangelica alla conciliazione con il bisogno di snellire il sistema repressivo e rimediare al sovraccarico di lavoro dei tribunali. Allo stesso tempo, questi meccanismi favorivano un superamento delle barriere del privato, facendo in modo che la pace acquisisse una dimensione pubblica fino a identificarsi con la «pubblica quiete», innalzata a valore supremo da salvaguardare (p. 175).
Il quarto capitolo esplora la cultura della conciliazione nello scenario europeo ed extraeuropeo, rivolgendo lo sguardo alla Francia, all’Inghilterra e all’Impero spagnolo. La prospettiva comparativa adottata dall’autore include paesi interessati dalla Riforma protestante o impegnati nella diffusione del messaggio evangelico a popolazioni non cristiane. In tal modo si riesce a comprendere quanto fossero importanti le motivazioni religiose nel promuovere le paci e nel riuscire a superare prassi incancrenite come il duello e la vendetta, considerate offensive verso il volere di Dio e fonti di disordini sociali permanenti. Anche se il pensiero giuridico e teologico promuoveva con decisione gli accomodamenti, l’odio sociale finiva spesso per sovrapporsi all’odio religioso, favorendo la sopravvivenza di tensioni e lo spregio degli impegni presi al cospetto delle autorità. Soprattutto nei «contesti di convivenza pluriconfessionale», il riferimento alla fede o all’aldilà «che solitamente si poneva alla base degli accordi» diventava «un ostacolo quasi insormontabile» (p. 222).
Nel quinto e ultimo capitolo, l’autore affronta i diversi livelli della promozione della pace attraverso l’iconografia, l’insegnamento teologico, l’omiletica, la penitenza e la remissione dei peccati. Il ruolo degli ecclesiastici era fondamentale. Il perdono dei torti subiti era una delle condizioni irrinunciabili per raggiungere un accordo e porre fine a un conflitto, ma era altrettanto necessario per ottenere l’assoluzione dal confessore. Quest’ultimo era dunque tenuto a pretendere dal peccatore segni di indulgenza nei confronti del nemico sia nel foro interno, nel segreto del cuore, sia in quello esterno, attraverso manifestazioni di benevolenza e armonia.
Erano in definiva le immagini, i gesti e le parole – ben coordinate in un sistema comunicativo dotato di caratteri variegati – a suggerire alla coscienza del fedele tutte le ragioni per le quali era consigliabile tenersi lontani dai tribunali. La litigiosità era descritta come origine di angosce difficili da cancellare, che si dipingevano sui volti e nelle anime degli esseri umani, trasformandosi in pesi insostenibili. La concordia trovava invece nell’abbraccio uno dei suoi momenti più significativi, soprattutto se consumato sotto lo sguardo della vergine Maria e degli angeli. Il messaggio era chiaro: solo mettendo da parte l’odio si poteva rimanere all’interno della comunità cristiana.
Alla base di queste elaborazioni c’era l’idea che le corti di giustizia avessero il potere di perpetuare i conflitti e, di conseguenza, di rompere equilibri sociali consolidati. Forse proprio in questo nodo si scorge un filo di fondo importante che contribuì a preservare la compattezza di un sistema complesso, fondato sulla complementarità fra apparati repressivi e tecniche di pacificazione. Il potere sovrano non mirava a cambiare i connotati dell’organizzazione sociale, ma si proponeva di conservare e legalizzare le forme strutturali di privilegio, sottoponendole alla sua approvazione. Come hanno spiegato di recente Stephen Cummings e Laura Kounine, i sistemi di risoluzione dei conflitti in età moderna producevano un «rafforzamento delle disuguaglianze»[1]. Le gerarchie e le distinzioni fra ordini – si pensi a quella tradizionale fra lavoratori, religiosi e guerrieri – erano connaturate alla condizione delle persone, e accettarle era un presupposto essenziale per essere parte del corpo sociale.
In un contesto del genere, risultava difficile immaginare una giustizia che ambisse a essere completamente neutrale rispetto alle parti in causa. Molto frequenti erano i benefici e le esenzioni, che dividevano le persone in base al ceto di appartenenza, alla ricchezza, all’etnia, alle scelte culturali, al genere, al credo religioso. In altre parole, non era possibile considerarsi uguali di fronte alla legge o all’autorità: i casi andavano risolti sulla base di considerazioni specifiche legate all’estrazione sociale e, più in generale, all’identità dei soggetti coinvolti. E imporre la pace era uno degli strumenti più efficaci per raggiungere questi scopi.
[1] S. Cummings - L. Kounine, Introduction: Confronting Conflict in Early Modern Europe, in S. Cummings - L. Kounine (edd), Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe, Farnham Burlington, Ashgate, 2016, pp. 1-16, qui p. 6, cit. in Governare l’odio a p. 20.