

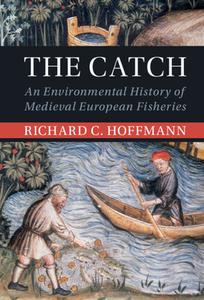
Reviewer Giulia Arrighetti - Università di Firenze
CitationRichard Hoffmann, già autore di un’importante sintesi sulla storia ambientale nel Medioevo[1], in questo volume esplora le interazioni tra le società umane e gli ecosistemi acquatici d’Europa durante il millennio medievale che si estende dal 500 al 1500 circa. Nell’ampia introduzione, che parte dalla descrizione di tre temi – la scomparsa dello storione atlantico, l’evoluzione degli approcci socioculturali agli ecosistemi di acqua dolce del Lago di Costanza e la storia della pesca e del commercio del merluzzo – evidenzia l’unicità dei contesti locali di un’attività diffusa ovunque. L’autore afferma inoltre che la pesca, intesa come una pratica ecologica e culturale allo stesso tempo, se studiata spostando la scala dal sito specifico alle più generali strutture socioeconomiche, fino ad arrivare alle rivoluzioni ecologiche, permette di passare dall’esperienza umana individuale alle generalizzazioni collettive, diventando una dimostrazione esemplare di come andrebbe sviluppato uno studio di storia ambientale.
Negli otto capitoli che seguono Hoffmann analizza il tema della pesca all’interno della più ampia evoluzione dell’economia post-romana dell’Europa occidentale cristianizzata, non mancando mai di indicare i forti vincoli culturali e la variabilità locale relativa ai distinti ecosistemi acquatici del subcontinente.
Il primo capitolo introduce i concetti fondamentali relativi a questi ecosistemi, partendo dalla geografia fisica e dalla glaciazione del Pleistocene. La narrazione si apre con l’ambiente d’acqua dolce e si sposta progressivamente verso quello marino, con l’obiettivo di ricostruire le relazioni sviluppatesi nel tempo tra le specie ittiche e il loro habitat. Il secondo capitolo continua la costruzione del quadro analizzando le modalità attraverso le quali il pesce, in quanto alimento destinato al consumo umano, costituì una delle prime forme di interazione e appropriazione dell’ambiente acquatico, anche – ma non esclusivamente – mediante la sua trasformazione da elemento naturale ad oggetto culturale. Viene messo in luce come la crescente conformità alle norme religiose cristiane incoraggiò il consumo di proteine del pesce in ritmi settimanali e stagionali, diventando al contempo un indicatore di status sociale e politico per coloro che potevano permetterselo.
Il terzo e il quarto capitolo impostano una narrazione che si sviluppa dal ruolo della pesca di sussistenza diretta da parte dei lavoratori appartenenti alle classi sociali più basse, per arrivare alla nascita dei pescatori artigiani nel X secolo. L’autore sottolinea come la pesca di sussistenza, diversa da luogo a luogo, sopravvisse con importanza decrescente per tutto il Medioevo creando un bagaglio di esperienze sulle quali si fondavano le comprensioni ecologiche locali e tradizionali di quel periodo. Con il passare dei secoli, nonostante i beni di consumo di base sfusi e deperibili come le risorse ittiche faticassero a rientrare nello scambio mercantile, intorno ai grandi centri ecclesiastici e secolari i pescatori di sussistenza trovavano facilmente persone disposte a pagare per le loro eccedenze. In seguito, il suo consumo seguì la crescita dei mercati incentrandosi nelle città e portando all’emergere di pescatori artigiani che si specializzarono in piccole pesche negli ecosistemi naturali locali e, più tardi, estesero la loro attività ad acque artificiali e distanti. In questa ricostruzione, Hoffmann evidenzia come siano stati i comportamenti delle specie ittiche autoctone a plasmare in primo luogo le pratiche lavorative dei pescatori, le quali si sono poi evolute all’interno di contesti più ampi, dando origine a reti sociali ed economiche condivise, rese visibili negli strumenti utilizzati in comune e nei metodi di cattura adottati.
Il quinto capitolo, invece, mostra come l’espansione demografica ed economica nell’Europa altomedievale sia stata accompagnata da una parallela crescita del commercio del pesce, che iniziò a rifornire i principali centri di consumo e a delineare reti di mercato su scala regionale. Questa crescita ebbe come conseguenza una pressione sugli ecosistemi acquatici che minacciò specie sensibili, facendo acquisire importanza dietetica ad altre meno prestigiose ma più accessibili. Il capitolo successivo prosegue delineando come le risposte alla preoccupazione della scarsità del pesce culturalmente apprezzato furono alla base dei radicali cambiamenti nella gestione delle attività di pesca in Europa a partire dal XII secolo in avanti. Misure che differirono a seconda degli ecosistemi regionali, delle relazioni economiche e dell’accesso alle risorse, ma che si direzionarono ugualmente verso una limitazione o razionalizzazione dell’accesso agli stock ittici e verso una protezione o mantenimento degli stessi per il bene comune.
Gli ultimi capitoli sono dedicati alle due innovazioni tardo-medievali che, cercando di ampliare l’offerta delle risorse ittiche, portarono a conseguenze più ampie e durature nel rapporto tra le comunità umane e gli ambienti acquatici. Da un lato, si trattò di gestire e costruire degli stagni artificiali per la carpa domestica, elemento che contribuì alla creazione di nuovi ecosistemi locali colonizzati trasformando il pesce in un «manufatto umano» (p. 406). Dall’altro lato, l’estensione dell’attività di pesca a regioni e specie marine fino a quel momento non sfruttate, richiese nuove tecnologie e strutture organizzative per conservare il pescato e trasportarlo a mercati di consumo distanti. Tuttavia, l’autore precisa che nessuna delle due forme applicate agli ecosistemi acquatici liberò la pesca dagli impatti e dai vincoli naturali a cui restava inevitabilmente legata.
Infine, è importante evidenziare quelle che Richard Hoffmann chiama sottocorrenti del suo volume, ovvero quelle linee narrative che travalicano i capitoli e che funzionano da fil rouge per tutte le tematiche specifiche affrontate nel corso del testo. La prima è indubbiamente la modalità operativa di indagine alla base del libro, che è condivisa tra le discipline e presuppone, quindi, una comparazione tra i dati proposti dai testi storici, dai materiali archeologici e dalle paleoscienze, con l’obiettivo di raggiungere, nello studio di ciascun caso, una concordanza di prove derivanti da fonti indipendenti e non correlate. La seconda è la rilevanza della TEK – Traditional Ecological Knowledge – ovvero il bagaglio di saperi posseduto dalla maggior parte della popolazione analfabeta che sottostava alla cattura e alla conservazione delle varie specie ittiche. Una conoscenza che Hoffmann definisce una «known unknowns» (p. 407) perché è quasi impossibile da recuperare attraverso i dati a nostra disposizione, ma della quale conosciamo l’esistenza e dobbiamo tener conto in ogni contesto di analisi.
Il libro si conclude richiamando quelle che l’autore definisce eredità medievali nella crisi globale della pesca odierna. Da un lato, l’idea di dominio umano sulla natura – frutto di un determinismo culturale – e la fiducia in risorse inesauribili si riflettono nella convinzione attuale che, con un adeguato know-how scientifico e tecnologico, gli esseri umani possano rimodellare il mondo a proprio piacimento. Dall’altro, dinamiche come la distribuzione del pescato, la reazione alla sua scarsità e la trasformazione dei paesaggi per farvi fronte non appaiono affatto nuove se osservate in una prospettiva medievale.
Ciò che Hoffmann sottolinea nelle battute finali, è che sebbene la storia e le esperienze del passato non permettano di sapere con esattezza cosa accadrà nel futuro, possono però aiutarci a riconoscere schemi, dinamiche o cause ricorrenti che nel corso dei secoli hanno avuto effetti positivi o dannosi, influenzando sia la natura che la società umana.
[1] R.C. Hoffman, An Environmental History of Medieval Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.