

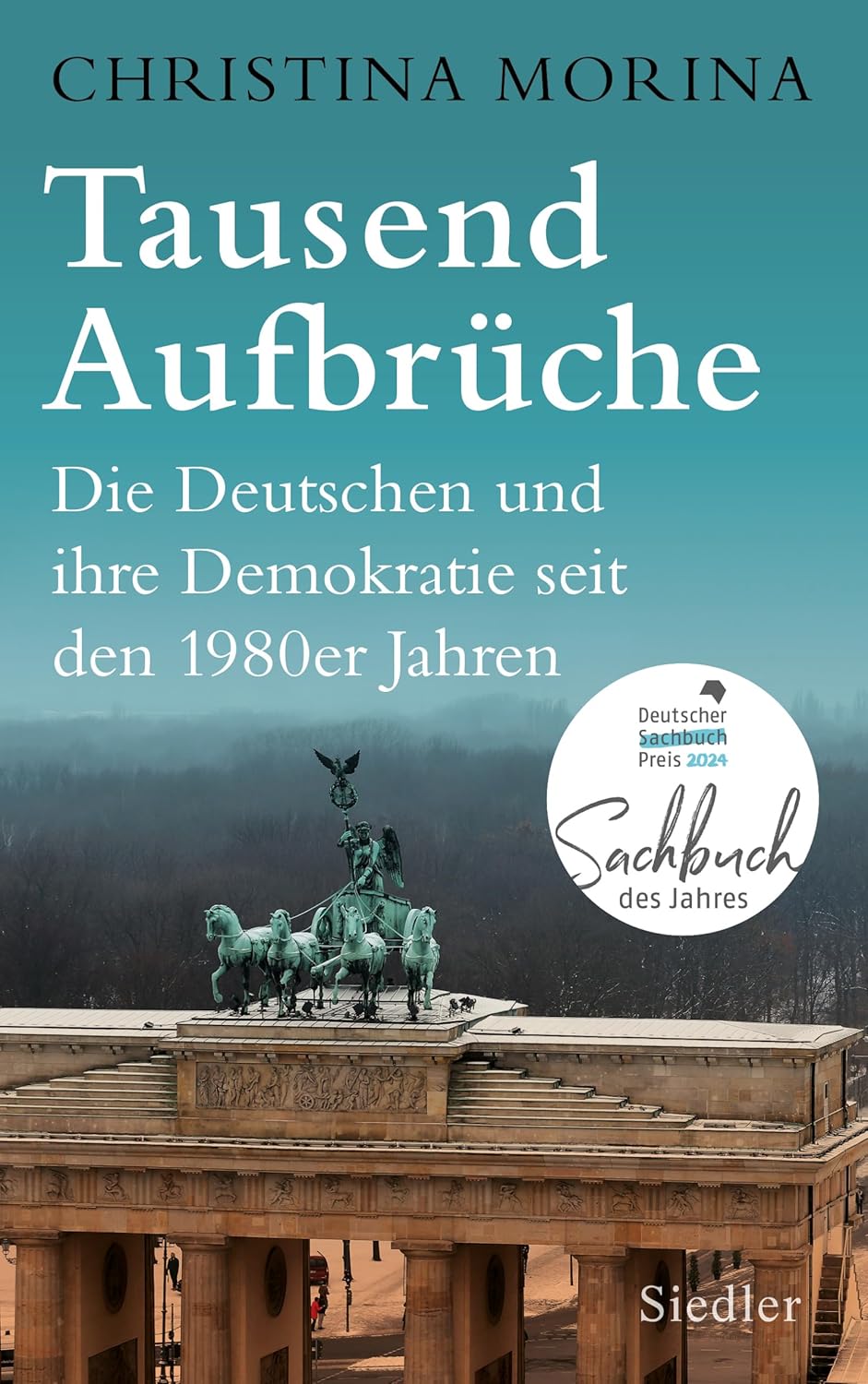
Reviewer Costanza Calabretta - Istituto Italiano di Studi Germanici
CitationVincitore nel 2024 del prestigioso Deutscher Sachbuch Preis, Tausend Aufbrüche è stato riconosciuto dalla giuria come uno studio che riesce a tracciare una «profonda storia della democrazia tedesco-tedesca ‘dal bassoʼ, al di là di schemi narrativi preconfezionati e di polemiche unilaterali», dando «nuovi impulsi e prospettive ai dibattiti ormai cristallizzati tra Est e Ovest» (https://www.deutscher-sachbuchpreis.de/aktuelles-jahr/2024/tausend-aufbrueche). Christina Morina, professoressa di storia contemporanea presso l’Università di Bielefeld, firma effettivamente un libro capace di riflettere sulla democrazia tedesca da una prospettiva originale e solida metodologicamente, offrendo un contributo al dibattito pubblico.
Tausend Aufbrüche comincia con una domanda: cosa lega la rivoluzione democratica dell’89 nata in Sassonia, Turingia, Brandeburgo, con il recente sostegno all’Afd (Alternative für Deutschland), dunque ad un partito populista di destra radicale? (p. 13). Per affrontare questa questione cruciale, lo studio adotta una prospettiva ‘internaʼ, analizzando le concezioni della democrazia e della società civile dei tedeschi, prima e dopo la cesura del 1989. Collocandosi nel dibattito attuale sulla crisi della democrazia, l’autrice cerca anche di rinnovarlo, allontanandosi dalle direttrici teoriche principali ‒ che vedono la democrazia in modo prosaico, come uguaglianza politica, o ‘empaticoʼ, come equità, uguaglianza nelle possibilità, ampliamento della partecipazione (p. 25). Per ricostruire la cultura politica ‘dal bassoʼ, Morina utilizza fonti variegate e inedite come lettere di cittadini, petizioni, volantini, oltre alle fonti giornalistiche e ai discorsi politici. Ulteriore elemento di originalità è l’adozione di una prospettiva inter-tedesca, con la messa a confronto e l’intreccio delle vicende fra Est e Ovest, evitando le annose polarizzazioni. Questa scelta si fonda sulla considerazione che la storia della RDT, anche se non è una storia democratica, è comunque una «storia di rivendicazione della democrazia» (p. 27). Se pure una ‘democrazia socialistaʼ ci fu solo in apparenza, questa fu sempre postulata dalla SED e su questa promessa si confrontarono i cittadini della RDT, accettandola, criticandola, credendo o meno nella sua realizzazione. Guardando alla RDT non solo come una dittatura, ma anche come una democrazia promessa, si riesce a dar conto della forza di mobilitazione e di integrazione dello Stato della SED. Dall’altro lato, invece, la democrazia della RFT è stata raccontata come una storia di successo (Erfolgsgeschichte), ma è anche da problematizzare come un progetto complesso, giovane e precario.
I primi due capitoli del volume, che costituiscono la sua premessa fondamentale, sono dedicati ad approfondire il modo in cui sono state comprese e concepite la democrazia e la cittadinanza fra i tedeschi della RFT e della RDT. L’autrice usa come fonti lettere scritte da cittadini tedesco-occidentali ai presidenti della Repubblica federale Karl Carstens e Richard von Weizsäcker, e lettere di cittadini tedesco-orientali trovate nell’archivio della Stasi. Oltre alle differenze (nelle concezioni di partecipazione e rappresentanza, come nella distribuzione dei poteri), emerge una somiglianza: negli anni ’80 le due società erano inquiete e politicizzate.
Il terzo capitolo, quello centrale, si focalizza sulle concezioni della democrazia che si svilupparono durante la Rivoluzione pacifica del 1989, analizzando i progetti e le iniziative intraprese dai movimenti civici (Neues Forum, Demokratischer Aufbruch, Demokratie jetzt). L’autrice guarda in modo inedito alle loro speranze e aspettative, alle loro richieste di una democrazia di base, diretta e popolare, mettendo in luce come la democrazia fosse concepita soprattutto come «una prassi quotidiana e sorprendentemente meno come un ordinamento politico» (p. 144). Evidenzia, inoltre, come le riflessioni su un nuovo ordine economico e la domanda sulla giustizia sociale avessero delle corrispondenze nella società e nella politica della RFT. I riformatori democratici della Germania occidentale, in particolare i critici della democrazia partitica che lottavano per una maggiore democrazia di base, videro rafforzarsi le loro speranze nelle rivendicazioni orientali.
Gli ultimi due capitoli, infine, si avvicinano al presente e passano ad analizzare il piano politico e partitico. Morina mette in luce come il clima democratico di rinnovamento, i «mille inizi», già nel 1990 lasciarono il posto a un senso di inevitabilità, dettato anche dall’incertezza rispetto alla situazione economica e internazionale. Analizzando il dibattito sulla costituzione, evidenzia come esso abbia rappresentato «un momento importante per l’auto-comprensione della società civile» (p. 230), anche se l’istanza di una partecipazione più diretta alla democrazia rimase inascoltata. L’ultimo capitolo affronta l’era del cancellierato Merkel, giudicato ambivalente perché incapace di superare la marginalizzazione degli interessi tedesco-orientali, nonostante la presenza ai vertici dello Stato della cancelliera e del Presidente della Repubblica Gauck, entrambi provenienti dall’ex RDT. Il capitolo analizza anche l’ascesa dell’AfD e si interroga sul suo successo nei Länder orientali, dipeso dall’essersi presentato come un partito alternativo a quelli tradizionali, e dall’aver rivendicato delle concezioni della democrazia tedesco-orientali (democrazia di base, governo diretto del popolo e partecipazione dei cittadini), assieme ad un ‘patriottismo solidaleʼ, le cui sfumature nazionalistiche e illiberali non sono percepite come pericolose. In questo modo l’AfD è riuscito a «rivitalizzare sia l’eredità pseudo-democratica del periodo della RDT sia gli impulsi democratici di piazza della rivoluzione del 1989 per legittimare una rivolta antiparlamentare» (p. 234).
Nella conclusione l’autrice torna a riflettere sulla democrazia, intesa come un processo e non uno stato, come una forma di convivenza sociale e non solo un sistema statale. È in questo modo che i tedeschi, fra Est e Ovest, hanno concepito la democrazia, nella sua quotidianità che non va data per scontata. Morina riesce a dare profondità alla storia del presente, tornando a riflettere su questioni cruciali della più recente storia della Germania, in un modo che non è mai normativo. La dimensione inter-tedesca viene sviluppata con originalità, restituendoci un affresco corale, complesso e sfaccettato.