

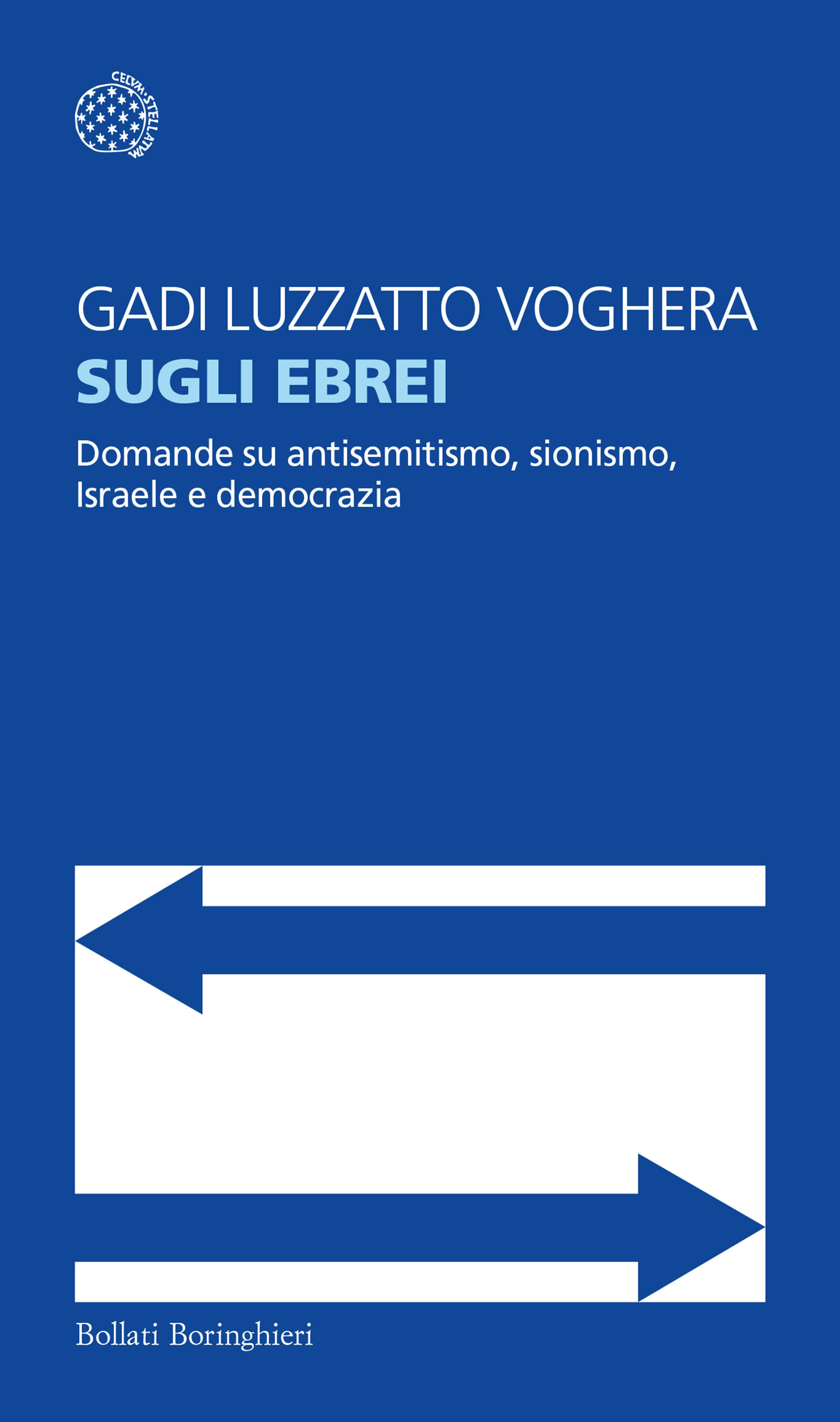
Reviewer Enrico Palumbo - Università IULM, Milano
CitationÈ un libro breve ma particolarmente denso, che affronta in chiave storica una questione – o meglio più questioni – di stretta attualità. L’autore, Gadi Luzzatto Voghera, dirige la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) di Milano ed è uno storico degli ebrei e dell’antisemitismo. Il suo punto di partenza è il 7 ottobre 2023, giorno dell’operazione terroristica di Hamas contro Israele, che ha dato avvio a una lunga guerra condotta da Tel Aviv a Gaza con risvolti umanitari drammatici. Luzzatto Voghera tira le fila della complessa matassa mediorientale e delle sue connessioni con la storia ebraica: lo fa con il metodo dell’equilibrato e autorevole storico della materia; ma anche con il punto di vista di chi osserva la realtà come direttore di un’istituzione che ospita l’Osservatorio Antisemitismo[1], che ogni giorno riceve e cataloga gli episodi di odio antiebraico che si manifestano in Italia; e infine da ebreo italiano, che, come scrive in una postfazione a tratti severa con il proprio passato, ha affrontato in più momenti della propria vita la necessità o il desiderio di rapportarsi alla vicenda dello stato di Israele (pp. 123-129).
Il volume è diviso in due parti. La prima è una sintetica ma ampia ricognizione della storia degli ebrei, significativamente intitolata «Contro la semplificazione: gli ebrei e le loro diversità»: l’assunto principale, da cui discende ogni ricaduta interpretativa del libro, è che gli ebrei sono molto diversi tra loro sia sul piano diacronico – hanno avuto molte evoluzioni, per esempio a livello religioso-devozionale o culturale – sia su quello sincronico – ogni tempo ha visto la presenza in contemporanea di un «caleidoscopio», come lo definisce l’autore, di ebrei (p. 13). Basterebbe questo a definire l’inconsistenza di ogni discorso antisemita, fondato sull’idea di un ‘ebreo immaginarioʼ, un monolite che annullerebbe l’identità plurale dei circa 15 milioni di ebrei presenti oggi nel mondo. Inevitabilmente articolate sono anche le vie che hanno prodotto le forme del politico nella cultura ebraica: il sionismo, nato alla fine dell’Ottocento come soluzione concreta alle violente persecuzioni antiebraiche in Europa, è solo una di esse e a sua volta è estremamente frammentato e plurale. Le pagine sul sionismo italiano, apparentemente marginale per le dimensioni delle comunità israelitiche della penisola, testimoniano di una peculiare e ricca elaborazione culturale capace di interagire con la cultura nazionale italiana: particolarmente illuminanti sono le riflessioni sulle influenze del dibattito post-bellico italiano nelle posizioni di Dante Lattes, interpellato nel 1958 dal governo israeliano su una interpretazione relativa alla cittadinanza dei figli di coppie miste (pp. 51-52). Queste reciproche influenze hanno in realtà riguardato tutta la vicenda ebraica: in un’altra sezione del libro l’autore ricostruisce l’evoluzione dell’ebraismo nel senso di una sua trasformazione in fenomeno meramente religioso e di un suo adattamento a pratiche che ricalcavano quelle del contesto esterno di matrice cristiana (pp. 105-109).
La nascita dello Stato di Israele ha modificato anche le espressioni dell’antisemitismo, a causa dell’identificazione del nuovo stato mediorientale con la storia ebraica. L’autore ricostruisce l’arrivo nel mondo arabo-islamico, tradizionalmente accogliente con gli ebrei in fuga dalle persecuzioni del mondo cristiano, dell’antisemitismo di matrice europea, che è spesso diventato uno degli strumenti adottati nella critica o nella lotta anti-israeliana. Luzzatto Voghera riconosce con lucidità che non vi era antisemitismo negli episodi di violenza contro i coloni sionisti nelle prime fasi della lotta palestinese, come nella rivolta del 1936-1939, e segnala che il quadro è cambiato dopo il 1948 (pp. 61-62). Proprio le complicazioni legate all’affastellarsi di nuove e diverse forme di antisemitismo hanno reso necessario, secondo alcuni studiosi, circoscrivere i contorni di cosa si possa definire tale. Da qui si sviluppano la Working Definition dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), la Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA), il documento della Nexus Task Force. Ciascuna definizione, secondo l’autore, presenta elementi di interesse e di valore, ma con importanti omissioni: come quella sulle radici religiose dell’antisemitismo e quella della dimensione intersezionale dell’odio antiebraico – quest’ultima a sua volta messa in discussione dalle timidezze di alcuni ambienti nel condannare le notizie degli stupri etnici contro le donne israeliane il 7 ottobre (pp. 64-71). Collegato a questo tema c’è il problema, solo sfiorato dall’autore, degli abusi dell’accusa di antisemitismo alle generiche critiche ai governi israeliani e alle loro politiche nei territori palestinesi occupati – peraltro ragione principale della frattura tra i fautori della dichiarazione della IHRA e quelli della JDA.
La seconda parte del libro propone alcuni temi di approfondimento introdotti da domande rivolte all’autore da un ‘lettore immaginarioʼ, che chiunque abbia frequentazione con la materia sa essere una pluralità di lettori reali. A dimostrazione di quanto siano cangianti anche le forme del pregiudizio antisemita, ci sono domande su temi relativamente nuovi: uno di questi riguarda la distorsione, diffusa recentemente soprattutto nelle reti sociali, del concetto di ebreo ashkenazita, rappresentato come una deviazione dell’ebreo originario e fautore di ogni malvagità immaginabile (pp. 87-89). Altri quesiti offrono a Luzzatto Voghera la possibilità di affrontare alcune questioni tra le più ricorrenti in chi si approccia alla storia ebraica: uno di questi è l’abuso del ricorso alla memoria della Shoah per criticare Israele, che impone un’equiparazione tra il comportamento delle autorità di Tel Aviv e i nazisti secondo la logica della «Holocaust inversion» (pp. 72-79)[2]; poi c’è il tema della ‘elezioneʼ del popolo ebraico, concetto che l’autore spiega nella sua radice biblica, a cui poi gli ebrei nel corso della storia si rapportano in modo differenziato (pp. 79-89). Non sono tramontati alcuni stereotipi infondati di lontano radicamento: sulla «doppia fedeltà» degli ebrei di altre nazionalità con lo Stato di Israele, sul rapporto degli ebrei con il denaro, sul loro settarismo (pp. 89 ss.). L’autore ricorda che, come in altri momenti più critici della storia mediorientale, anche oggi sembra che a ogni ebreo sia richiesto di rendere conto delle azioni compiute dai governi israeliani, come se l’identità ebraica coincidesse con quella israeliana: un meccanismo che contribuisce a ingenerare confusione e che si lega al ricorso ad argomentazioni che attingono al repertorio antisemita.
A conclusione di questa esposizione schematica dei principali elementi di pregio del libro, mi permetto di segnalare invece un aspetto in cui sarebbe stato opportuno un approfondimento. Riguarda la trattazione, un po’ frettolosa, della prospettiva post-coloniale, rappresentata in modo troppo semplificato e inserita in un discorso che sembra alludere alla presenza di scorie antisemite in chi vi ricorre (p. 57). L’interpretazione del sionismo come fenomeno coloniale (o meglio come settler colonialism), e quindi dei palestinesi come popolo subalterno, è in realtà al centro di un articolato dibattito – certamente, come ogni prodotto della riflessione umana, non privo di forzature ideologiche in alcuni dei suoi fautori e di strumentalizzazioni malevole in alcuni dei suoi estimatori – che ha avuto tra i suoi principali animatori anche diversi studiosi israeliani: si pensi a esponenti della sociologia critica come Gershon Shafir e Baruch Kimmerling, che hanno ragionato secondo quest’ottica fin dagli anni Ottanta e via via molti altri studiosi fino a oggi[3]. Certamente una maggiore considerazione di questo dibattito non avrebbe inficiato la solidità dell’architettura interpretativa del volume e anzi avrebbe offerto un elemento di maggiore complessità proprio in linea con le tesi centrali espresse dall’autore, essendo israeliani o ebrei parecchi autori che hanno saputo riflettere sul sionismo con spirito critico e autonomia di giudizio.
La vicenda dello Stato di Israele ha dunque modificato in modo definitivo la traiettoria non solo della storia ebraica ma anche dell’antisemitismo. Si tratta di una questione che interessa tanto i sostenitori delle politiche israeliane quanto chi vi si oppone, perché le argomentazioni anche solide per criticare Tel Aviv ci sono e non necessitano del macabro e fuorviante registro antisemita. Ugualmente l’aumento dell’antisemitismo nel discorso pubblico è un tema che sollecita non solo gli ebrei ma anche tutti gli altri cittadini, perché, come ricorda Luzzatto Voghera in un passaggio che conserva valore civile per l’Italia, le limitazioni alla libertà degli ebrei sono, in varie forme, palesi violazioni dei principi costituzionali espressi in vari articoli (da quelli sul diritto allo studio a quelli sulla libertà religiosa) (pp. 100-101) e la demolizione della Costituzione parte sempre dall’inadempienza parziale di alcune sue parti, per alcuni dei suoi cittadini.
[1] Si veda: www.osservatorioantisemitismo.it (ultimo accesso 22 agosto 2025).
[2] Cfr. L. Klaff, Holocaust Inversion, in «Israel Studies», 24, 2019, 2, pp. 73-90.
[3] Sul dibattito, cfr. A. Marzano, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl a oggi, Roma, Carocci, 2017, pp. 65-71.