

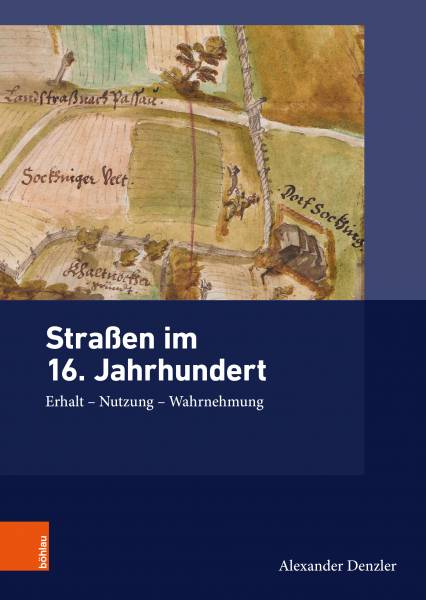
Reviewer Andrea Pojer - Università di Trento | FBK-ISIG
CitationNegli ultimi anni, la storiografia legata al cosiddetto mobility turn ha toccato una varietà tematica importante. In questo dibattito, tuttavia, l’elemento infrastrutturale della strada ha ricevuto un’attenzione solo marginale, pur essendo essenziale a quasi tutte le forme di mobilità premoderne. Spostare l’attenzione verso questa mancata protagonista è uno degli obbiettivi della monografia di Alexander Denzler.
Lo studio, che metodologicamente si colloca in un punto di intersezione tra storia dello spazio, dell’ambiente e della materialità, si interroga sulla dimensione materiale delle strade a partire da un approccio prasseologico volto a ricostruire i «doings and sayings» (p. 59) che animavano le società di età moderna. Denzler non si interessa a come le strade permettessero a persone, merci e informazioni di spostarsi da un punto A a un punto B, ma alle pratiche, spesso modellate da fattori ambientali, che ne caratterizzarono la forma, l’utilizzo, la manutenzione e l’appropriazione da parte di diversi attrici e attori storici[1]. Lo studio si distingue per la considerevole ampiezza di fonti diverse utilizzate attraverso le quali viene fornita un’immagine quanto mai variegata delle relazioni instaurate con lo spazio stradale. Particolare attenzione è dedicata al contesto rurale (altro punto bianco all’interno del dibattito) con un focus specifico sulla parte meridionale del Sacro Romano Impero e sull’importante nodo viario di Norimberga durante il Cinquecento.
L’introduzione, tanto densa quanto scorrevole, colloca l’indagine efficacemente all’interno di uno stato dell’arte che viene ricostruito con precisione, attingendo principalmente alla letteratura germanofona, senza trascurare però quella francofona e anglofona. Il primo capitolo offre una ricognizione delle diverse tipologie di strade a partire dalla ricca terminologia coeva. Ricorrendo a diverse fonti visive (volantini, carte a stampa e manoscritte) il secondo capitolo si interroga sull’aspetto delle strade e sul loro rapporto con l’ambiente circostante, riflettendo anche sulle convenzioni attraverso le quali esse venivano rappresentate. L’esperienza della strada, descritta nelle fonti odeporiche, è oggetto del terzo capitolo. Esso esplora quando, come e all’interno di quali contesti narratologici la strada fu tematizzata in descrizioni di viaggio, guide e itinerari. Particolare attenzione è riservata al rapporto tra il corpo umano in viaggio e lo spazio stradale e ambientale attraversato.
Da qui il focus si sposta, nei capitoli seguenti, alla materialità della strada. Attraverso i documenti contabili dell’ufficio incaricato della manutenzione stradale di Norimberga (Weg- und Stegamt), Denzler ricostruisce quantitativamente e qualitativamente l’apporto di tempo, forza lavoro e risorse naturali necessari per il mantenimento di strade, ponti e canali. Queste riflessioni vengono poi inserite in una cornice più ampia, evidenziando come le strade rappresentarono un immancabile strumento di governo, attraverso il quale le autorità riuscirono a intensificare il proprio controllo sul territorio. Ciò si concretizzò nell’elaborazione, ai vari livelli istituzionali, di norme volte a garantire un utilizzo sicuro ed efficiente dell’infrastruttura stradale, coinvolgendo funzionari locali preposti alla sua ispezione e alla supervisione dei lavori di manutenzione. Il capitolo conclusivo si sposta sul piano della mobilità a livello locale («Mikromobilität») riflettendo sull’utilizzo quotidiano della rete viaria locale e sulla sua manutenzione. Si tratta di un cambio di prospettiva tanto utile quanto illuminante, poiché la manutenzione stradale era effettuata principalmente da parte delle comunità locali, spesso in forma di corvée (Frondienst).
Particolarmente importanti sono le evidenze presentate a sostegno di una sostanziale rivalutazione dell’efficienza dell’infrastruttura viaria premoderna. Numerose ricostruzioni storiche, spesso animate da una concezione teologica dei processi di modernizzazione, hanno insistito sulle carenze e sui malfunzionamenti delle reti stradali, almeno fino all’avvento dei grandi progetti stradali e ferroviari dei secoli XVIII e XIX. In particolare, Denzler mette in discussione la visione tradizionale secondo cui l’inefficienza stradale sarebbe da imputare a una presunta negligenza delle comunità nella manutenzione a livello locale. Oltre a dimostrare come attrici e attori a tutti i livelli dell’organizzazione sociale fossero interessati a fruire di una rete stradale funzionante, egli ricorda come la sua manutenzione fosse affidata proprio alle comunità locali, poiché il suo buon funzionamento era indispensabile alle forme di (micro)mobilità più essenziali (come il raggiungimento della chiesa parrocchiale o dei mercati più vicini).
Il volume si collega in maniera convincente e innovativa ai quesiti mossi dalla storia dello spazio, dell’ambiente, della materialità e della mobilità, facendoli convergere efficacemente. I dati empirici presentati, interpretati con straordinario rigore e puntualmente contestualizzati tramite numerosi rimandi alla letteratura storiografica, restituiscono un ricchissimo mosaico di pratiche sociali e culturali con cui numerosi attrici e attori storici si approcciarono allo spazio stradale. Oltre a fornire una ricostruzione storica ricca e precisa, lo studio offre molteplici spunti a futuri approfondimenti e ricerche, invitando ad approfondire ulteriormente le pratiche e le infrastrutture stradali extraurbane. Non resta dunque che auspicarne un’ampia ricezione.
[1] Così nel testo: «Statt die außerurbanen Straßen in erster Linie als Transport- und Verbindungslinien zu begreifen, die es Menschen, Waren und Nachrichten ungeachtet aller (baulichen) Widrigkeiten ermöglichten, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, werden die vielfältigen Erscheinungsformen, Nutzungswiesen, Instandhaltungspraktiken und Aneignungsformen der Verkehrswege durch die Menschen und in Abhängigkeit von der Natur behandelt». (p. 58).