

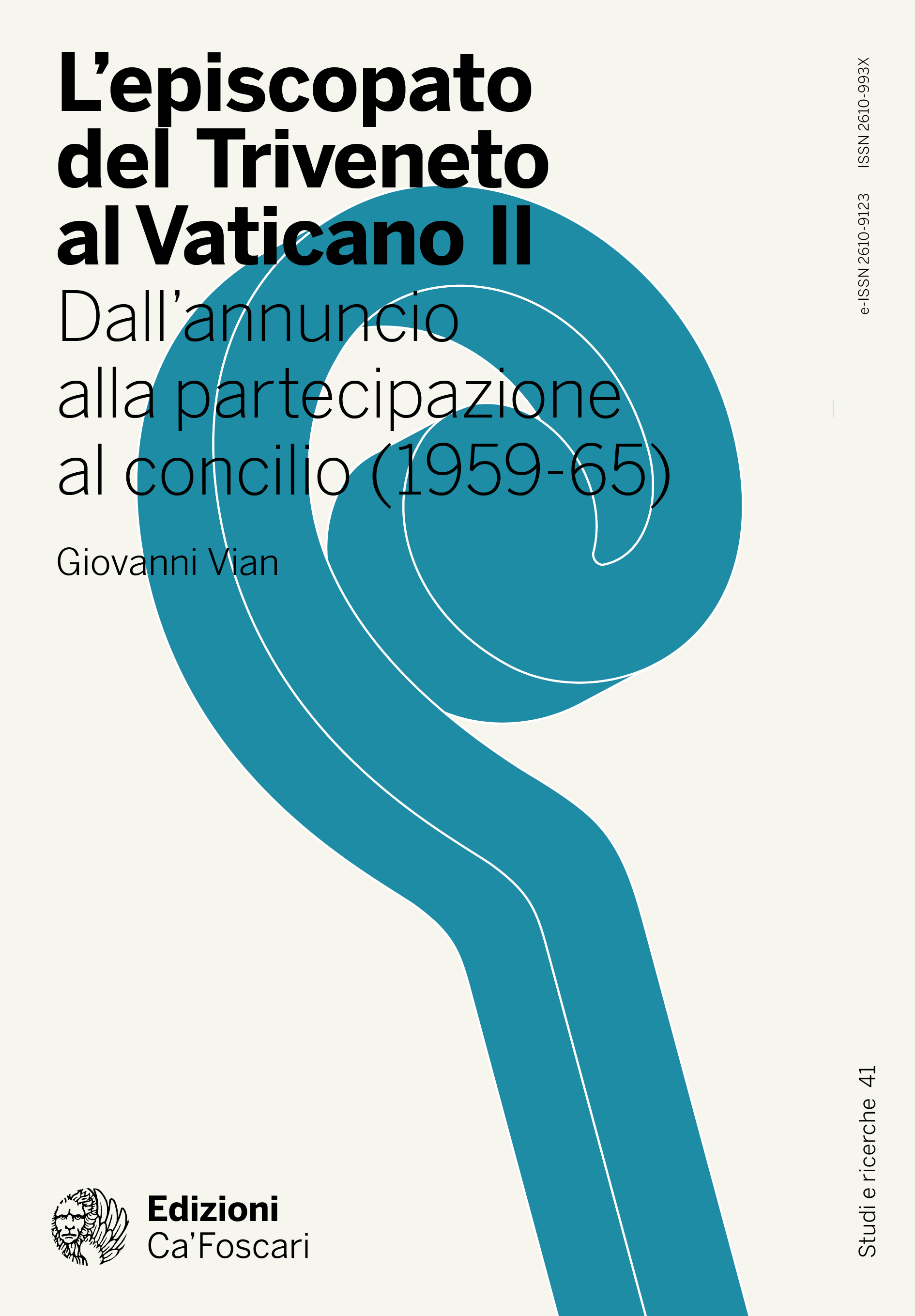
Reviewer Ivan Portelli - Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia
CitationLe indagini sull’attività dei vescovi organizzati secondo nazionalità, provenienza o contiguità linguistica al Concilio Vaticano II possono offrire risultati significativi anche per cogliere i cambiamenti in atto nel mondo cattolico nei decenni centrali del Novecento. Giovanni Vian si sofferma in questo studio sul caso della partecipazione al concilio dei vescovi afferenti alla Conferenza episcopale Triveneta (CET). La Regione ecclesiastica Triveneto comprende le diocesi di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige ed è la più grande per estensione tra le 19 regioni ecclesiastiche italiane, ma non la più popolata. Ha un numero significativo di presuli: 18 per 15 diocesi, una rappresentanza al Concilio più nutrita di quella di diversi episcopati nazionali, in buona sostanza stabile dopo le nomine seguite all’elezione di Roncalli, con all’interno un futuro pontefice. Inoltre, la collocazione ai confini della penisola permette l’apertura ad incontri e a confronti con realtà diverse da quella italiana. La fisionomia di questa regione ecclesiastica viene in parte ridefinita negli anni del Concilio e conosce un’importante variazione nel 1964 con la nascita della nuova diocesi di Bolzano-Bressanone (e in Austria di quella di Innsbruck-Feldkirch), che comporta il definitivo riassetto dei confini e delle giurisdizioni ecclesiastiche dell’area tra il Trentino e il Tirolo.
L’episcopato triveneto ha un forte punto di riferimento nel patriarca di Venezia Urbani, capace di «imprimere agli altri vescovi della Regione ecclesiastica un certo coordinamento». Si tratta di un episcopato «dotato di una sua fisionomia, che operava in una società e in una Chiesa in cambiamento» [p. 4]. Un gruppo di vescovi relativamente variegato per le posizioni, per lo più ascrivibili a una collocazione conservatrice, ma con diverse sfumature, che opera in territori dove il cattolicesimo è radicato nella società, come emerge anche dall’ampio consenso elettorale della Democrazia Cristiana. Urbani, scelto da Roncalli come suo successore a Venezia, assume un ruolo centrale al Concilio quale membro della commissione di coordinamento dei lavori; successivamente sarà posto da Paolo VI alla guida della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), segnando un cambiamento rispetto alla presidenza Siri.
Nella ricostruzione sono utilizzate principalmente fonti ufficiali edite oltre ad alcuni diari, a cui si aggiungono sondaggi archivistici, grazie all’accesso limitato alla documentazione dell’Archivio Storico della Conferenza Episcopale Triveneta (si tratta di una documentazione ancora esclusa alla consultazione). L’ipotesi che ci sia anche altro materiale è quindi più che valida.
La disamina dell’azione dei vescovi del Triveneto al Concilio parte dai vota inviati nella fase preliminare, scritti parallelamente alle prime discussioni comuni in cui si affrontano temi come l’unità dei cattolici e il rinnovamento della Chiesa. Rispetto ai 14 vota inviati su 15 (manca all’appello quello di Muccin, Belluno-Feltre) si possono fare alcune note. Ambrosi (Gorizia, fino al 1962) e Zinato (Vicenza) dichiarano di aver preventivamente sondato parte del clero diocesano, altri lo fanno di sicuro, ovvero Urbani, Mistrorigo (Treviso), De Zanche (Concordia-Pordenone). Emerge la preoccupazione per la condizione religiosa e spirituale dei sacerdoti, secondo posizioni dal sapore antimodernistico. Luciani (Vittorio Veneto) esprime ottimismo rispetto al dilagare dell’individualismo nella società e pone il problema pastorale del recupero dei fedeli comunisti. Urbani e Ambrosi si esprimono contro le discriminazioni etniche e i nazionalismi, affermando i diritti delle minoranze; sono tra i pochi vescovi italiani. Emerge da più parti la necessità di porre i religiosi sotto il controllo dei diocesani, ed in generale di un rafforzamento dell’ufficio del Vescovo; vengono sottolineati i temi della pace come anche l’importanza di famiglia e matrimonio.
Vian pone attenzione a come si organizzano la CET e la CEI durante il Concilio seguendo, attraverso le fonti al momento disponibili, la sequela degli incontri e delle riunioni. Gli incontri della CET guidata da Urbani hanno una significativa regolarità e continuità, che portano l’episcopato del Triveneto a maturare una linea comune e quindi a muoversi in maniera unitaria, su temi importanti come ad esempio il comunismo.
Vian fa un bilancio dell’effettiva partecipazione dei vescovi della regione al Concilio soffermandosi a lungo sul contributo dei singoli al dibattito conciliare, offrendo una ricostruzione puntuale e articolata, di cui qui necessariamente riportiamo solo alcuni elementi.
A fronte della posizione preminente di Urbani nel processo di maturazione del dibattito e dell’incontro tra i singoli vescovi, quelli più attivi, oltre allo stesso Urbani, risultano Gargitter (Bolzano-Bressanone), Santin (Trieste), Carraro (Verona), Bortignon (Padova) e Zaffonato (Udine). Alcuni sono anche relatori di documenti conciliari.
L’esame puntuale delle posizioni dei singoli presuli porta a collocarli in prevalenza più vicini alla componente conservatrice, ma con articolazioni e sfumature anche significative. Va sottolineata l’azione di Gargitter che partecipa anche alle riunioni dei presuli di lingua tedesca, esercitando una significativa funzione di ponte tra i due gruppi e ponendosi, per le sue prese di posizione, su linee decisamente progressiste.
Al di là di ciò emerge in via embrionale l’avvio di un confronto collegiale costante, che la CEI guidata da Siri ancora non conosceva, e che inizia a strutturarsi durante la presidenza Urbani. Non è secondario il legame con Montini, che già durante il concilio permette diversi momenti d’incontro e di condivisione tra vescovi triveneti e lombardi.
Andando ad esaminare puntualmente gli interventi e le discussioni, emerge il significativo ruolo di sintesi e di mediazione svolto da Urbani, anche per la sua funzione alla guida dell’assemblea. Non va dimenticata la posizione di Pangrazio (Gorizia) nell’ufficio per la comunicazione del Concilio.
In alcune di queste discussioni l’attività di questi vescovi è maggiormente significativa, sia per quantità che per la qualità degli interventi.
Nella discussione sullo schema De liturgia oltre al frequente richiamo alla Mediator Dei viene posto da diversi presuli il problema della partecipazione attiva dei fedeli alla liturgia, nella prospettiva di un'eventuale riforma liturgica. Carraro è a proposito di posizioni conservatrici come anche Santin, ma da lui vengono caute aperture alle lingue moderne.
Tra coloro che intervengono sullo schema De fontibus revelationis, Urbani ha attenzioni ecumeniche, ma riafferma la centralità cattolica, mentre Gargitter e Bortignon ragionano sul rapporto tra Bibbia e tradizione. Il ruolo coordinato dei vescovi a proposito è confermato da proposte che vengono presentate sostanzialmente in maniera condivisa, quale frutto di una sintesi.
Ampia e animata la partecipazione al dibattito sullo schema De ecclesia, in particolare nella riflessione sulla nozione di popolo di Dio; qui emerge il ruolo innovativo di Gargitter che parlando di vescovi e laici affronta il tema del sacerdozio universale ed è orientato verso quelle che saranno i contenuti della Lumen gentium. Luciani pone invece l’accento sulla collegialità episcopale, affrontando un tema centrale; è significativo che uno dei vescovi più giovani intervenga su una delle questioni ecclesiologiche più rilevanti. È partecipato anche il dibattito sul diaconato permanente con posizioni critiche.
Carraro ha un ruolo di primaria importanza nell’elaborazione del documento De institutione sacerdotali che favorì probabilmente la riforma dei seminari, «ma che in realtà̀ non affrontava in profondità̀ le sfide e i problemi che i cambiamenti in atto a livello socioculturale, almeno in Occidente, stavano suscitando nel clero cattolico, contribuendo a una sua crisi che sarebbe esplosa in modo visibile negli anni immediatamente successivi» [p. 84].
Vian nota poi come il ruolo importante dell’Azione Cattolica nel Triveneto influisca sugli interventi per lo schema De apostolatu laicorum.
Significativo, in occasione del dibattito sullo schema De oecumenismo, l’intervento di Pangrazio all’assemblea conciliare del 25 novembre 1963 in cui per primo espone il tema della gerarchia delle verità della dottrina cattolica, che sarà poi ripreso nel decreto Unitatis redintegratio ed è fondamentale nella criteriologia ecumenica.
L’episcopato nazionale italiano ha delle dimensioni uniche in termini numerici, ma è ancora poco uso ad incontri nazionali. Nota Vian come la stagione conciliare porta «ad avviare un ripensamento della CEI, con l’obiettivo di renderla un’istituzione più organica ed efficace, in primis sul piano operativo» [p. 118]. L’esperienza dell’episcopato triveneto è in buona misura anticipatrice di questi indirizzi.