

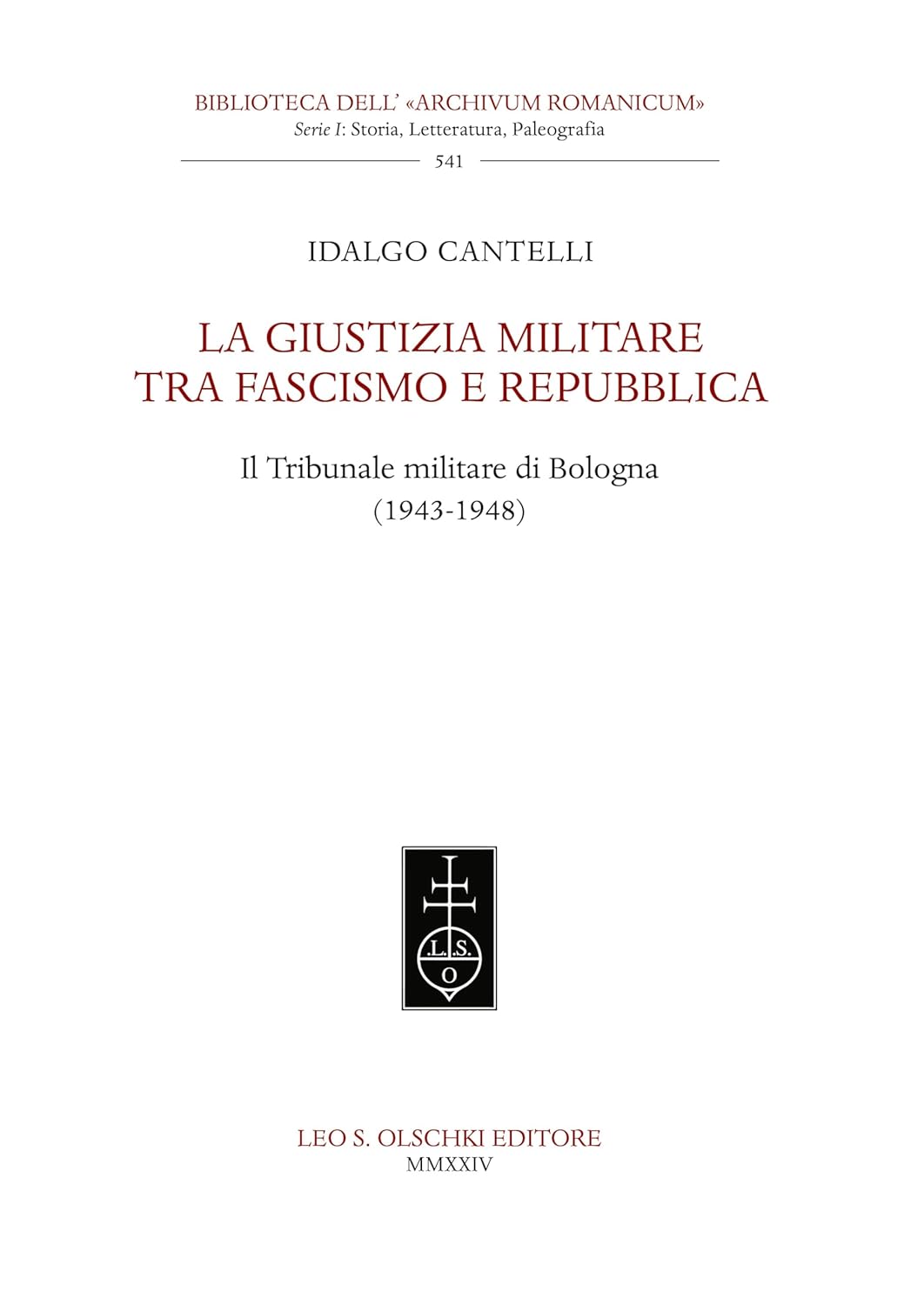
Reviewer Nicolò Da Lio - Università degli studi di Padova
CitationLa giustizia militare tra fascismo e repubblica (275 pagine) di Idalgo Cantelli colma una delle molte lacune della storiografia sulla giustizia militare nella Seconda guerra mondiale. Il volume analizza l’attività del Tribunale militare territoriale di Bologna fra 1943 e 1948, ed è organizzato in due parti. La prima, divisa in dieci capitoli (pp. 1-148), fornisce un’introduzione al ruolo della giustizia militare, compie una ricognizione storiografica, e ricostruisce il contesto giuridico e l’evoluzione legislativa dei codici militari dalla Grande Guerra alla Seconda guerra mondiale, proseguendo poi con gli effetti che la Costituzione ebbe sulla giustizia militare fino alla riforma del 1981. Le fonti archivistiche, la pubblicistica e la stampa coeva, ma anche cinema e letteratura, danno all’analisi un ampio respiro, attento al contesto culturale coevo. I capitoli successivi sono dedicati a diversi gruppi di reati (reati di assenza, che occupavano il 52% dell’attività del tribunale; contro il patrimonio, 10%; contro la disciplina militare, 3%; reati comuni, 10%; reati politici, 6,3%, poco più della metà dei quali legati al collaborazionismo)[1], approfondendo l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale delle diverse fattispecie. L’autore dimostra come la corte felsinea rifletté in parte gli orientamenti del Tribunale Supremo Militare. Per i reati di assenza dal servizio, per esempio, non sfruttò la discrezionalità offerta dalle norme, e fu relativamente severa almeno fino al 1949 (pp. 73-76). Nei reati contro la disciplina, che andavano a tutelare la sacertà della gerarchia militare, istruttorie e i dibattimenti appaiono ponderati ed equanimi, ma le condanne erano più comuni di quanto accadesse per i reati di diserzione (pp. 104-109).
La seconda parte del volume è dedicata all’analisi di 38 casi (pp. 149-244), e alla presentazione di un’appendice statistica sull’attività del Tribunale fra 1943 e 1948. Cantelli ricorda come la giustizia militare sia «una procedura complessa», «oggetto di raffinate riflessioni dottrinarie» e che, almeno per il periodo considerato, rimase al riparo dalle interferenze delle istituzioni militari e dei vertici politici (p. 1). Secondo l’autore, in questo modo i magistrati militari attuarono una «forma di ribellione allo stato di subordinazione» sancito dall’ordinamento giudiziario militare (p. 9). Rispetto al periodo immediatamente precedente, in un’Italia travagliata dal deterioramento dell’ordine pubblico, dalle cattive condizioni economiche, dal diffondersi della prostituzione, dal difficile reinserimento dei reduci (pp. 17-22), l’attività del Tribunale (che subì un ricambio quasi completo dei giudici) presenta una minor attenzione per i civili (p. 10), e una generale tendenza assolutoria, in particolare per i reati di collaborazionismo (pp. 10 12). I tribunali militari ebbero giurisdizione su questi reati dal 1944, anche se rapidamente essa fu ridotta ai soli casi nei quali fosse necessaria una valutazione tecnico militare dei fatti (p. 122). Il tribunale bolognese contestò 361 reati di collaborazionismo: poco più del 3% di quelli trattati fra 1943 e 1948 (p. 246). A essere processati furono quasi esclusivamente uomini (350, 9 le donne, 2 autori ignoti), e quasi tutti furono assolti (350, 8 le condanne, 3 le rimissioni ad altro tribunale) (p. 252): una tendenza assolutoria che si manifestò in anticipo all’emanazione dell'amnistia del 1946 e che, secondo l’autore, potrebbe essere spiegata con il timore che la sanzione di numerosi collaborazionisti avrebbe potuto minare il prestigio delle forze armate (p. 132). Cantelli evidenzia anche la riluttanza di molti giuristi a riconoscere la validità dei decreti che colpivano il collaborazionismo anche retroattivamente (nonostante il codice militare già prevedesse reati simili), e adottavano la presunzione di colpevolezza per chi avesse avuto cariche rilevanti nella Repubblica Sociale (pp. 26-27). La possibilità di punire le violenze squadriste fu invece frustrata dalla difficoltà di circostanziare le accuse (p. 126). Altra attività fondamentale fu la cassazione e la dichiarazione di inesistenza delle sentenze politiche emanate dal tribunale militare saloino di Bologna: una deroga al principio dell’intangibilità del giudicato giustificata dall’illegittimità dello stato fascista repubblicano (pp. 134-142).
L’autore ricorda come le leggi militari, riformate nel 1941, furono parte delle diverse riforme legislative compiute dal fascismo in senso statolatrico (p. 32), dove il regime si orientò principalmente verso la complementarietà e l’estensione della giurisdizione militare anche a soggetti estranei alle forze armate (pp. 32-53). L’armistizio, il periodo luogotenenziale, e il referendum istituzionale furono momenti di passaggio fondamentali anche per la giustizia militare. Alcuni dei principi introdotti nella Carta comparvero già nella legislazione transitoria del 1946. Ad avere particolare effetto sulla giurisdizione militare furono però gli articoli 25 e 103 della Costituzione. Il secondo, che limitava la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace ai soli appartenenti alle forze armate, lasciava spazio a interpretazioni, come successivamente dimostrato dal caso Renzi-Aristarco. Ma già nel 1948 questa ambiguità vide l’avvio di un dibattito fra giuristi e magistrati (militari e ordinari), e fu applicato in modo ondivago dalla Cassazione (pp. 143-148).
I primi capitoli del lavoro di Cantelli sono un’ottima sintesi dell’evoluzione del diritto penale militare italiano e del suo legame con il diritto comune nel regime, nella transizione, e agli albori della Repubblica, rappresentando un’ottima lettura per chiunque si avvicini allo studio della giustizia militare. I capitoli successivi e l’ampio apparato documentale sono particolarmente interessanti per chi si occupa della giustizia di transizione, e permettono di approfondire aspetti della storia giuridica, sociale e politica dell’Italia del 1943-1948 attraverso la lente della giustizia militare. Per questo, il volume è un utile passo avanti nello studio della giustizia castrense.
[1] Rielaborazione della tabella 1 a p. 246.