

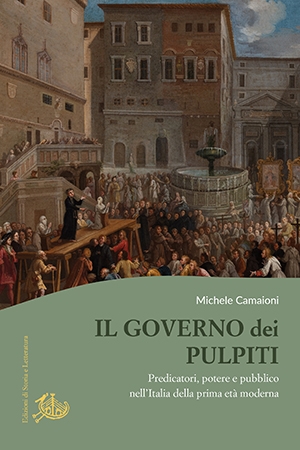
Reviewer Flavia Tudini - Roma Tre
CitationNel 2024 più volte papa Francesco ha esortato i sacerdoti a tenere omelie brevi – «la predica dev'essere un'idea, un affetto e una proposta di azione. E non andare mai oltre i dieci minuti»[1] – suscitando l’applauso dei fedeli in piazza san Pietro. Ben altra approvazione, invece, suscitava la predicazione nella prima età moderna, i cui sermoni soprattutto nei periodi di Quaresima e Avvento potevano durare anche diverse ore. I predicatori più abili degli ordini mendicanti e della Compagnia di Gesù erano vere e proprie star itineranti, «professionisti della parola» (p. X) che avevano la capacità di creare uno spettacolo nelle piazze e nei pulpiti più ambiti. Le prediche durante la Quaresima e l’Avvento diventavano quindi vere e proprie perfomance, che vedevano coinvolte le autorità cittadine nella loro organizzazione, le autorità ecclesiastiche nel loro controllo e il popolo a cui erano dirette in cui suscitavano emozioni e fervore religioso.
L’interessante libro di Michele Camaioni analizza la predicazione in Italia tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Seicento attraverso un’innovativa lettura di storia sociale, culturale e materiale – andando quindi oltre la classica analisi di storia religiosa e di storia delle idee – e presentando il forte legame tra la predicazione e la comunicazione pubblica della prima età moderna. Per raggiungere l’obiettivo, accanto all’importante contesto storiografico che emerge nell’apparato critico, l’Autore applica metodi in parte inediti per studiare tipologie di fonti ben conosciute, come ad esempio i sermoni, nella loro dimensione orale all’interno della sfera pubblica e definendone il carattere intermediale.
Partendo dall’osservazione di un quadro, probabilmente seicentesco e di attribuzione anonima, conservato presso il Museo del Capitolo della Cattedrale di Perugia, Camaioni accompagna il lettore attraverso dodici capitoli tematici dedicati alla dimensione politico-sociale della predicazione nell’Italia dell’età moderna (p. XXV). Nei primi due capitoli viene presentata la figura del predicatore, le sue caratteristiche e la percezione che ne aveva la popolazione a cui predicavano, sottolineandone la funzione sociale e religiosa. Attraverso figure esemplari, come Giacinto da Casale e Francesco da Montepulciano, si esplorano i diversi tipi di predicazione da quella «apostolica» di carattere profetico a quella penitenziale fino all’invettiva di carattere politico di Savonarola. Emerge dunque l’importante funzione sociale della predicazione, che permette di plasmare e trasformare gli individui e la società (p. 13).
Una volta presentati i protagonisti, nei capitoli 3-5 l’attenzione dell’Autore si sposta verso gli aspetti della predicazione più legati alla performance, alla sua ricezione e alla possibile contestazione e repressione di cui poteva essere oggetto. Come riporta l’Autore, «ogni predica presentava un certo grado di imprevedibilità» (p. 33), legati da un lato all’attorialità del predicatore (il tono di voce, uno sbadiglio, una défaillance potevano comportare un esito negativo della predicazione e il suo fallimento) e dall’altro al messaggio che veniva trasmesso. I contenuti della predicazione non dovevano far sorgere sospetti di simpatie luterane o che potessero veicolare messaggi politici ‘pericolosi‘ per le autorità cittadine che si erano prodigate nell’organizzazione dell’evento data la partecipazione di un ampio pubblico. La predicazione era quindi soggetta a numerose regole sia durante il suo svolgimento che nella sua fase di pianificazione, autorizzazione e organizzazione. Da un lato vi erano le regole previste dagli ordini religiosi: il predicatore doveva possedere tutte le facoltà e i requisiti necessari per svolgere la predicazione e doveva obbedienza alle gerarchie dell’ordine che decidevano le sue destinazioni. Dall’altro, vigevano regole e disposizioni definite dalle autorità diocesane, che avevano facoltà di concedere ai predicatori l’autorizzazione di predicare all’interno delle diocesi dopo un colloquio o un esame preliminare con il predicatore, riaffermando una loro prerogativa di governo pastorale. Al controllo da parte dei vescovi, i predicatori dovevano difendere le proprie prerogative dal sant’Uffizio, che poteva intervenire sul contenuto delle prediche esaminandone l’ortodossia.
Il capitolo 6 affronta la questione dell’itineranza dei predicatori, che potevano seguire percorsi variabili, intraprendendo anche lunghi viaggi tra una città e l’altra dell’Italia. Ciò permetteva la circolazione di idee, notizie ed oggetti grazie alla rete dei religiosi e al ruolo di mediatori culturali che potevano svolgere. I luoghi della predicazione permettevano, poi, ai singoli predicatori di ‘specializzarsi‘ nei confronti di determinate tipologie di pubblico, come quello della predicazione rivolta agli ebrei. Nei capitoli 7-9, poi, vengono presentati gli aspetti materiali del «mestiere della parola», come le difficoltà di affrontare e sostenere molte ore ininterrotte di predicazione, la necessità di un regime alimentare specifico per i predicatori, la preparazione dei sermoni e lo studio di modelli per poter affrontare al meglio sia la redazione del sermone che la presenza scenica di fronte al pubblico.
Negli ultimi capitoli, 10-12, viene infine presentata la modalità di organizzazione e il finanziamento dei grandi cicli di predicazione da parte delle autorità cittadine. La presenza di predicatori famosi, la richiesta che tornassero per più anni consecutivi, le negoziazioni delle autorità con i cardinali protettori, gli equilibri di potere che potevano crearsi e le modalità di finanziamento permettono di rivolgere lo sguardo al significato politico che assumeva la predicazione all’interno degli spazi urbani nella prima età moderna.
Concludendo, il libro di Michele Camaioni non è solamente uno studio sulla predicazione nell’Italia di un lungo Cinquecento, è una ricchissima ricerca che permette di aprire lo studio della predicazione a nuove prospettive e metodologie di indagine, permettendo un dialogo con la materialità legata alla predicazione (sermoni a stampa, manoscritti, libri), al viaggio e alle sue difficoltà, all’alimentazione e alla sua disciplina all’interno degli ordini religiosi, alla circolazione di idee e al difficile rapporto tra predicatori, le autorità diocesane e gli spazi urbani. La ricerca apre quindi a nuove indagini sulla prospettiva sociale e comunicativa della predicazione in età moderna.
[1] https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2024/12/04/il-papa-no-alle-omelie-lunghe-massimo-10-minuti_77b275f3-5b92-4275-b650-9da9c9353a13.html, «Ansa», 4 dicembre 2024, ultima consultazione 1 luglio 2025.