

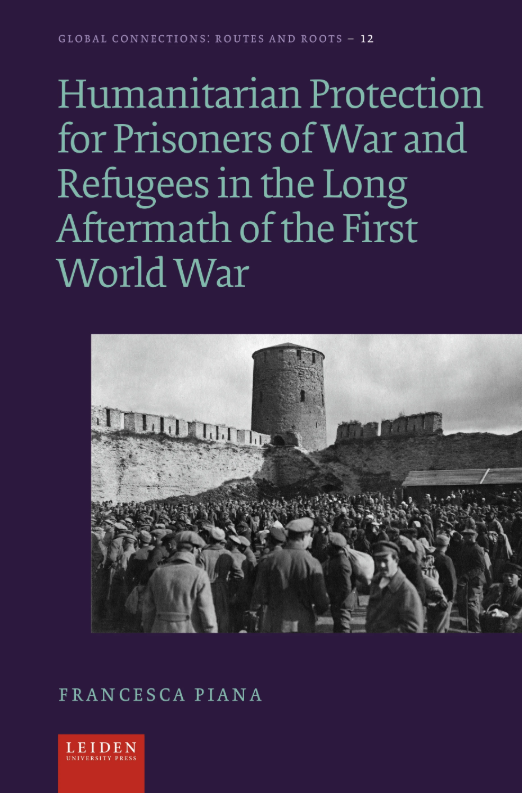
Reviewer Mara Dissegna - FBK ISR
CitationQuesto lavoro di Francesca Piana si inserisce nella tradizione di studi legati ai temi dell’umanitarismo e della storia delle relazioni internazionali che si sviluppano in particolare negli ambienti dei centri di ricerca di Ginevra (Davide Rodogno) e di Mainz (Johannes Paulmann). Altro settore che concorre a creare le basi teoriche del volume è rappresentato dagli studi sul tema della storia dei rifugiati (Peter Gartrell, Michael Marrus).
Il lavoro parte dalla considerazione che la firma dei trattati di pace alla fine della Prima guerra mondiale rappresenta la fine ufficiale delle ostilità, ma non comporta per tutti l’inizio di un periodo di pace. Si apre invece un nuovo momento caratterizzato dal ritorno e dalla ricerca di quella che viene percepita come ‘casaʼ. La caduta degli imperi, lo spostamento dei confini, il nuovo ordine internazionale portano con sé la creazione di una nuova categoria di persone che vengono identificate come rifugiati. La guerra, quindi, non vede solo il ritorno dei prigionieri di guerra ma anche lo spostamento di masse di civili che cercano una home che hanno perduto a causa del nuovo assetto politico e sociale. A contribuire a questa situazione di equilibrio in costante mutamento si inserisce un nuovo paradigma statale che vede l’introduzione dell’uso di passaporti o documenti che attestino l’appartenenza di un soggetto a uno stato e allo stesso tempo lo sviluppo di legislazioni nazionali volte a limitare il flusso in entrata di stranieri.
In questo contesto l’autrice propone un’analisi, estremamente interessante e originale, che copre un periodo che va dal 1918 al 1930. Il lavoro, partendo da un’approfondita analisi della letteratura scientifica, mira a ricostruire, sulla base di un importante lavoro di analisi della documentazione d’archivio, l’azione principalmente di tre attori internazionali che operano in diversi contesti geografici e diplomatici: il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Società delle Nazioni e l’Organizzazione internazionale del lavoro. In particolare, va a investigare le motivazioni che sono alla base dell’intervento di queste organizzazioni e la loro strategia di azione (non si può parlare di politica vera e propria) verso i rifugiati, in particolare nelle aree dell’Europa orientale e di parte dell’ex impero ottomano.
Appare interessante il lavoro svolto attraverso la documentazione archivistica per analizzare l’intrecciarsi delle attività delle tre organizzazioni citate che influenzano e vengono influenzate dagli attori circostanti e al contempo si influenzano e collaborano fra loro. Le tre organizzazioni hanno un mandato molto diverso ma, nel corso degli anni e rispetto ai contesti qui considerati, sviluppano delle azioni che possono essere comuni, parallele, sussidiarie fra loro, non solo a livello diplomatico ma anche nell’azione sul campo.
L’autrice, attraverso la documentazione, partendo da un’analisi prettamente diplomatica e delle relazioni internazionali, arriva a esempi di microstoria che descrivono la quotidianità dei diversi soggetti coinvolti sul campo. In alcune parti del volume si ha quasi la sensazione di poter vedere, come in una pellicola d’archivio, la descrizione dei vari personaggi che partecipano alla realtà di un campo profughi, che siano essi delegati di una delle organizzazioni coinvolte, parte dello staff locale, vittime. L’autrice propone parallelamente anche una lettura del lavoro umanitario secondo una lettura gender, che in alcuni momenti arriva quasi a utilizzare delle categorie del presente per analizzare il passato, ma che nel complesso sollecita importanti riflessioni.
Dopo una densa introduzione che illustra le basi teoriche e la metodologia applicata, il volume inizia presentando i principali attori umanitari e la questione del rientro dei prigionieri di guerra in particolare nell’area dell’Europa orientale. Come caso di studio viene presentata Narva, una località al confine fra Russia ed Estonia dove, accanto all’antico forte della città, venne costruito un campo di scambio di prigionieri. L’analisi della quotidianità di questa realtà viene utilizzata per descrivere in primis la quotidianità di chiunque passasse per questo campo (soccorritori e soccorsi) ma anche per illustrare, attraverso le ricadute, come le decisioni prese nei quartier generali delle organizzazioni internazionali a Ginevra incontrassero la realtà di queste persone in viaggio verso la pace.
Proseguendo nella lettura ci si sposta a Costantinopoli. Qui troviamo non solo i prigionieri di guerra ma soprattutto rifugiati che arrivano nella città turca dal mondo dell’Europa orientale e sperano in un futuro migliore che sia verso il Medio Oriente o verso altri territori. Viene considerata l’azione della diplomazia umanitaria e delle influenze della politica degli stati nella gestione del contesto.
Restando sempre nell’area dell’ex-impero ottomano, l’ultima parte del volume si occupa delle vittime del genocidio armeno e della gestione dei sopravvissuti e rifugiati di questo dramma che si consuma negli anni presi in considerazione. La descrizione della quotidianità, tratta dagli archivi, mostra come questa parte del mondo fosse diventata in breve tempo un’area dove si erano concentrate necessità umanitarie, di protezione, ma anche un luogo da cui era molto difficile riuscire a uscire, come se le potenze occidentali cercassero di tenere lungo i bordi dell’Europa, i confini dell’Occidente, un insieme di persone considerate unwanted, per motivi di religione, di nazionalità, di etnia. La riflessione che accompagna questa ricerca porta a delle riflessioni che non toccano soltanto il passato ma che purtroppo ben si prestano, con le necessarie distinzioni, a descrivere ancora la nostra realtà di oggi.
La trattazione si chiude con una speranza: «Even if I cannot possibly reconstruct every single path, I still hope to have done justice to so much suffering, courage, and strength».