

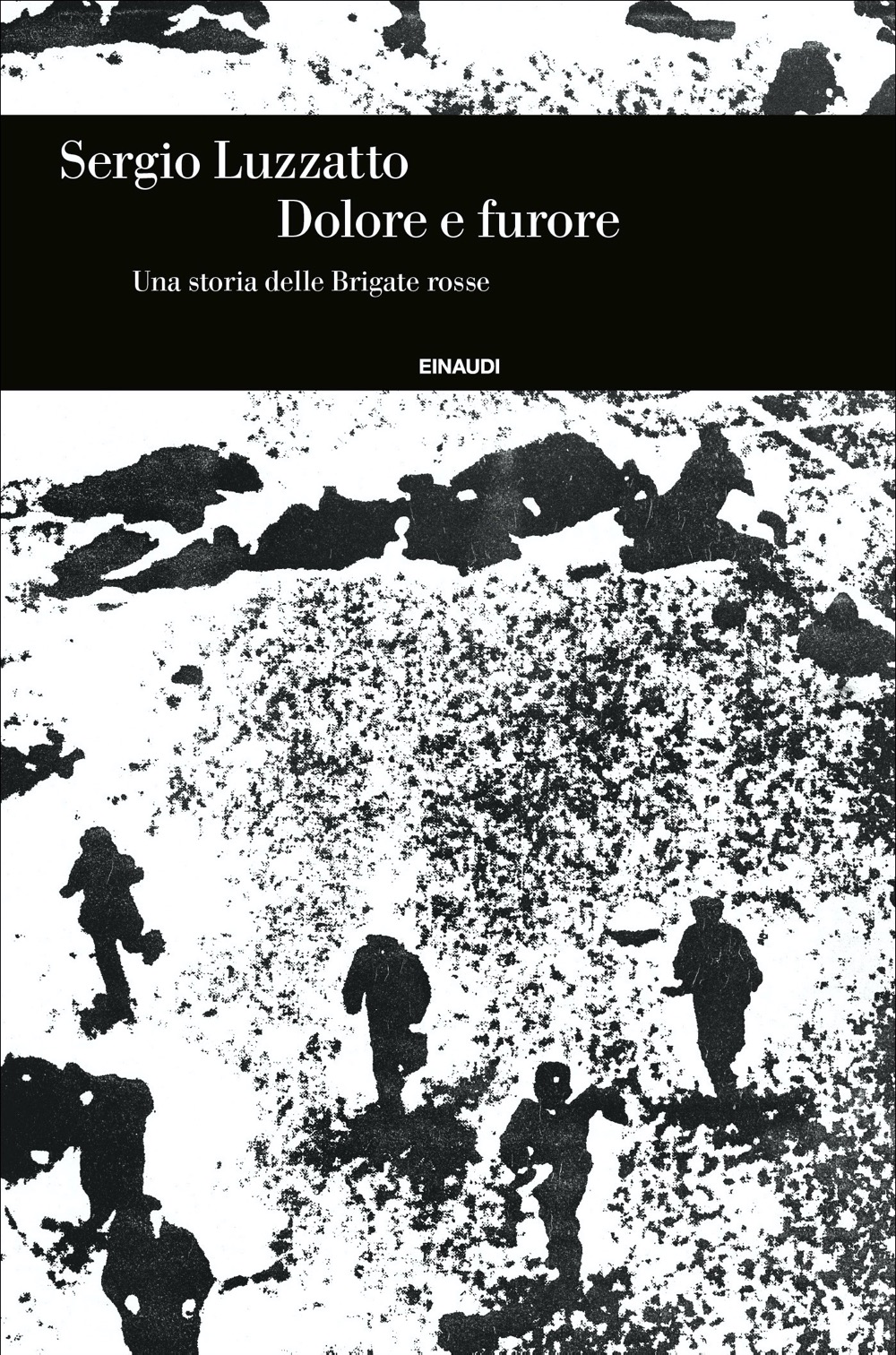
Reviewer Davide Serafino
CitationIl volume Dolore e furore. Una storia delle Brigate rosse di Sergio Luzzatto rappresenta, per certi aspetti, il prosieguo di un lavoro di ricerca iniziato con Giù in mezzo agli uomini. Vita e morte di Guido Rossa, incentrato sulla figura dell’operaio ucciso dalle Brigate rosse nel 1979. In Dolore e furore Luzzatto si concentra sulla figura di quello che possiamo definire il 'contraltare' di Rossa, cioè il brigatista che lo aveva ucciso, Riccardo Dura. La parabola umana ed esistenziale di Dura funge, infatti, da vero e proprio «fil rouge biografico» del volume (p. XXIII) e, attraverso di lui e le persone che gli sono ruotate intorno, composte in una sorta di 'ritratto di gruppo', Dolore e furore ripercorre le vicende della colonna genovese delle Br, ma offre anche una rappresentazione vivida di una città dolente, eternamente sospesa, come scrisse Giorgio Caproni, tra «cattedrale» e «bordello». La scelta, quasi prosopografica, di costruire una galleria ragionata di volti e figure, aiuta a tratteggiare il milieu in cui si era mosso il protagonista e, più in generale, un ritratto sociologico e culturale di Genova, eccentrica anticipatrice di alcuni passaggi chiave del fenomeno armato. Il volume, inoltre, ha il merito di sottrarre Dura a quella leggenda nera – complice la sua morte precoce – che lo aveva trasformato in un compendio di fanatismo e ferocia: «del fango di poi son piene le fosse» (p. 551) scrive Luzzatto.
La ricerca è importante non soltanto perché inquadra il fenomeno della lotta armata all’interno della storia del Paese, ma anche per la quantità e la qualità delle fonti utilizzate dall’autore. Inoltre, il volume ha il pregio di riuscire a combinare felicemente lo scavo archivistico – Luzzatto è un vero e proprio 'scovatore' di fonti – con uno stile narrativo coinvolgente e capace di dare alla luce un volume appassionante e appassionato da cui affiora la 'bellezza' del fare ricerca storica e la passione ad essa necessaria.
Dal punto di vista metodologico, l’autore integra la ricostruzione delle vicende della colonna genovese, soprattutto dove le fonti sono meno eloquenti, con un esercizio, quasi sempre equilibrato, di immaginazione che si sforza di provare a ipotizzare come avrebbero potuto ragionare o comportarsi, in un contesto storico-sociale ben determinato, i protagonisti delle vicende.
Il volume appare, infatti, debitore di un approccio empirico tipico dell’antropologia e della ricerca sul campo. La narrazione/ricostruzione degli accadimenti e del contesto umano, psicologico e antropologico, prima che sociale e politico, nel quale i fatti si sono svolti, è arricchita dal racconto concreto del lavoro di ricerca, in cui l’autore esplicita impressioni ed emozioni. Se da un lato tale impostazione è stata vista come rappresentativa della storiografia dell’età neoliberale[1], dall’altro lato “disvela” il mestiere dello storico – costellato di dubbi e ipotesi più che di apodittiche 'verità' –, che viene colto nel suo dispiegarsi.
Il volume si può dividere idealmente in due parti. La prima, più efficace, si concentra sulla ricostruzione del contesto genovese a partire dagli anni ’60, adottando una periodizzazione che consente di collocare la lotta armata all’interno della storia del Paese e di vederla non solamente come il prodotto di fervide elucubrazioni rivoluzionarie, ma come un fenomeno sociale e politico che trova la sua ragione d’essere, senza sfociare nel rigido determinismo, nell’assetto politico bloccato del dopoguerra, nelle enormi trasformazioni innescate dal miracolo economico – Luzzatto scrive di «sradicamento originario» e «spaesamento» (p. XXIV) – e dalla «fiumana del progresso» che scremò i «sommersi» dai «salvati», gli «apocalittici» dagli «integrati» o, più prosaicamente, chi riuscì a salire sull’ascensore sociale e chi, quell’ascensore, lo aveva trovato occupato: «periferia umane», questi ultimi, per citare le efficaci parole di Beppe Battaglia, ex militante del Gruppo 22 ottobre (p. 126).
La seconda parte, dedicata alle Br viste dalla prospettiva genovese, mostra qualche incertezza e criticità in più rispetto alla prima proprio negli aspetti più originali del volume. In taluni frangenti, infatti, il felice equilibrio tra narrazione e ricostruzione storiografica pare sbilanciarsi in favore della prima. Ad esempio, quando l’autore indugia troppo sull’immagine, tanto evocativa quanto problematica, dei «cognati rossi» Enrico Fenzi e Giovanni Senzani, entrambi docenti universitari, e, più in generale, sul ruolo degli intellettuali nella storia della lotta armata. Se alcuni intellettuali genovesi rappresentarono un punto di riferimento per la nascente colonna e agevolarono i contatti tra alcuni militanti e le Br, appare troppo perentorio sostenere che la colonna genovese sia nata in via Balbi, sede delle facoltà umanistiche dell’università di Genova. Quando Moretti e Micaletto arrivarono a Genova, inoltre, non lavorarono esclusivamente «con un paio di professori e chirurghi» (p. XXXIII) o con il gruppo di tendenze anarchiche guidato da Faina che stazionava in via Balbi, ma anche con proletari – si pensi agli operai dell’Ansaldo vicini alla rivista «Contro il padrone» che aveva appoggiato, da un punto di vista operaio, il sequestro Sossi –, portuali ed ex militanti di Lotta continua[2].
Pur senza negare l’importanza che alcuni intellettuali ebbero nella storia delle Br, la matrice originaria e la composizione del gruppo genovese, al di là della sua scarsa penetrazione nelle fabbriche, più che intellettuale fu sensu lato proletaria[3]. Il ruolo degli intellettuali, al di là della fascinazione narrativa, andrebbe dunque ridimensionato. L’autore conviene, in termini generali, con Rossana Rossanda sull’improbabilità che siano stati dei professori a formare i gruppi armati di sinistra, ma per quanto riguarda lo specifico genovese sostiene che «intorno a un chirurgo come Sergio Adamoli, a uno storico come Gianfranco Faina, a un filologo come Enrico Fenzi, le parole sono diventate pietre» (p. XLIII). Luzzatto sposa così l’interpretazione dell’origine storica del terrorismo a Genova che diede all’epoca il generale Dalla Chiesa, il quale sosteneva come esso non fosse il frutto della penetrazione della propaganda brigatista presso le grandi fabbriche, ma della «semina incessante di alcuni idéologues dell’università o dell’ospedale – Gianfranco Faina, Enrico Fenzi, Sergio Adamoli – capaci di convertire alla lotta armata un manipolo di studenti fuori corso, di cani sciolti del movimento, gli operai delle 150 ore, e di presentarli bell’e pronti a due abili dirigenti rivoluzionari venuti da fuori» (p. 544). Tuttavia, il fatto che Fenzi fosse un importante intellettuale non significa affatto che sia stato anche un ideologo – il progetto politico delle Br peraltro risale ad alcuni anni prima del suo avvicinamento al gruppo – o un indottrinatore (p. 352).
Non vi è dubbio che i discorsi, la retorica e l’incessante attività politica di un personaggio come Faina abbiano contribuito a creare una koinè culturale in cui la lotta armata divenne qualcosa di concretamente possibile. Sul piano materiale, però, Faina contribuì alla fondazione della colonna nella misura in cui mise a disposizione di Moretti una rete di contatti e rimase nelle costituende Br pochi mesi. Fenzi sarebbe rimasto un gregario a vita se alcune contingenze non gli avessero ritagliato, più che il ruolo di dirigente come lo definisce l’autore (p. XVIII), quello di improbabile spalla di Moretti in alcune riunioni della Direzione Strategica. Il chirurgo Adamoli fornì un supporto logistico alle Br, le aiutò a entrare in contatto con il mondo ospedaliero e mise a disposizione le proprie conoscenze per progettare un ospedaletto da campo e curare i militanti feriti (p. 377), ma non ebbe mai alcun ruolo direttivo e operativo. Un’ultima figura emerge dal volume, quella del criminologo e docente universitario Senzani che fu indubbiamente un dirigente delle Br, ma solamente in una fase tarda della vita della formazione, a meno che non si voglia retrodatare il suo ingresso nel gruppo, come suggerisce l’autore, precisando però come manchino «evidenze documentarie d’epoca» (pp. 305-306). Il fatto che Senzani possa aver fatto parte del Comitato rivoluzionario toscano – una struttura secondaria delle Br – o che possa aver avuto alcuni contatti diretti con dirigenti delle Br nel periodo antecedente alla primavera del 1978, non autorizza a collocarlo ai vertici del gruppo, addirittura nella duplice veste di capo delle Br e di consulente delle istituzioni, come sostengono alcuni autori inclini alla 'dietrologia'[4] su cui pare appoggiarsi Luzzatto. Al di là di questo, il volume appare prezioso sia per l’approccio e il metodo – la prima parte del volume è anzi magistrale in tal senso –, sia per la libertà e il coraggio intellettuale – in particolare in merito alla strage di via Fracchia – nell’affrontare il fenomeno armato degli anni ’70 sottraendolo a facili semplificazioni e rendendo conto delle complesse ramificazioni che ebbe.
[1] E. Traverso, La tirannide dell’io. Scrivere il passato in prima persona, Roma-Bari, Laterza, 2022.
[2] Mi permetto di rimandare a D. Serafino, La lotta armata a Genova. Dal Gruppo 22 ottobre alle Brigate rosse, Pisa, Pacini, 2016.
[3] In riferimento a questo aspetto, per quanto riguarda le Br nel loro complesso, si veda M. Clementi, Storia delle Brigate Rosse, Roma, Odradek, 2007 e M.A. Albanese, Tondini di ferro e bossoli di piombo. Una storia sociale delle Brigate Rosse, Pisa, Pacini, 2020.
[4] Si veda, ad esempio, G. De Lutiis, Il golpe di Via Fani. Protezioni occulte e connivenze internazionali dietro il delitto Moro, Milano, Sperling & Kupfer, 2007, pp. 149-150.