

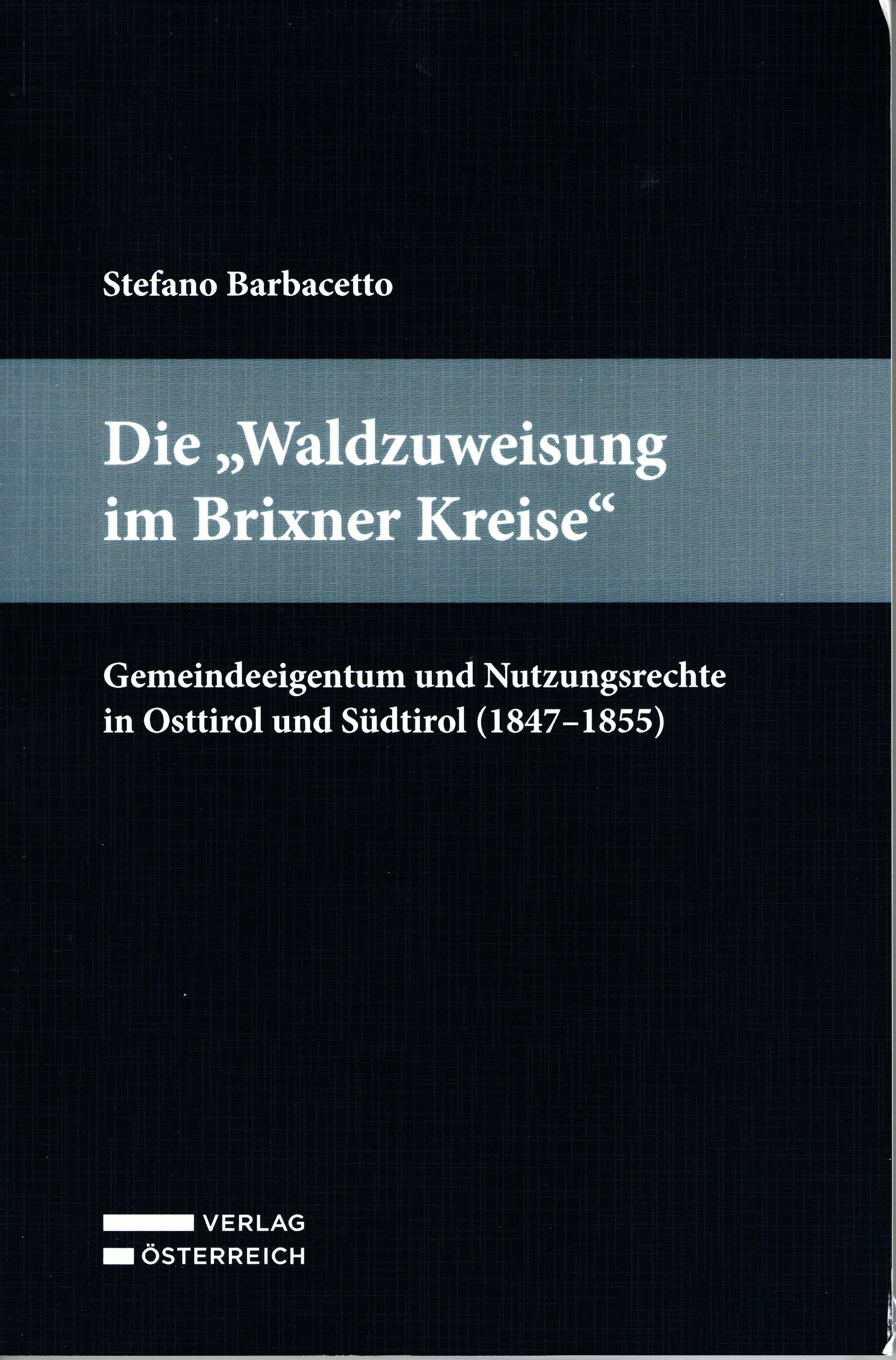
Reviewer Mark Bertogliati - Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
CitationSe il bosco dell’Ottocento poteva apparire più spoglio rispetto a quello odierno[1], la selva giuridica di diritti d’uso, vincoli e forme di possesso degli spazi forestali doveva invece risultare assai intricata. Ad alimentare la complessità e a innescare dinamiche contraddittorie in tema di godimento dei boschi contribuiva non poco il principio di sovranità sulle foreste, affermatosi già nel Medioevo nel Tirolo per contrastare i disboscamenti e sostenere le attività legate soprattutto alla metallurgia e all’industria del sale sottoponendo vaste aree all’amministrazione dei sovrani e in seguito dell’Erario. La regalia forestale (Forsthoheitsrecht) si applicava però anche a boschi divisi o indivisi di minore interesse strategico, ma di accesso più diretto alle comunità tramite i cosiddetti «percepimenti di legna per grazia sovrana», investiture o servitù a favore di enti collettivi o particolari.
Il nodo relativo alla proprietà dei boschi venne sciolto, almeno nelle intenzioni, con la risoluzione di Ferdinando I d’Austria del 6 febbraio 1847 (Aller höchste Entschließung betreffend die Regulirung der Tiroler Forstangelegenheiten). L’attesa riforma – dopo decenni di controversie – fu partorita in anni difficili con l’intento di limitare le vertenze attorno ai diritti d’uso e al possesso dei boschi, consolidare dal profilo patrimoniale i comuni politici che si stavano nel frattempo affermando come soggetti giuridici e migliorare l’amministrazione forestale. Con la riforma si attribuirono oltre due terzi della superficie boschiva ai comuni e, in misura minore, a privati, conservandone circa un terzo a favore dello Stato. Nel Tirolo orientale e meridionale l’attuazione delle assegnazioni dei boschi (Waldzuweisungen) avvenne a tappe: dapprima (1847-1849) tramite i tribunali distrettuali, poi (1853-1854) con una commissione incaricata in base a precise istruzioni. Nell’area corrispondente al circolo di Bressanone entro il 1855 circa 200 enti locali (ri)acquistarono appezzamenti boschivi, in gran parte nella forma di ‘donazioni imperialiʼ e ciò, in generale, senza precludere i diritti e le servitù preesistenti. In Trentino (Tirolo italiano o Welschtirol), invece, non si ritenne necessaria l’operazione, considerando storicamente consolidata l’autonomia delle comunità locali nella gestione forestale.
Partendo da queste premesse e seguendo le attività dei funzionari incaricati delle Waldzuweisungen, l’Autore del saggio analizza il contesto e gli esiti del processo di assegnazione dei boschi offrendo, in chiave comparativa con altri territori della Monarchia asburgica, un’interessante fotografia delle diverse situazioni possessorie riscontrate nelle regioni in esame: foreste erariali riservate per la produzione di legno di fabbrica e combustibile per le attività strategiche (ma non di rado accessibili anche ad altri attori); boschi indivisi gestiti a livello comunitario; boschi suddivisi in parcelle assegnate a privati; boschi di pertinenza di singoli privati; boschi ‘mistiʼ con vincoli a favore di particolari e specifici appezzamenti titolari di diritti di servitù forestale o riservati a diverse comunità per usi stratificati[2].
È interessante rilevare come nello stesso periodo in cui si concretizzava questa ampia operazione – in buona misura a beneficio delle comunità locali e senza intaccare gli usi comunitari e i vincoli precedenti – in varie parti d’Europa i beni collettivi subivano l’assedio delle autorità centrali e gli ‘attacchi liberaliʼ dei fautori di un’economia forestale regolata e di una concezione privatistica della proprietà che tra secondo Ottocento e inizio Novecento condussero, soprattutto in Francia e in area italiana, a esiti diametralmente opposti[3].
L’analisi sulle forme di possesso e uso dei boschi è affiancata da un’indagine sui soggetti giuridici beneficiari delle assegnazioni: i comuni (politici) e le frazioni di comuni riconosciute, a determinate condizioni, come entità a sé stanti. La pubblicazione, frutto di un’approfondita ricerca e interpretazione critica delle fonti, offre un valido contributo alla comprensione dei processi storici di formazione dei comuni nell’area austriaca, soffermandosi sulla definizione giuridica dei comuni e sulle dinamiche di acquisto e trasferimento dei diritti di godimento dei beni comunali, aspetti che non riguardano solo il Tirolo, benché siano evidenti le particolarità di questo caso nel contesto alpino ed europeo. Gli spunti sono molto attuali, non da ultimo in relazione ai controversi trasferimenti di numerose proprietà comunali alle comunità agrarie (Agrargemeinschaften) concretizzatisi nella seconda metà del Novecento sulla scorta di rivendicazioni storiche, culminate nella sentenza della Corte costituzionale del 2008 che ha ravvivato il cosiddetto Tiroler Agrarstreit: un vero e proprio terremoto politico e giuridico che continua a scuotere le cronache e l’opinione pubblica austriache, alimentando un ampio dibattito sulle funzioni, sul valore intrinseco e sulla distribuzione della proprietà in un contesto di mutamenti a livello socio-economico[4].
[1] In questo senso cfr. L. Blanco, Per una storia amministrativa e sociale dei boschi. Introduzione a M. Cerato, Le radici dei boschi. La questione forestale nel Tirolo italiano durante l’Ottocento, Pergine Valsugana, Publistampa, 2019, p. 14.
[2] La carta allegata alla pubblicazione e accessibile in rete come contenuto extra si rivela un contributo prezioso sia per documentare gli esiti della riforma, sia per individuare le forme di possesso dei boschi vigenti a metà Ottocento nell’area esaminata.
[3] M.-D. Demélas - N. Vivier (edd), Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914). Europe occidentale et Amérique latine, Rennes Cedex, Presses Universitaires Rennes, 2003, p. 337; G. Alfani - R. Rao, La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 10.
[4] A questo proposito si veda G. Siegl, Die Entstehung der Agrargemeinschaften in Tirol unter besonderer Berücksichtigung der Gemeindegutsagrargemeinschaften. Zur historischen Dimension eines aktuellen Problems, in M. Cerman - E. Landsteiner (edd), Zwischen Land und Stadt. Wirtschaftsverflechtungen von ländlichen und städtischen Räumen in Europa 1300-1600, Innsbruck - Wien - Bozen, Studien Verlag, 2009, pp. 218-240.