

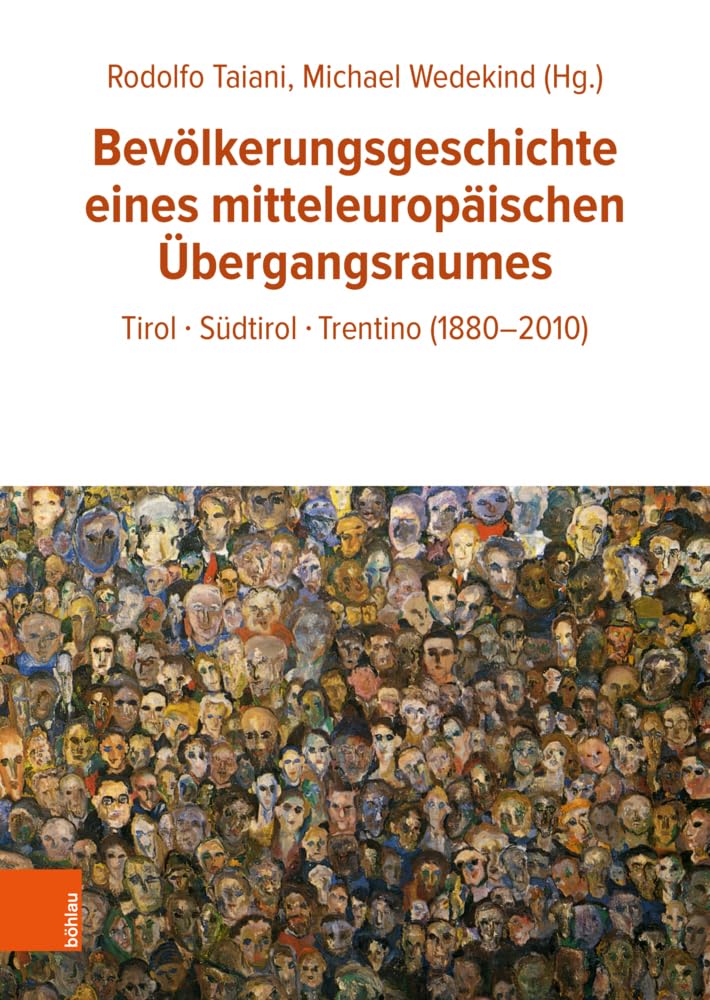
Reviewer Gustavo Corni - già Università di Trento
CitationUna prima constatazione: si tratta di un’opera imponente. Quasi settecento pagine, trenta capitoli, una quarantina di autori, italiani, austriaci, tedeschi e oltre, una bibliografia che copre poco meno di cento pagine di studi citati nel testo. Un lavoro pionieristico, unico, interdisciplinare. I curatori, infatti, mettono in evidenza di avere voluto realizzare un’opera a più voci di storia della popolazione, coinvolgendo quindi elementi che andassero molto aldilà della demografia storica in senso stretto, focalizzando l’attenzione sugli intrecci fra evolversi della popolazione e politiche di stato (o, nel caso, delle provincie). Per usare le parole dei curatori, si prendono in esame «una molteplicità di fattori ecologici, economici, socioculturali, politico-istituzionali, scientifici, tecnologici, medico-sanitari, relativi all’alimentazione, alle ideologie e alle religioni» (p. 11).
L’opera è uscita in edizione originale nel 2021 e rientra all’interno di un progetto ampio quanto ambizioso, avviato dalla Fondazione Museo storico del Trentino già alla fine degli anni ’90 e frutto in special modo delle sollecitazioni di Christoph von Hartungen, storico bolzanino scomparso da qualche anno. L’intento era quello di definire per la prima volta i quadri storici di una regione che ha più volte cambiato confini statuali di appartenenza: nel 1918 le due parti a Sud del confine del Brennero sono state acquisite all’Italia, a cui sono tornate dopo il 1945; ma non possiamo dimenticare che nel periodo finale della Seconda guerra mondiale (1943-1945) il Reich hitleriano aveva accarezzato l’idea di inglobare le provincie di Bolzano e Trento nuovamente entro i confini del Reich germanico. Un territorio che ben si può definire Übergangsraum – ‘area di passaggioʼ, come suona il sottotitolo.
Il progetto si conclude in questo stesso anno con la pubblicazione in italiano di un quarto volume, dedicato a Espressioni e forme di identità culturali. I primi due, dedicati a Politica e Istituzioni e a Economia. Le traiettorie dello sviluppo erano stati pubblicati rispettivamente nel 2007 e nel 2009, con traduzioni tedesche in contemporanea a cura della medesima Fondazione. Adesso ci troviamo di fronte a un salto di qualità nelle dimensioni, nelle ambizioni scientifiche ed inter-disciplinari, e anche nel tentativo di darne diffusione (come è doveroso) in lingua tedesca, considerato il diretto coinvolgimento dell’area austro-germanica, a cui fino al 1918 una parte del territorio in oggetto ha fatto parte. Un salto di qualità, considerato anche che l’edizione tedesca è stata realizzata da una casa editrice importante, Böhlau, fra l’altro ben presente anche in Germania.
È molto difficile riassumere in modo sintetico i contenuti così densi e variegati del volume. Questo si articola in due ampie sezioni, precedute da una densa introduzione, che ben chiarisce i motivi e le direttrici dell’impresa. La prima sezione tratta della «popolazione come oggetto di conoscenza», esaminando fra l’altro l’evoluzione di discipline cruciali per l’argomento, come la demografia storica, l’antropologia, le scienze statistiche e la storia delle istituzioni pubbliche preposte, il rapporto fra caratteri montani dei territori ed evoluzione demografica (matrimoni, natalità), i processi migratori, le lingue. La seconda parte è dedicata invece a studiare – ancora una volta sotto molteplici punti di vista – gli intrecci fra popolazione e politica, prendendo le mosse dal 1871.
Particolare attenzione viene dedicata alle due guerre mondiali (soprattutto alla prima) e ai loro impatti sulle popolazioni, così come sulle politiche snazionalizzatrici del fascismo e – di converso – del nazionalsocialismo. Attenzione è dedicata nell’ultima parte di questa seconda sezione alla questione dei ladini, oggetto (per lungo tempo impotente) delle dispute fra italofoni e tedescofoni e strattonati a seconda delle situazioni dall’una o dall’altra parte. I saggi conclusivi si aprono agli scenari dell’oggi e del domani, analizzando le nuove migrazioni e la delicata questione dell’accoglienza. Va precisato che per il periodo successivo al 1918 l’attenzione degli autori si concentra dichiaratamente sulle due porzioni del Tirolo storico passate sotto la sovranità italiana, mentre il Land Tirol rimane sullo sfondo.
Gli stimoli sono innumerevoli, tutti interessanti. Invero, una parte di questi saggi sono da considerarsi pionieristici. Ricordo ad esempio i due saggi di Di Michele e Mezzalira dedicati alle migrazioni interne dall’Italia verso la provincia di Bolzano durante il fascismo e dopo il 1945. Ma particolarmente interessanti mi sono parsi anche i saggi della prima parte che ricostruiscono l’attenzione degli antropologi verso il territorio alpino o la questione dei confini, così aspramente discussa fra geografi italiani e austriaci (e tedeschi) fra Otto e Novecento. O le riflessioni sul rapporto fra assetto fondiario (maso chiuso, o no) ed evoluzione demografica.
Per tirare le somme, considero questo volume un eccellente Handbook (tipo quelli di Oxford University Press – se il paragone non suonerà blasfemo ai tanti amanti del made in Britain), al quale si può attingere in svariati modi e per molti scopi. Certo, non è una lettura facile!
Era ora – a mio parere - che un’istituzione così importante come la Fondazione Museo storico si facesse promotrice di progetti di ricerca che travalicassero i confini nazionali, ma soprattutto provinciali! Come se eventi storici così importanti come guerre, dinamiche economiche, culturali, identitarie, e – nel caso di questo volume – legate all’evoluzione della popolazione di questi tre territori potessero essere studiate e soprattutto capite sulla scala ‘piccolaʼ, sebbene politicamente e identitariamente così rilevante, come una provincia, due provincie, o tre.
Compiuto questo passo così rilevante e faticoso (sono trascorsi quasi trent’anni da quando il progetto è stato lanciato), ci si dovrebbe porre l’obiettivo di fare un passo in avanti – a mio parere. Passare dalle raccolte di saggi – magari di alto livello e di grande interesse come quelli raccolti nel volume qui recensito – alla realizzazione di studi specifici e comparativi su singoli aspetti, o su specifici nodi di particolare rilevanza storica. La Fondazione Museo storico dovrebbe fare un salto di qualità: da stimolatrice di pubblicazioni a più mani a protagonista in prima persona della ricerca storica. Magari, affidando specifici incarichi di ricerca – adeguatamente remunerati – a singoli studiosi, o magari a una coppia di studiosi (non dimentichiamo mai il gap linguistico italiano/tedesco), ai quali venga affidato uno specifico incarico. Studiando – faccio due esempi – in modo comparato e approfondito, ma al tempo stesso leggibile e fruibile a un pubblico più ampio, le dinamiche dell’agricoltura negli specifici contesti a maso chiuso e non, o le politiche delle due dittature aldiquà e aldilà del displuvio alpino negli anni Trenta. Ma i temi su cui focalizzare nuove ricerche sarebbero molti. Si potrebbe così – credo – avviare lo studio davvero approfondito e comparato di questo così delicato e complesso Übergangsraum – e spezzare le angustie del localismo e dell’identitarismo. Forse non è un obiettivo facile, le resistenze sono prevedibilmente forti. Ma ci si potrebbe – direi, dovrebbe – provare.