

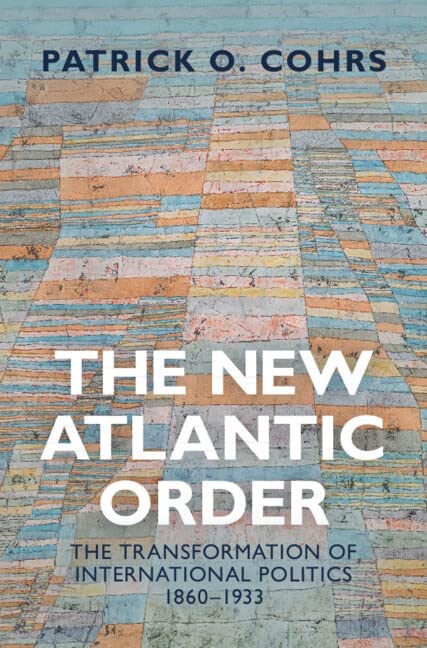
Reviewer Jacopo Perazzoli - Università di Milano
CitationCome chiarito fin dalla primissima riga dell’introduzione, lo studio di Patrick O. Cohrs, quanto mai ricco di spunti, di stimoli e di informazioni, vuole trovare una soluzione ad una questione che alimenta da tempo il dibattito tra storici e storiche del Novecento, e cioè «perché non sia stato possibile creare un ordine internazionale duraturo dopo la Prima guerra mondiale» (p. 1).
Per contribuire efficacemente ad un dibattito storiografico davvero fecondo (si pensi, giusto per fare due esempi di lavori concepiti in epoche diverse, a Politics and Diplomacy of Peacekeeping di Arno J. Mayer e a The Deluge: The Great War and the Remaking of Global Order di Adam Tooze), Cohrs ritiene sia utile «esplorare nel modo più completo possibile le modalità con cui i protagonisti del primo dopoguerra hanno affrontato la sfida più profonda […] che si è presentata durante la guerra e si è acuita nel dopoguerra», ossia «di superare l’“ordine” mondiale ancora eurocentrico dell’epoca dell’imperialismo […] e di gettare le basi per qualcosa di inedito» (p. 1), cioè «un nuovo ordine atlantico di Stati democratici» (p. 16). L’insuccesso di quel processo avrebbe avuto implicazioni globali sull’evoluzione del Ventesimo secolo.
Strutturata in quattro differenti sezioni, la ricostruzione prende il via con la costruzione del “concerto di potenze” europee a seguito del Congresso di Vienna del 1815 e dalla sua progressiva disintegrazione a causa delle pulsioni provocate dalle rivoluzioni europee del 1848. Anche se il «sistema di Vienna» sarebbe riuscito ad «evitare un’escalation» dei moti «in una conflagrazione transeuropea», la sua struttura, «un tempo solida», cominciò, proprio a seguito di quelle turbolenze, «a sfilacciarsi sensibilmente» (p. 58). La prima parte, che deve essere considerata una sorta di inquadramento storico-tematico, termina giustamente con lo scoppio della Grande guerra: è una scelta logica, direi quasi scontata, che però talvolta viene omessa dagli studi su questi temi, che invece devono necessariamente considerare le macro-ragioni che portarono alla rottura degli equilibri continentali nell’estate del 1914.
Nel sottolineare l’«immensa complessità che caratterizzò le relazioni tra le grandi potenze» nelle fasi immediatamente precedenti al conflitto (p. 161), Cohrs sembra voler premettere una questione che affronterà col prosieguo del suo studio: certo, la guerra sarebbe stata «la catastrofe catartica che avrebbe […] dato l'impulso decisivo al primo serio tentativo dell’era moderna di costruire un moderno sistema internazionale atlantico» (p. 168); tuttavia, le tensioni, che precedevano la stessa esplosione delle ostilità, avrebbero avuto un peso significativo nell’ostacolare i propositi degli architetti del mondo postbellico.
Proseguendo con l’analisi in chiave cronologica e al contempo tematica, nella seconda parte l’autore si concentra sulla Prima guerra mondiale, leggendone l’evoluzione dalla prospettiva specifica di dare forma al nuovo ordine atlantico. Ebbene, un iniziale momento di svolta Cohrs lo individua, a ragione, nell’armistizio dell’11 novembre 1918. Pur dimostrando la nuova centralità degli Stati Uniti, capaci di trasformare il conflitto «in una guerra euro-atlantica in cui […] l’influenza politico-ideologica acquisita da Wilson» aveva iniziato a giocare «un ruolo determinante», la cessazione delle ostilità sul fronte occidentale aveva dimostrato che «il presidente americano […] non era (stato) in grado di imporre le sue condizioni e visioni all’Intesa». Inoltre, l’«armistizio, per nulla wilsoniano», avrebbe portato ad «una più totale sconfitta della Germania, minando così le prospettive di pace stabile» (p. 277).
A questo proposito mi permetto un’osservazione specifica: è senz’altro innegabile che le condizioni dell’armistizio, poi di fatto confermate dal Trattato di Versailles, avrebbero rappresentato un duro colpo per la nascente Repubblica tedesca. Al tempo stesso, come ci è stato ricordato da alcuni recenti studi sulla Conferenza di pace di Parigi, alla Germania venne comunque data la possibilità di accedere al nuovo sistema internazionale, a patto che dimostrasse una buona condotta nell’immediato dopoguerra.
Dopo aver esaminato il conflitto e la sua difficile conclusione, Cohrs, nella terza parte, compara le tre differenti visioni di pace e di ordine internazionale che Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna intendevano realizzare all’indomani della guerra. Giustamente, si sostiene che, al di là della «gamma senza precedenti di attori ufficiali e non ufficiali che si sforzarono di influenzarla», ciò che risultò decisivo per la costruzione della pace «furono, indiscutibilmente, gli obiettivi prevalenti, le visioni e le concezioni in evoluzione dei principali leader politici dei tre principali vincitori». In pratica, a Parigi si trattava di vedere quanto «Wilson, Clemenceau, Lloyd George e i loro principali consiglieri» riuscissero a «sviluppare […] strategie efficaci che si prestassero alla costruzione di una pace duratura e di un ordine postbellico» (p. 349). Secondo l’autore, quella partita prese il via nei «due mesi che intercorsero tra l’armistizio del novembre 1918 e l’apertura della Conferenza di pace a metà gennaio 1919», una vera e propria fase «di apprendimento sia per i vincitori che per i vinti», nel corso della quale «riorientarono in modo critico i loro approcci alla pacificazione e alla creazione di un nuovo ordine internazionale» (p. 350).
Alla sfida di costruire un mondo diverso – ed è questo uno degli assunti centrali su cui Cohrs pone l’accento – partecipò anche la Germania. Anche se, come è ampiamente risaputo, alla fine la Repubblica tedesca non ebbe voce sul trattato di pace, l’autore, esaminando l’atteggiamento wilsoniano della MSPD (Partito socialdemocratico maggioritario), che nel 1919 esprimeva capo del governo, Philipp Scheidemann, e capo dello stato, Friedrich Ebert. Ebbene, i socialdemocratici tedeschi non furono in grado di «preparare il terreno per un dibattito interno il più realistico possibile sul tipo di pace e sul posto che la Germania poteva aspettarsi di avere nell’ordine postbellico». Così facendo, si crearono «le premesse per le successive delusioni, il risentimento e gli eventuali tentativi di sviare le responsabilità accusando Wilson di aver “tradito” la Germania rinnegando le precedenti promesse» (p. 542).
Nella quarta ed ultima sezione, Cohrs completa il suo ragionamento, illustrando al lettore le ragioni che impedirono la costruzione dell’ordine atlantico postbellico. Facendo luce anche sulle numerose controversie affrontate dalla Conferenza di Parigi, dalla riorganizzazione territoriale dell’Est-europeo alla sfida bolscevica, per l’autore la pace non poteva in alcun modo trascendere «i tradizionali interessi di potere», riuscendo magari a favorire «una riconciliazione tra i belligeranti» e varare non solo «una Lega autorevole», ma anche una vasta «autodeterminazione» (p. 880). L’accordo che si raggiunse e il sistema di Versailles «furono più che altro – e inevitabilmente – il risultato di un accumulo di complessi compromessi – compromessi tra concezioni, obiettivi, interessi vitali e preoccupazioni interne dei principali vincitori, che per aspetti cruciali rimasero molto difficili o addirittura impossibili da conciliare» (p. 881). Soltanto dopo il 1945 avrebbe preso forma «una vera e propria Pax Atlantica» (p. 999).
In conclusione, il libro di Cohrs, che deve essere apprezzato anche per la ricchezza di fonti su cui è stato costruito, ci offre una rilettura affatto scontata di quel segmento dell’età contemporanea, compreso tra la seconda metà del Diciannovesimo secolo e i primi trent’anni del Novecento. A mio giudizio, ci permette, infatti, di fare luce sulle ragioni più profonde della mancata stabilizzazione dell’ordine globale dopo la più grande tragedia che l’umanità aveva vissuto fino a quel momento, la Prima guerra mondiale. Ne sarebbe servita un’altra per arrivare ad una stabilizzazione sostanziale, che oggi non pare più così solida come un tempo.