

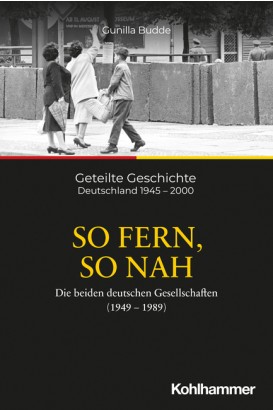
Reviewer Costanza Calabretta - Istituto Italiano di Studi Germanici
CitationAd aprire il volume So fern, so nah. Die beiden deutschen Gesellschaften (1949-1989) è un breve racconto sull’incontro inter-tedesco fra una giovane donna di Oldenburg (Niedersachsen) e uno studente di teologia di Jena (Thüringen), avvenuto nel 1956 durante l’Evangelischer Kirchentag di Francoforte. Dall’incontro nacque una storia d’amore che portò la giovane a spostarsi nella DDR, seguendo una traiettoria anomala rispetto al flusso migratorio prevalente che si sviluppò in direzione contraria, da Est verso Ovest. La storia della coppia e poi della famiglia Gallas ci introduce alla monografia di Gunilla Budde, professoressa di storia contemporanea presso l’Università di Oldenburg, dedicata a ricostruire le somiglianze, le differenze e gli intrecci fra la società tedesco-orientale e quella tedesco-occidentale. Muovendosi nel solco tracciato in primis da Christoph Kleßmann, l’idea fondamentale è quella di indagare gli sviluppi delle due società senza presentarle esclusivamente nell’ottica dell’opposizione e del contrasto, ma mettendo in primo piano la loro dimensione relazionale, fatta di distanziamenti, scambi, sguardi e rappresentazioni incrociate. L’autrice, inoltre, vuole evitare le letture teleologiche e le gerarchizzazioni, che frequentemente hanno subordinato gli sviluppi della Repubblica democratica a quelli della Repubblica federale, presa a modello.
So fern, so nah è articolato in sei capitoli, sei nuclei tematici attraverso cui sono presentate le due società tedesche, dalla loro ristrutturazione dopo la Seconda guerra mondiale, agli sviluppi nel campo dell’istruzione, della famiglia, dell’infanzia e della gioventù, dei consumi e, infine, agli spazi dei movimenti di protesta e opposizione. Le fonti usate per ricostruire questa storia, con un approccio prevalentemente socio-culturale e di genere, includono letteratura secondaria, stampa, prodotti culturali in senso ampio ‒ film e trasmissioni televisive, romanzi e canzoni popolari ‒ ed infine interviste con testimoni d’epoca (anche se l’uso delle fonti orali risulta poco tematizzato).
Il primo capitolo sviluppa una riflessione sulla ricostruzione delle società tedesche, unendo in modo inedito il tema degli spostamenti di popolazione ‒ dai Vertriebene che lasciano i territori orientali dopo il 1945, ai Flüchtlinge che abbandonano la DDR ‒, con quello dell’elaborazione del passato nazista. Le due società sono presentate come dinamiche e «in movimento», con le trasformazioni strutturali portate avanti dalla Repubblica democratica e l’ampia diffusione del benessere economico nella Repubblica federale. Non mancarono tuttavia delle «isole di tradizione», che l’autrice ravvisa ad esempio nella persistenza di privilegi e stili di vita borghesi non solo nella BRD, ma anche fra l’intellighenzia socialista della DDR.
L’attenzione si sposta sul tema dell’istruzione, specchio dell’identità politico-culturale delle due Repubbliche, che si fronteggiarono anche in questo ambito, sviluppando sistemi diversi ‒ centralistico nella DDR e federale nella BRD. L’autrice indaga poi la questione dell’uguaglianza fra uomini e donne ‒ proclamata nelle Costituzioni di entrambe le Repubbliche ‒ e dell’emancipazione femminile, guardando alla presenza delle donne nel mondo del lavoro e alla loro parità fra le mura domestiche. Proprio sotto quest’ultimo aspetto Budde dimostra la fallibilità del mito dell’emancipazione femminile nella DDR. La divisione dei ruoli di genere, infatti, non fu messa in discussione così profondamente, e alle donne rimase più difficile accedere ai ruoli guida nel partito e nello Stato. La riflessione sul ruolo della donna si prolunga anche nel capitolo successivo dedicato alla famiglia, che «in piccolo tenne insieme i due Stati tedeschi» e rimase in entrambi «la forma di convivenza più diffusa e amata» (p. 93). Da specialista di storia della famiglia, l’autrice riserva un’attenzione inedita a questo tema, analizzando il diritto, le politiche, i modelli familiari e le pratiche concrete ‒ dalle famiglie «incomplete» delle vedove della Seconda guerra mondiale, alla vita matrimoniale, al divorzio, ai compiti dei genitori. Da questo sguardo ravvicinato appare come nel contesto familiare le differenze fra i due sistemi si facessero più evanescenti (p. 127). Altrettanto denso è il capitolo successivo, dedicato all’infanzia e alla giovinezza, che analizza gli aspetti educativi e scolastici, le forme di organizzazione del tempo libero, di politicizzazione, le subculture e i consumi giovanili (musica, moda). In questo campo, come nei movimenti ambientalisti e pacifisti di cui tratta nel sesto capitolo, l’autrice vede delle convergenze fra le due società, forse sottostimando che nella DDR alcune scelte erano specchio di una forma di occidentalizzazione, che aveva una connotazione di protesta verso il regime.
So fern, so nah si inserisce in un panorama di studi sull’entangled history delle due Germanie ormai nutrito, e vi apporta un contributo significativo, soprattutto perché riesce a mettere in luce efficacemente come la realtà delle due Repubbliche fosse rimasta più vicina di quanto sostenuto dai modelli discorsivi e dalle rappresentazioni opposte. Nel coprire tutto l’arco della doppia statutalità tedesca, l’autrice non manca di evidenziare rotture e continuità, offrendo un quadro ricco di sfumature, scardinando alcuni miti e mettendo in luce come la concorrenza fra DDR e BRD sia stato un fattore di dinamicità (p. 214). Lo sguardo ravvicinato alla società e alle pratiche di vita permette, infine, di capire come sia stato possibile per i cittadini dell’ex DDR vivere «una vita del tutto normale», pur all’interno di un regime autoritario. Il volume inevitabilmente tralascia alcuni aspetti, ma in compenso si offre come un’ottima rappresentazione complessiva, adatta anche ad un pubblico non specialistico, tanto più che il testo è agile e di piacevole lettura, «una rara eccezione rispetto all’aspro gergo scientifico tedesco» ‒ come ha scritto Ralph Jessen (https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-135363).