

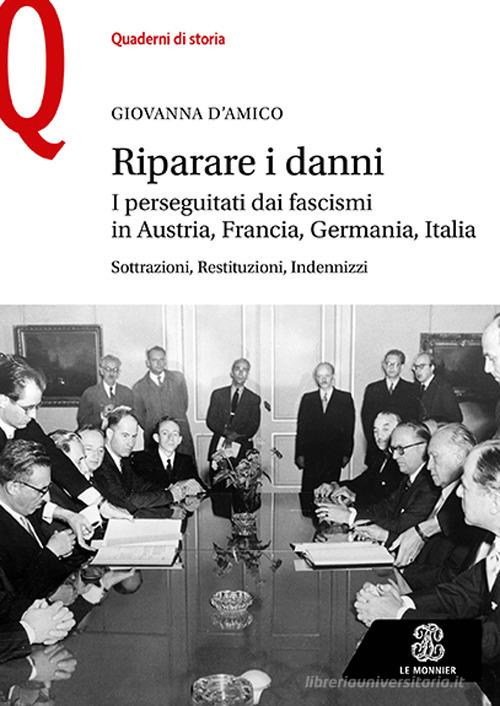
Reviewer Maddalena Guiotto - Fondazione Museo Storico del Trentino
CitationCome indicano i sottotitoli, il volume di Giovanna D’Amico affronta in un’ottica comparata l’ormai settantennale questione della riparazione dei danni subiti dai «perseguitati dai fascisti». Non si limita a ricostruire puntualmente in quale modo e in quale misura dopo il 1945 sono avvenute le restituzioni dei beni sottratti e come sono stati reintegrati, per lo più nei loro posti di lavoro, i «perseguitati», ma esamina anche le varie forme di persecuzione subite in precedenza dalle vittime dei fascismi – che vanno dalla privazione della cittadinanza alle espulsioni dal lavoro, dalle spoliazioni di beni alla persecuzione di alcuni gruppi sociali. Di conseguenza anche l’arco temporale del volume è ampio e si snoda dalla salita al potere di Mussolini sino ai giorni nostri, dato che i risarcimenti, le restituzioni dei beni e gli indennizzi alle vittime dei regimi interbellici rappresentano una questione ancora aperta e di rilievo internazionale.
Il volume è suddiviso in tre capitoli. Il primo capitolo affronta oltre al tema delle depredazioni di beni alle vittime dei diversi regimi fascisti, soprattutto quello delle restituzioni patrimoniali e degli indennizzi ai perseguitati, esaminando le varie norme e soffermandosi anche sugli aspetti quantitativi e fattuali. Nel secondo capitolo viene sviluppato il tema dei licenziamenti e delle reintegrazioni nel lavoro attraverso i casi specifici dei professori universitari e degli imprenditori. Il lavoro autonomo imprenditoriale era infatti quello più diffuso tra gli ebrei, mentre l’espulsione dagli impieghi pubblici e statali ebbe un forte impatto anche tra i perseguitati politici. Si tratta inoltre dei casi più studiati nei quattro paesi presi in considerazione, ovvero l’Austria, la Francia, la Germania e l’Italia, e quindi maggiormente raffrontabili. Il terzo e ultimo capitolo si concentra invece sulla lenta e tarda reintegrazione delle cosiddette «vittime dimenticate», ossia degli «zingari», degli omosessuali e dei lavoratori «coatti», che le iniziali norme austriache e tedesche avevano solo in parte compreso nella definizione di «vittime del nazismo», nella quale rientravano solo gli oppositori politici, i «perseguitati razziali» e i perseguitati «per motivi religiosi».
È importante sottolineare che questo libro rompe con una certa tendenza radicata nella storiografia a privilegiare ricostruzioni squisitamente nazionali e utilizza invece un metodo comparativo con l’analisi e la rielaborazione delle storiografie dei quattro Paesi considerati. Sono Paesi che hanno una storia molto differente sia per quanto riguarda il periodo precedente a quello considerato nel volume che il periodo stesso, anche se ovviamente non mancano i tratti in comune. Tra questi in particolare il dato di fatto che nel dopoguerra furono gli Alleati i primi a pensare e a mettere in atto la riabilitazione delle vittime in tutti e quattro i Paesi. Il caso della Germania è tuttavia particolarmente importante. Gli Alleati che la occuparono vi impressero di proprio pugno norme e provvedimenti assai più radicali di quelli emanati in Austria e in Italia (la Francia, quale potenza vincitrice, poteva permettersi dal canto suo di sottrarsi all’imposizione britannica e statunitense), ma oltre a questa maggiore radicalità la Germania fu e rimane anche fino ai nostri giorni punto di riferimento ultimo per ulteriori richieste e rivendicazioni.
La scelta di questi quattro Paesi è motivata dalla loro appartenenza all’Europa centro-occidentale, dove già dal 1944-1945 si fissò l’idea che era necessario, nell’accordare la dovuta riparazione alle vittime dei fascismi, reintegrarle il più possibile nella posizione in cui si sarebbero trovate se la persecuzione non fosse stata attuata e riparare in questo modo il passato per poter finalmente guardare avanti, come aveva auspicato Ivanoe Bonomi. Vennero quindi restituiti non solo i posti di lavoro a quanti ne erano stati privati perché si erano opposti al fascismo e al nazismo, o per motivi razziali e religiosi, ma vennero resi anche i beni e i patrimoni. Nell’Est europeo, ovvero nei paesi del blocco sovietico e quindi anche nella ex DDR (Repubblica Democratica Tedesca), si instaurò invece un ordine economico che fino alla svolta del 1989 portò alla mancata restituzione dei beni.
Ma c’è anche una seconda ragione nella scelta dell’autrice di occuparsi di questi quattro Paesi, ovvero la possibilità di un ampio e stimolante confronto tra situazioni in alcuni casi diverse e in altri simili. Per esempio, Italia e Francia non conobbero la Gleichschaltung di tutte le istituzioni e dell’intera società messa in atto dal nazionalsocialismo, prima in Germania dopo il 1933 e poi, dopo l’Anschluss nel 1938, anche in Austria. Di conseguenza in Francia e in Italia sono rimaste più a lungo al potere le élites “tradizionali” e questo sembra avere influito, tra l’altro, nelle spoliazioni patrimoniali a carico dei perseguitati dal regime fascista che furono meno incisive che in Germania e dopo il 1938 anche in Austria. Quest’ultima divenne periferia del Reich, ma al tempo stesso anche centro di un aggressivo germanesimo di confine. Hitler voleva crearvi una struttura soggetta direttamente a Berlino e completamente integrata nel Reich e nella sua Gleichschaltung, soprattutto con il travaso, che voleva fosse integrale (ma integrale non lo fu mai), dei provvedimenti persecutori nazisti, tra cui le leggi di Norimberga. Va aggiunto a quanto scrive l’autrice che a essere annientata in Austria dai nazisti fu per prima la dittatura instaurata da Engelbert Dollfuß a partire dal 1933 e continuata, dopo il suo assassinio, da Kurt Schuschnigg. Nel primo Transport per il campo di concentramento di Dachau si trovavano, assieme a comunisti, a noti scrittori ebrei, ad artisti e a uomini del mondo dell’economia, anche i cosiddetti «austrofascisti», ossia vari appartenenti al governo autoritario austriaco e al Fronte patriottico ed ex comandanti della Heimwehr.
L’autrice sottolinea giustamente come l’Austria sia un caso interessante anche per quel che riguarda il tema delle spoliazioni ed espulsioni dal lavoro, perché permette di analizzare la loro diversa incisività nei due diversi regimi: «austrofascista» prima del 1938 e nazionalsocialista dopo. Approfondendo questo aspetto della diversa incisività impiegata nelle spoliazioni e nei licenziamenti dai differenti regimi fascisti in Austria, in Italia e Francia, l’autrice, dopo aver ricordato che anche nei territori dell’Italia e della Francia annessi di fatto al Reich vennero applicate direttamente le leggi discriminatorie e persecutorie naziste, sottolinea che nel secondo dopoguerra i governi italiani, come anche quelli austriaci, dovettero tenere conto al momento della reintegrazione dei perseguitati delle norme discriminatorie differenti prima e dopo il 1943 in Italia, prima e dopo il 1938 in Austria. In pratica questi governi si trovarono di fronte a quello che l’autrice definisce un duplice passato fascista: c’erano da una parte i torti messi in atto dai nazisti, assieme o separatamente dai collaborazionisti, e dall’altra le politiche dei regimi autoctoni.
Per rimanere in Austria, che dei quattro casi esaminati nel volume rappresenta indubbiamente quello meno conosciuto in Italia, è interessante l’osservazione che le leggi di restituzione dei beni a favore degli oppositori politici che erano stati perseguitati durante il regime autoritario dal 1933-1934 al 1938, vennero denominate Rückgabegesetze, mentre quelle a favore dei perseguitati dal nazismo dopo il 1938 assunsero il nome di Rückstellungsgesetze. L’autrice osserva che si traducono entrambe con «restituzione» e che la differente titolazione voleva rimarcare difformità di natura simbolica. C’è però una sottile differenza che ha un significato profondo. Sembra infatti che con le Rückgabegesetze si volesse soltanto stabilire una restituzione di quanto tolto dal regime autoritario, mentre invece con le Rückstellungsgesetze si intendesse sottolineare un ritorno alla situazione antecedente al 1938, cancellando gli anni del totalitarismo nazista.
In conclusione, a parte rare piccole imprecisioni, è indubbiamente apprezzabile il grande lavoro dell’autrice che espone il meditato risultato di ampie letture della storiografia internazionale, offrendo al tempo stesso spunti e stimoli per ulteriori approfondimenti che si auspica continuino ad applicare il proficuo metodo comparativo.