

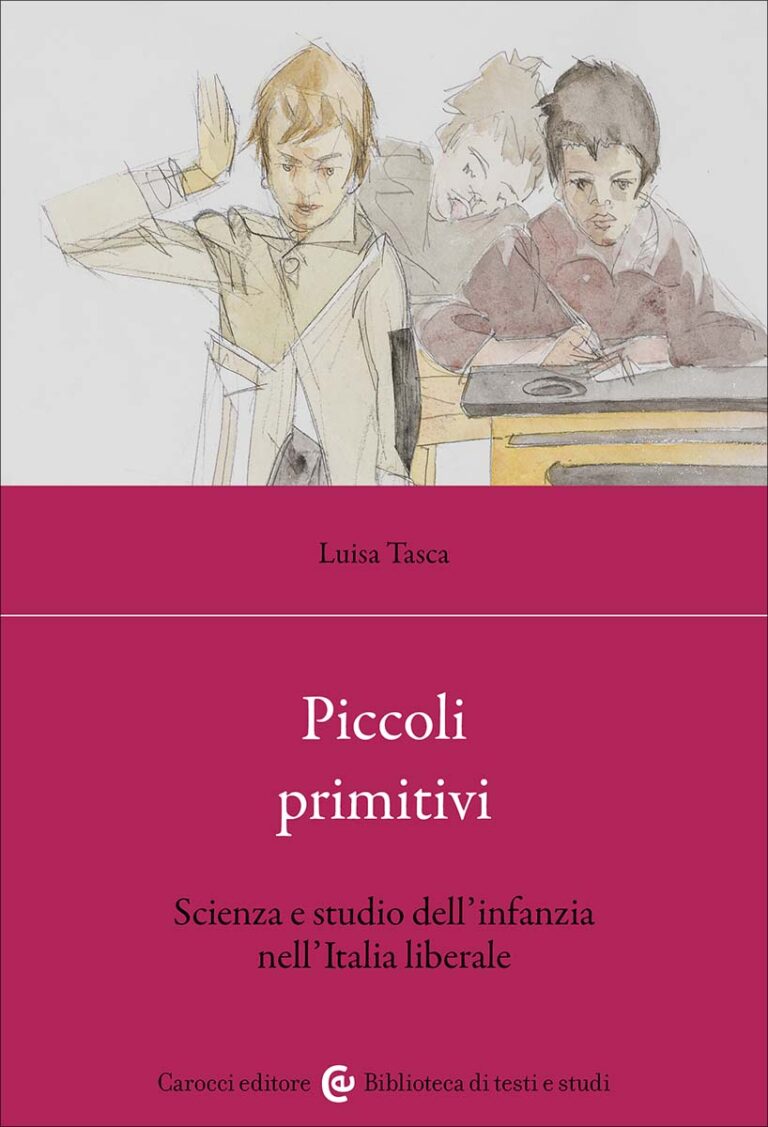
Reviewer Andrea Mariuzzo - Università di Modena e Reggio Emilia
CitationL’autrice del volume qui presentato è già da alcuni anni impegnata in ricerche relative alla storia intellettuale e alla circolazione delle idee nell’Italia dell’Ottocento. In quest’ultima opera, dedicata, come chiarito nel titolo, all’emergere degli studi medico-scientifici e psicologici sull’infanzia nei primi decenni dell’Italia unita, ella individua un tema di sicuro interesse perché posto all’incrocio di diversi sviluppi di grande rilevanza. Da un lato, per la cultura e la scienza italiana il periodo liberale è innanzitutto il periodo in cui il generale consenso positivista caratterizza l’affermazione di un sistema nazionale degli alti studi e della ricerca capace di trovare, attraverso un grande sforzo collettivo di modernizzazione e di sintonizzazione sui maggiori spunti di dibattito internazionali, almeno un abbozzo di collocazione europea delle sue voci protagoniste. Dall’altro, quegli stessi anni vedevano un interesse riformatore verso l’atteggiamento nei confronti dell’infanzia, interesse che si esplicitò tanto in una nuova idea di scuola, con la riforma dell’obbligo del 1877 e l’elaborazione dei nuovi programmi elementari aggiornati da Aristide Gabelli nel 1888, quanto poi in un ancora più incisivo tentativo di mettere in discussione i paradigmi consolidati nel rapporto con bambine e bambini rappresentato a inizio Novecento dalle idee e dall’opera di Maria Montessori.
Nel ricostruire il contesto generale di questi movimenti, l’autrice traccia un profilo per molti aspetti originale del dibattito scientifico relativo all’infanzia nei decenni a cavallo del 1900. In primo luogo, esso ha il pregio di saldare in modo convincente le idee alle persone. Gli esponenti di spicco di almeno due generazioni della scienza, dell’antropologia e della medicina positivista, da Enrico Ferri e Paolo Mantegazza a Cesare Lombroso, da Giuseppe Sergi a Giovanni Antonio Colozza, emergono come protagonisti della ricezione nella cultura italiana dei maggiori studi internazionali sulla psicologia e l’educazione dell’infanzia negli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento, a partire da quelli del francese Bernard Perez, in un’ondata di rinnovamento di atteggiamenti con la quale dovranno fare i conti per ritagliarsi spazio e credibilità nel dibattito tanto intellettuali ed educatori cattolici, quanto dalla fine del secolo gli emergenti esponenti socialisti. Ne risulta, dunque, la ricostruzione di un quadro di confronti intellettuali ricco e vivace, da cui si può apprezzare lo sforzo della comunità scientifica e intellettuale italiana di connettersi alle reti internazionali più aggiornate, sforzo che si riverberò nei primi anni del Ventesimo secolo anche negli interventi sulla scuola, per garantire il pieno consolidamento istituzionale dell’istruzione primaria di massa, in particolare attraverso la legge Daneo-Credaro del 1911, secondo le basi teoriche acquisite dalla pedagogia nei due decenni precedenti.
Connesso a questo elemento vi è poi una proposta interpretativa di particolare interesse di cui l’autrice intende farsi interprete. Come si legge infatti nell’introduzione (p. 27), la ricerca
«si pone in modo critico verso una corrente di pensiero anti-illuministica che attribuisce alla scienza, e in particolare alle neonate scienze sociali, l’obiettivo di una riorganizzazione gerarchica dei rapporti umani. Secondo questa tesi, la scienza ottocentesca, intrisa di stereotipi razziali, sociali e antisemiti, avrebbe preparato Auschwitz […]. È una lettura del potere e della cultura occidentale che ascrive alla scienza il razzismo, lo schiavismo e il genocidio ebraico […]».
Da un lato è vero, riconosce Tasca, che la scienza positivista ereditava dalla cultura precedente un atteggiamento verso l’infanzia in cui si riversavano le diffidenze verso il “primitivo” inteso come incivile, incolto e immaturo e quindi imperfetto, non tanto depositario dell’innocenza primigenia quanto della perversione dovuta all’incapacità di limitare e reprimere le proprie pulsioni. Un atteggiamento, questo, che potrebbe portare a guardare ai dispositivi di educazione e di riformulazione delle relazioni sociali in termini di disciplinamento, di distinzione catalogatrice dei tipi umani e di giustificazione della violenza repressiva. Ma è soprattutto vero – continua nel suo tratto argomentativo l’autrice – che la cultura scientifica tardo-ottocentesca, pur con le sue rigidità biologiste e le sue forzature, appare legata soprattutto a uno sforzo umanitario di inclusione, di diffusione del benessere, di emancipazione e di sfondamento delle barriere nazionali e sociali. In questo senso, una voce rivoluzionaria della cultura educativa di inizio Novecento come Maria Montessori si collocava sul piano ideale in una linea di continuità col clima positivista in cui si era formata – e che aveva prodotto anche i medici e antropologi che intendevano risolvere le patologie infantili legate alla seduta forzata sul banco scolastico con gli studi di ergonomia piuttosto che con la loro eliminazione – in modo assai più evidente di quanto gli studi più recenti tendano a mettere in evidenza.
Si tratta di una chiave di lettura che, spinta all’estremo, forse si espone al rischio di essere non meno unilaterale di quella da cui l’autrice intende prendere in modo esplicito le distanze. Bisogna però riconoscere che il volume, nelle sue conclusioni, non cade mai in questo eccesso, ma piuttosto aiuta a ricontestualizzare nel panorama del dibattito scientifico e intellettuale coevo l’indubbio sforzo progressivo messo in opera – pur tra mille cautele e contraddizioni – da tutti i maggiori governi europei, così come in Italia da sinistra storica prima e classe dirigente giolittiana poi nel quarantennio che precedette la Grande Guerra.