

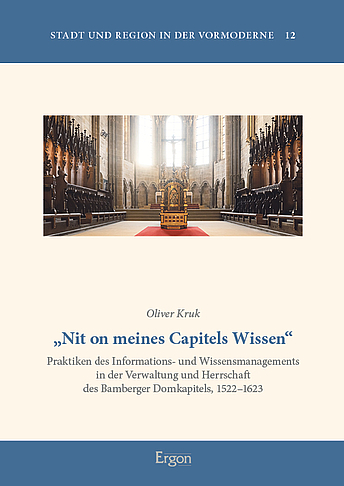
Reviewer Emanuele Curzel - Università di Trento
CitationIl volume costituisce l’esito a stampa di una tesi di dottorato, discussa nell’agosto 2023 presso la Otto-Friedrich-Universität di Bamberg, ed è il felice risultato di una ricerca che si colloca all’incrocio tra la storia dei capitoli delle cattedrali, lo studio dell’evoluzione degli organismi statali (in un’area peculiare come quella imperiale: non casuale la scelta della collana editoriale) e l’analisi dei meccanismi della comunicazione in età moderna. Si tratta di questioni che, come è facilmente intuibile, sono diverse e hanno alle spalle tradizioni di ricerca differenziate, ma che nel robusto tomo vengono fatte interagire fino a giungere a un risultato utile a molti filoni di ricerca.
L’esposizione si articola in sette capitoli. Quello introduttivo presenta ordinatamente status quaestionis, fonti utilizzate e percorso di costruzione del lavoro, anticipando così i principali temi trattati. Il secondo è di carattere istituzionale: tratteggia la storia del capitolo della cattedrale di Bamberg, forte di 34 membri (di cui 20 aventi pienezza di diritti), con la sua gerarchia interna e i suoi meccanismi di funzionamento. L’ente aveva un notevole peso nella città e nel territorio: Bamberg era infatti una città vescovile, nella quale il titolare del potere religioso esercitava anche poteri temporali, e i suoi «ausiliari concorrenti» (per usare l’espressione di Gabriel Le Bras), esclusivamente nobili, non potevano che essere fortemente e quotidianamente coinvolti nell’amministrazione civile ed ecclesiale. Anzi: il Capitolo aveva il diritto di governare in sede vacante e di eleggere il nuovo vescovo, imponendogli di volta in volta capitolazioni che ne condizionavano le scelte successive. I canonici possedevano inoltre un notevole patrimonio, fondato su estesi diritti immobiliari (e perfino su un proprio autonomo spazio giurisdizionale). L’autore prende in considerazione l’arco cronologico che va dal 1522 al 1623, considerato significativo perché si tratta dell’epoca contemporanea e successiva alla divisione confessionale che rese Bamberg una penisola cattolica circondata da aree passate invece alla Riforma: un fatto che ebbe evidentemente conseguenze a più livelli.
Per esercitare i suoi compiti e difendere i suoi diritti l’ente aveva bisogno di avere, al centro, i propri burocrati, economi e scrivani («mani e piedi», come vengono definiti) e, sul territorio, i propri funzionari e rappresentanti capaci di conoscere le situazioni («occhi e orecchi»), così che le decisioni potessero essere prese alla luce delle informazioni raccolte. Il terzo capitolo è così dedicato proprio alla comprensione dei meccanismi di acquisizione delle informazioni utili alla gestione del potere territoriale (testimonianze, rapporti, suppliche, appelli; notevole l’importanza dello strumento cartografico) e del trattamento e della trasmissione di tali informazioni. Il quarto capitolo è sulle questioni archivistiche: l’archivio del capitolo – ben distinto da quello vescovile – era percepito come una parte del tesoro stesso della cattedrale; era conseguentemente protetto e circondato di attenzioni che si traducevano anche nella redazione di ciò di cui c’era bisogno per il suo uso (repertori, inventari, indici). Governo e amministrazione erano (e sono) anche un problema di conoscenza: collocandosi all’interno delle ricerche sull’Information State, Kruk mostra come l’archivio fosse lo strumento che permetteva la conservazione e la catalogazione delle informazioni, nonché il punto di partenza perché queste fossero nuovamente, all’occorrenza, rese disponibili; e presenta le serie documentarie (i Rezessbücher con le deliberazioni capitolari, i Protokollbücher con i verbali delle riunioni, i libri nei quali si prendeva nota dei nomi dei canonici residenti e degli assenti, gli Juramentenbücher nei quali erano riportati i giuramenti dei titolari delle prebende, dei funzionari e dei sudditi). Anche i funzionari presenti sul territorio scrivevano libri di conti e manuali di lavoro che talvolta, e sempre più spesso con il trascorrere del tempo, trasmettevano ai successori favorendo, sul lungo periodo, la spersonalizzazione dell’ufficio. Proprio la lunga durata dell’ente capitolare (nonché la sua stessa continuità istituzionale tra età moderna e contemporanea) ha permesso la conservazione di un gran numero di testimonianze di questo genere che permettono di conoscere nel dettaglio le modalità di sedimentazione della memoria dell’ente, il modo i cui le competenze potevano passare da un funzionario all’altro, il grado di autonomia di cui questi godevano nel rapporto con i canonici. Il quinto e il sesto capitolo definiscono dunque i percorsi attraverso i quali venivano amministrati i beni e i diritti capitolari: la storia del capitolo può dunque essere letta anche come una storia della gestione del suo sapere. Il settimo capitolo è quello conclusivo e riepilogativo, nel quale l’autore insiste sul fatto che i canonici si sentivano depositari e responsabili della continuità e della stabilità stessa del principato vescovile. La costruzione e la strutturazione dell’archivio, la spersonalizzazione degli uffici e il consolidamento del ruolo politico dell’ente capitolare all’interno del principato favorirono così il percorso stesso di istituzionalizzazione. In questo modo gli stati ecclesiastici – conclude Kruk – possono essere compresi non solo come strutture politiche ma anche come strutture culturali.
La derivazione del volume da una tesi di dottorato emerge in un certo schematismo didattico, preoccupato di far notare quanto innovativa sia la ricerca (la retorica sulla mancanza di studi sui capitoli delle cattedrali dell’ambito imperiale appare, almeno comparativamente, fuori luogo); nel fatto che si dia sistematicamente ai capitoli e ai paragrafi un titolo evocativo e un sottotitolo esplicativo; in una certa ‟ansia da riepilogo” che porta l’autore a redigere svariati riassunti al termine dei capitoli (al punto che talvolta si ha l’impressione che si tratti di un «libro a tesi»). D’altronde, la dettagliata descrizione del sistema organizzativo, della raccolta sistematica delle informazioni, del loro deposito/schedatura, della loro trasmissione appaiono convincenti. Peccato che la sezione delle illustrazioni sia poco efficace, sia per la sua collocazione al termine della trattazione, sia per la sua limitatezza. Si poteva definire meglio quale fosse il territorio che veniva amministrato e quale aspetto avessero quei mezzi di informazione di cui continuamente si parla, a maggior ragione considerato il fatto che tra essi vi erano spesso – si dice – anche molti strumenti cartografici (qualcosa c’è, ma è troppo poco).