

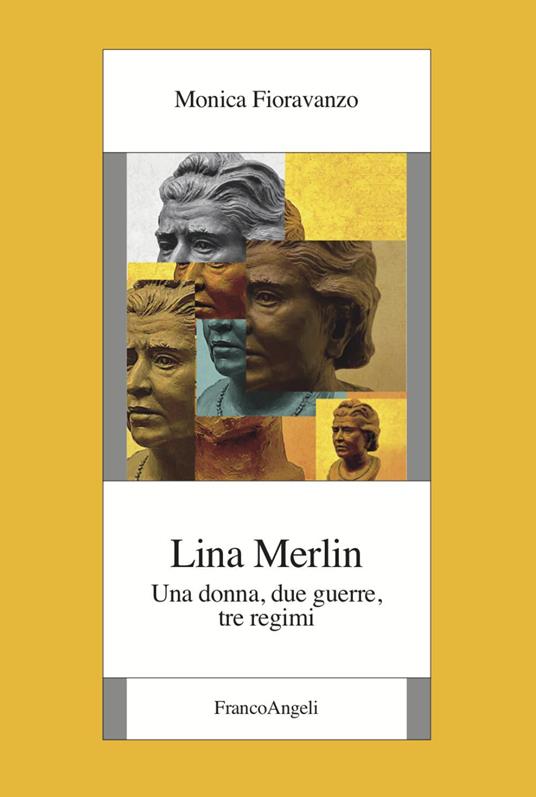
Reviewer Laura Schettini - Università di Padova
CitationIl volume di Monica Fioravanzo, Lina Merlin. Una donna, due guerre, tre regimi, restituisce il racconto storico per la prima volta nella sua complessità e tracciando una lunga traiettoria tra la vita e l’impegno di Lina Merlin (1887-1979), figura chiave della politica italiana del Novecento. Profondamente legata ai suoi luoghi di origine, tra la provincia di Padova e Chioggia, e capace allo stesso tempo di elevarsi a protagonista della storia nazionale, Merlin è stata finora conosciuta, e in una certa misura oscurata, per il suo impegno parlamentare per l’abolizione della regolamentazione di Stato della prostituzione, ottenuta nel 1958 con una legge che ancora è ricordata comunemente come “legge Merlin”.
Grazie a uno scavo meticoloso di scritture private, memorie e documentazione d’archivio (dal Casellario politico centrale all’Archivio dell’Università di Padova, passando per diversi archivi utili alla ricostruzione della storia del Partito socialista e per le carte di polizia conservate negli Archivi di Stato di Padova e Rovigo), Fioravanzo dipana un racconto che si snoda in quattro capitoli, corredati da una significativa appendice di fonti, che va ben oltre questa sovrapposizione. L’intento del volume, dichiarato sin dal primo capitolo introduttivo, è proprio quello di allargare la cronologia, evidenziando il ruolo significativo e peculiare che la politica veneta ha avuto nella storia italiana già a partire dagli anni Venti e fino agli anni Settanta.
Se al primo capitolo del libro è affidato il compito di discutere le mancanze della storiografia nei confronti della biografia politica di Lina Merlin e di anticipare la singolarità delle sue posizioni, in più occasioni ritenute scomode e ambivalenti, il volume prosegue con una struttura originale. Il secondo capitolo traccia la biografia personale e politica di Merlin, ricostruendone le tappe fondamentali, mentre i capitoli terzo e quarto rappresentano un affondo e un ingrandimento dei due assi principali del suo impegno: il rapporto con il socialismo, inteso anche come rapporto con il Partito, e la lotta per il miglioramento della condizione femminile, declinata come battaglia per la parità giuridica ed economica e fortemente influenzata dalla sua adesione al socialismo di stampo umanitario, dall’attenzione ai «diritti delle ultime».
Due sensibilità e due piani di azione, quindi, che Fioravanzo ci mostra fortemente intrecciati tra loro lungo tutto l’arco della vita di Merlin.
Cresciuta in una famiglia della media borghesia delle professioni, la giovane venne avviata agli studi magistrali e fu maestra elementare con convinzione fino al 1926, quando fu costretta a lasciare il suo impiego in base alla legge fascista che dall’anno precedente consentiva al Governo di rimuovere dal loro incarico i funzionari statali, maestre comprese, che avessero mostrato infedeltà alle politiche del regime.
Già all’indomani della guerra, infatti, Lina Merlin si era avvicinata al Partito socialista, del quale divenne ben presto una importante figura operativa a Padova, dove organizzò la sezione femminile, una biblioteca per adulti, il teatro del popolo e garantì l’uscita de «L’Eco dei lavoratori», il periodico socialista locale, fino al 1926 e nonostante la crescente stretta del regime. Fondamentale, inoltre, il suo ruolo nella campagna elettorale del 1924, in occasione della quale, mentre a esponenti più in vista, come Giacomo Matteotti, era impedito di tenere comizi, fu lei a percorrere le campagne del vicentino e del padovano a nome del Partito e a raccogliere la documentazione sui brogli elettorali che costituì la base per il celebre discorso del deputato alla Camera nel maggio del 1924.
Per questa sua coraggiosa e rigorosa postura fu condannata al confino per cinque anni e mandata in diverse località della Sardegna, dalla quale fece anticipatamente ritorno nel novembre del 1929 in seguito ad amnistia. Subito dopo il rientro si trasferì a Milano, città più grande dove sperava di sfuggire meglio al controllo poliziesco, trovare lavoro e, probabilmente, anche di ricongiungersi con Dante Galliani, con il quale aveva intrecciato importanti rapporti politici e personali negli anni precedenti al confino e che infatti sposò nel 1933, un anno dopo la morte della prima moglie di lui.
Sopravvisse a Milano grazie a lezioni individuali o impieghi in scuole private e a mano a mano che il decennio avanzava, benché colpita dalla morte di Galliani nel 1936, intensificò l’impegno nella lotta antifascista clandestina, non disdegnando di fare riferimento anche agli ambienti comunisti, operativamente più organizzati. Nonostante la scarsezza di documentazione rispetto ai suoi incarichi, è accertato che Merlin fondò già nel 1934 un gruppo di donne per il sostegno alle famiglie dei perseguitati politici, organizzò scioperi di lavoratrici, infine fu tra le fondatrici nel 1943, con Ada Prosperi e Giovanna Barcellona, dei Gruppi di difesa delle donne e, nel 1944, dell’Unione donne italiane. Nel biennio successivo partecipò attivamente alla Resistenza nelle fila del ricostituito Partito socialista (Psiup), del quale fu rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia.
La Liberazione segnò per Merlin l’avvio di una diversa fase del suo impegno politico, questa volta istituzionale e pubblico: nel luglio del 1945 fu la prima donna a entrare nella Direzione nazionale del Partito socialista, incarico al quale fu riconfermata per diversi anni e in diversi congressi successivi e il 2 giugno 1946 venne eletta membro dell’Assemblea costituente. Fu senatrice e deputata fino al 1963 e nel corso di questa carriera rivolse il suo impegno principalmente al mondo della scuola (laicità, stabilizzazione degli insegnanti, doposcuola); alla ricostruzione del Polesine dopo l’alluvione del 1951, per la quale si impegnò indefessamente per un decennio; alla prostituzione e – dopo l’approvazione della legge – al reinserimento sociale delle ex-prostitute; alle condizioni di lavoro delle donne. Da segnalare che nel 1961 fu tra le redattrici del Libro bianco sui licenziamenti per causa di matrimonio in Italia, questione alla quale lavorava già da diversi anni. Nel 1963, alla fine della legislatura, Merlin decise di non ricandidarsi, anche per aumentati dissidi con il Partito, nel quale aveva smesso di riconoscersi, seppure idealmente continuò a ritenersi socialista. L’allontanamento dal Partito, tema a cui è dedicato molto spazio nel terzo capitolo, si era prodotto in misura crescente nel decennio Cinquanta, a mano a mano che si compiva la svolta marxista-leninista dello stesso e la politica dell’unità d’azione con il Partito comunista, che aveva avuto come corollario l’imposizione dall’alto dei quadri locali.
Finita la sua esperienza parlamentare a Roma, nei primi anni Sessanta Merlin tornò a Milano, dove fece una vita abbastanza ritirata e poco documentata, impegnandosi solo in alcune istituzioni e associazioni locali.
Tornò alla ribalta delle cronache nel 1970, quando assunse la carica di vicepresidente del comitato promotore del referendum abrogativo dell’appena approvata legge sul divorzio, posizione che destò non poche perplessità, soprattutto nei movimenti delle donne, e che Fioravanzo approfondisce nel quarto capitolo. Secondo l’autrice, questa posizione va interpretata proprio alla luce dell’impegno pluridecennale di Merlin a favore dei «diritti delle ultime» e alla sua valutazione che l’istituto del divorzio, calato in un regime di evidente asimmetria economica tra uomini e donne e di mancata riforma del diritto di famiglia, si sarebbe tradotto solo nella possibilità per i mariti, per gli uomini, di svincolarsi dall’onere di provvedere e mantenere le mogli e i figli. Oltre alle ragioni materiali, ci suggerisce Fioravanzo, non è stata estranea a questa posizione anche l’intenzione di Merlin di promuovere e difendere una specifica idea di “natura femminile”: quella secondo cui le donne sarebbero e dovrebbero essere portate alla difesa del bene comune, della collettività, mentre il divorzio segnerebbe il trionfo della volontà e dell’interesse del singolo. È su questo piano, dunque, che negli ultimi anni della sua vita (morì a Padova nel 1979) Lina Merlin marcò la distanza anche dal neofemminismo, generazione politica che, tra le altre cose, ha dedicato molte riflessioni critiche proprio alle declinazioni date e all’esistenza stessa della “natura femminile”.