

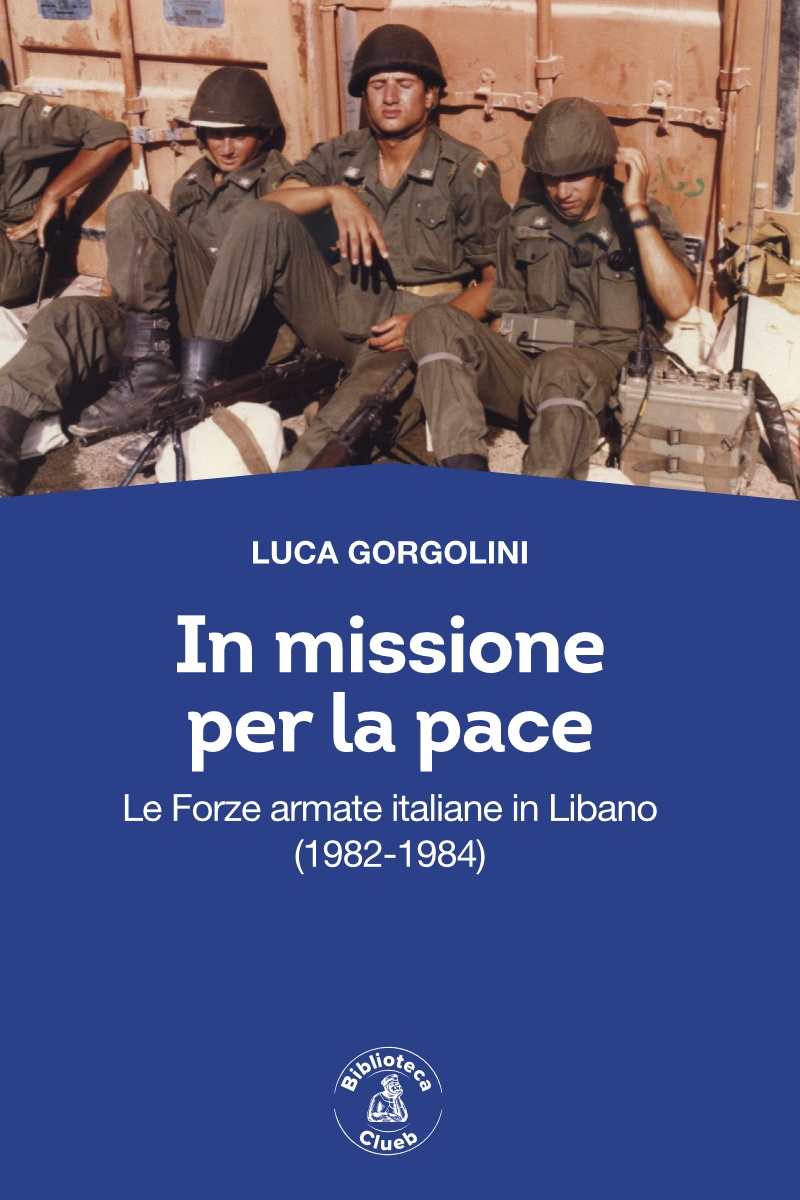
Reviewer Andrea Argenio - Università di Roma Tre
CitationQuando nell’agosto 1982 il Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini, primo non democristiano alla guida del governo, decise l’invio di un contingente militare che partecipasse alla missione di pace condotta dalla Forza multinazionale in Libano, la notizia giunse nel mezzo di un’estate caratterizzata dalla gioia per la vittoria nel mondiale di calcio spagnolo. Negli anni passati non erano mancate occasioni per le forze armate di partecipare a operazioni di peacekeeping sotto l’egida delle Nazioni Unite ma l’ampiezza, la durata dell’impiego dei soldati italiani (la missione ebbe termine nel marzo 1984 coinvolgendo circa ottomila soldati) e la pericolosità del quadrante di operazioni la resero un evento che trascese le semplici motivazioni politico militari. Non stupisce quindi che la storiografia più recente si sia concentrata sullo studio della missione anche grazie alla possibilità di consultare archivi e fonti sinora chiusi ai ricercatori. Al volume di Silvio Labbate del 2022 edito da Franco Angeli, L’Italia e la missione di pace in Libano 1982-1984, si aggiunge ora il libro di Luca Gorgolini, professore associato presso l’Università di San Marino, che è un ulteriore tassello per la conoscenza delle vicende del contingente italiano impegnato a Beirut.
L’autore non si limita al racconto dei fatti contingenti alla missione ma, oltre ad analizzare lo sviluppo degli eventi che portarono alla scelta dell’invio delle truppe, dedica uno spazio rilevante alle origini della guerra civile libanese. Il lettore potrà quindi apprezzare quanto Gorgolini si addentri nelle complesse alchimie della fragile democrazia confessionale libanese partendo dal processo di emancipazione dal dominio francese fino allo scoppio della guerra civile che portava con sé, sullo sfondo, la questione palestinese e la presenza ingombrante di Israele e Siria. La scelta italiana di intervenire in un contesto così complicato non fu episodica ma figlia di una percezione, di un’idea che la classe dirigente aveva sempre manifestato sin dai tempi del fascismo, quella di un Mediterraneo come naturale sbocco della politica italiana, inizialmente per motivazioni di carattere economico e successivamente come una delle direttrici di un nuovo ruolo sempre più attivo in quell’area. Ruolo che l’Italia si vide riconosciuto nel corso del Consiglio europeo di Venezia del giugno 1980 con la sostituzione della Norvegia nell’Unifil e la partecipazione alla forza multinazionale nel Sinai. Due eventi che mostrarono all’estero un nuovo approccio, più interventista e che si rivelò essere l’anticamera dell’invito statunitense a partecipare alle due missioni in Libano anche senza l’egida dell’Onu.
Il Libano sembrava essere, secondo le parole di Massimo Campanini, «un vaso di coccio tra vasi di ferro» e una preda fragile di opposte ambizioni geopolitiche, e divenne palcoscenico di una missione multinazionale che avrebbe avuto l’obiettivo di restituire il controllo di Beirut alle autorità libanesi e, allo stesso tempo, assicurare lo sgombero dei combattenti dell’Olp, dell’esercito libanese della Palestina e dei soldati siriani presenti nella parte ovest della città. La prima Missione durò poche settimane e, una volta ottenuto il ritorno del pieno controllo amministrativo alle autorità libanesi, il contingente militare italiano fu imbarcato sulla via del ritorno. L’assassinio del presidente libanese Bashir Gemayel compiuto da un attivista del partito vicino alla Siria e il massacro di Sabra e Chatila perpetrato dalle forze falangiste segnarono però il ritorno dell’instabilità moltiplicando le voci che auspicavano un nuovo impegno militare per la salvaguardia della stabilità. Per quanto riguarda l’Italia, come sottolineato da Gorgolini, il ritorno del contingente militare in Libano fu percepito, da una parte non piccola dell’opinione pubblica del paese, come un’azione necessaria a tutelare il paese dei cedri dall’invasione israeliana. Le reazioni successive alla strage di Sabra e Chatila radicalizzarono la percezione di Israele come uno stato imperialista e aggressivo tanto che l’estate e l’autunno del 1982 furono caratterizzati da numerosi atti intimidatori verso le istituzioni ebraiche che culminarono nel sanguinoso attentato del 9 ottobre contro la sinagoga di Roma che portò alla morte di Stefano Gaj Tachè, un bambino di due anni, e al ferimento di quaranta persone.
Lo sbarco del secondo contingente italiano di 1,200 uomini prese il via all’alba del 27 settembre vedendosi assegnata la porzione di Beirut tra il settore controllato dai francesi a nord e quello sotto gestione statunitense a sud allo scopo di procedere alla rimozione delle macerie, alla bonifica dell’area e all’interposizione tra le forze in campo. Le forze falangiste e quelle druse, infatti, continuarono i combattimenti individuando la forza multinazionale come il nemico da abbattere: la morte di un soldato italiano nella notte tra il 15 e 16 marzo 1983 e, ancor di più, gli attentati condotti il 23 ottobre contro americani e francesi (furono uccisi poco meno di 300 soldati) segnarono il fallimento della missione che scontò la mancanza di coordinamento della Forza multinazionale che alla fine divenne, pur non volendolo, parte in campo del conflitto libanese.
Pur nella drammaticità degli avvenimenti la missione militare segnò uno spartiacque nella percezione del ruolo delle forze armate nel paese. L’iniziale sostegno unitario del parlamento, la figura del Presidente della Repubblica Sandro Pertini che in visita al contingente militare dichiarò che i soldati italiani sapevano farsi amare, così come il racconto dei mass media resero la missione come uno dei segnali di forza di un Paese che si stava lasciando alle spalle gli anni Settanta. E, ancora una volta, l’insistenza e l’emergere di una narrazione incentrata sull’umanizzazione del soldato italiano, sul suo ruolo di paciere, di soccorritore e non su quella del combattente, confermarono quanto l’Italia fosse parte di una più generale età post eroica.