

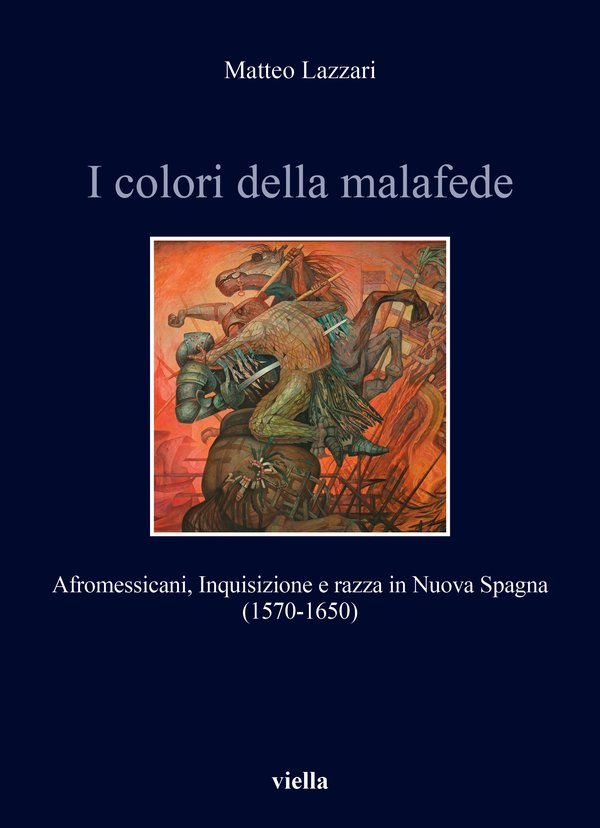
Reviewer Marco Albertoni - Università di Chieti-Pescara "G
CitationCosa rivela l’invisibilità degli afrodiscendenti nella narrazione delle radici identitarie messicane iniziata un secolo fa e ancora oggi propagandata? Gli stereotipi e i pregiudizi di un tempo sono giunti fino a noi ed è da essi che trae linfa il razzismo odierno? E se sì, quali sarebbero i passaggi intermedi? I processi dell’Inquisizione di Città del Messico possono aggiungere un tassello utile a indagare la profondità cronologica del razzismo in Messico? Sono queste alcune delle domande che sembrano dare stimolo al lavoro di Matteo Lazzari, volume che si colloca al crocevia di due tradizioni storiografiche longeve come quella degli studi sull’Inquisizione in Nuova Spagna e quella sulle genesi dei razzismi.
Apre il volume un’agile prefazione di Davide Domenici alla quale segue un’introduzione con lo status quaestionis. Pagine dense, dopo le quali il libro si presenta suddiviso in due parti: «Società, razza, Inquisizione», dedicata a un ritratto del viceregno della Nuova Spagna, e la seconda rivolta all’approfondimento di alcuni casi studio.
In un primo breve capitolo (pp. 41-49) l’autore sintetizza i caratteri della società novoispana nel sedicesimo secolo per poi tratteggiare i contorni di categorie umane di quel contesto, definite con termini quali mulatos, negros ladinos, negros criollos e negros bozales (rispetto alle quali è presente un sintetico ma pratico glossario finale). Una ripartizione che, come viene spiegato, rappresenta di per sé un tentativo degli spagnoli di classificare e gerarchizzare per meglio esercitare il proprio dominio. Categorie, si sa, del tutto inadatte a rappresentare la complessità, perché incapaci di stare al passo delle sue trasformazioni e ibridazioni. Quella in questione era del resto una realtà che in un secolo aveva subìto fenomeni sconvolgenti come entrare in contatto con l’altro, subirne il dominio (e tutto ciò che ne conseguì), nonché vedere l’approdo di altre persone, ancora diverse e ridotte in catene, direttamente dalla tratta atlantica. Categorie dunque artificiose, necessariamente vaghe e sempre imprecise, ma di certo non neutre, e soprattutto non prive di conseguenze concrete.
Nel secondo capitolo l’autore propone una genesi teorica del concetto di razza variamente inteso, provando a mettere a fuoco alcuni degli strumenti normativi che fecero da base al funzionamento sociale voluto dagli spagnoli per il territorio messicano. Dato l’intreccio di questioni che il tema del volume è chiamato a considerare, sotto questo profilo il punto di partenza dell’autore sono gli statuti della limpieza de sangre, notoriamente pensati per la reconquista della penisola iberica e sui quali negli anni si è sviluppato un lungo dibattito storiografico (Bethencourt, Schaub, Prosperi, Stolcke, Hering Torrs) che di fatto si è interrogato attorno a vari quesiti, tra cui uno centrale: è anacronistico pensare che la limpieza de sangre possa aver fatto da base per quello che oggi chiamiamo razzismo? Dopodiché Lazzari passa ad analizzare la lettura che offre dei due concetti (e non solo) il Tesoro de la lengua castellana (1611) di Sebastián Covarrubias y Orozco, per poi tornare a chiedersi se il concetto di limpieza de sangre sia stato reimpiegato, e in che modo, in Nuova Spagna, in particolare dal 1571, anno di fondazione ufficiale del Sant’Uffizio in Messico. Fu in quell’anno che si andò a sostituire l’inquisizione episcopale, istituita quasi in parallelo alla conquista del Messico (1521) o persino qualche anno prima, con singoli provvedimenti che istituivano forme embrionali e non istituzionalizzate di tribunali ecclesiastici. Va quasi da sé che il terzo capitolo ripercorra allora la storia dell’istituzione, delle funzioni, dell’organizzazione, dei crimini perseguiti, dell’iter processuale e quello delle pene instaurato dal 1571 dai tribunali dell’Inquisizione in Messico, sintetizzando in forma chiara e schematica quanto già noto grazie alla copiosa storiografia precedente, dalla quale emerge l’evidente tentativo di replicare in un contesto decisamente diverso il modello inquisitoriale già rodato da un secolo nella penisola iberica.
La seconda parte del volume è dichiaratamente volta ad affrontare una serie di casi studio (7 brevi nel quarto capitolo, più un ottavo, più approfondito, nel quinto), con una particolare attenzione al lessico usato nelle carte del Sant’Uffizio. Si presenta così, ad esempio, ciò che dai documenti rimasti si riesce ad apprendere del caso di Theresa, negra bien ladina (vale a dire in parte ispanizzata nella lingua o nella discendenza) che all’alba del XVII secolo ebbe l’ardire di usare parole oltraggiose contro l’Inquisizione di fronte a due spagnoli che stavano trasportando un terzo uomo (definito africano) verso il tribunale inquisitoriale di Città del Messico con l’aiuto di una guida “indigena” che poi fugge lasciando smarriti i due. Nella lettura dell’autore, in questo caso si riscontra peraltro «una sorta di operazione di ‘mascolinizzazioneʼ della figura di Theresa, la quale viene rappresentata e descritta dai due spagnoli come una donna spaventosa, che spinta dalla rabbia e dalla collera riesce a far scappare l’uomo indigeno obbligando così i due mulattieri a proseguire il loro cammino verso la capitale del viceregno con estrema difficoltà» (p. 103). “Mascolinizzazione” che fa il paio invece con la “femminilizzazione” dell’indigeno, attorno alla cui figura si insiste con i classici stereotipi di uomini indolenti e deboli.
In un altro caso si esamina invece l’utilizzo del termine bozal – etichetta utilizzata da spagnoli e portoghesi per indicare quegli schiavi africani giunti di recente in America – nel quale l’autore individua il germe della biologizzazione, avvenuta nei secoli successivi, del concetto di “razza”.
Si passa poi all’approfondimento che riguarda la storia e il processo dell’afromessicano “mulatto” Gaspar Riveros Vasconcelos, già noto, ma comunque riletto nell’ottica del volume. L’uomo nel 1650 fu processato e arrestato non solo perché accusato di praticare l’astrologia giudiziaria di Albumasar per casi di furto, ma anche per aver calunniato gli inquisitori e il Sant’Uffizio nel difendere alcuni giudeoconversi. Ma al di là dei comportamenti, anche le sue origini paterne lasciavano presumere che egli fosse un criptogiudeo. A questo si aggiungevano altre accuse, come quella di incesto, che è frequente trovare come calunnia pretestuosa nei processi inquisitoriali contro gli ebrei assieme a quella di omosessualità. Ma chi era costui? E quanto le sue origini influenzarono il processo? Nativo di Tangeri (1620 circa) e figlio di un uomo di discendenza portoghese e di una donna definita di “casta” Angola, Vasconcelos era un cosiddetto “creolo atlantico” che approdò a otto o nove anni assieme allo zio a Pernambuco (oggi Recife), spostandosi poi in una peregrinazione sincopata attraverso città come Cartagena de Indias, San Cristobál de la Habana a Cuba e Veracruz, per poi arrivare a Città del Messico. Un uomo dotto, che prima di incappare tra le maglie del Sant’Uffizio aveva studiato la grammatica, la retorica, l’arte, ed era nel tempo divenuto in grado di leggere il latino, oltre che parlare tre lingue. Quello di Vasconselos è un caso di tri-culturalismo – spiega l’autore – in una commistione di identità tra una, preponderante, portoghese, una minima parte angolana, e una robusta ispanoamericana.
Sottoposto a un lungo processo di cui si riportano molti dettagli e testimonianze, in ultimo la sentenza contro Vasconcelos ordinò una severa reprimenda, il bando da Città del Messico per due anni, e la minaccia di pene corporali se fosse tornato a occuparsi di astrologia giudiziaria. Una sentenza non particolarmente dura, e forse persino edulcorata, considerando che a posteriori i giudici accolsero parzialmente le richieste dell’uomo, che dopo il verdetto chiese di posticipare di qualche mese l’esilio per potersi prima rimettere dai malanni causati dalla prigionia (non fu accettata, invece, quella di restituirgli le carte sequestrategli). Ma l’aspetto centrale per la prospettiva del lavoro di Lazzari è che le carte definiscono l’imputato de mala raza de sangre infecta (p. 158). Va anche detto, però, che distinguere i piani pregiudiziali o riconoscere gerarchie di gravità delle accuse, in questo caso, è alquanto complicato, perché i giudici presumono esplicitamente anche la sua appartenenza alla nación hebrea sulla base del fatto che Vasconcelos gioiva o si dispiaceva dei successi o degli insuccessi degli ebrei portoghesi (p. 159). A complicare il quadro per una possibile valutazione, va tenuto conto della situazione politica iberica di quel periodo alla luce dell’indipendenza raggiunta dal Portogallo dalla Spagna appena dieci anni prima, concausa dell’odio degli spagnoli nei confronti della sua discendenza lusitana (oltre che ebraica). Sono problematicità di cui del resto l’autore si mostra avvertito (si vedano le considerazioni a p. 171).
Nelle ultime pagine, Lazzari trova la sponda per formulare delle considerazioni finali a partire da un episodio – minore ma significativo – avvenuto nel 2018: un’intervista su un periodico a Jorge Pérez Solano, regista del film La Negrada. Un articolo dalle cui colonne affiorano, negli occhi dell’autore ma anche in quelli del regista stesso, evidenti scorie di razzismo, problema col quale fa i conti tutt’oggi la società messicana e che chiude il cerchio rispetto alle domande iniziali.
Chiude l’opera un’appendice di tre documenti: due, già editi, relativi alla fondazione del Sant’Uffizio in Nuova Spagna, e il terzo rappresentato da alcuni estratti del voluminoso processo a Vasconcelos. Le ultime pagine sono riservate a fonti, bibliografia, glossario e indice dei nomi.
Nell’insieme, il libro riesce a muoversi nel ginepraio messicano ponendo attenzione alle tante insidie metodologiche che presenta già da principio una ricerca di questo tipo. Il lavoro appare abbastanza prudente nelle valutazioni, evitando di cadere nella tentazione di trovare scorciatoie interpretative che individuino nel lessico degli incartamenti inquisitoriali la base culturale del determinismo biologico e del razzismo scientifico dei secoli successivi. L’autore ritiene, in sintesi estrema, che sia però opportuno rivalutare l’importanza che il XVI e il XVII secolo ebbero nella creazione di quegli stereotipi e pregiudizi che avrebbero fatto da base ideologica alla teorizzazione del sistema de castas e delle ideologie razziali propriamente intese dei due secoli successivi.
Quanto alle scelte compiute nell’opera, sarebbe stato preferibile ridurre e spostare in nota le lunghe e sovrabbondanti citazioni, forse evitando anche le (peraltro rischiose) traduzioni in italiano (che seguono le trascrizioni originali) dei brani di documenti, svantaggiose anche nell’economia della lettura.
Ciascuna ricerca è frutto delle inclinazioni e delle competenze di chi l’ha condotta, e quella che ha dato frutto a questo libro tende all’antropologia storica e alla tradizione microstorica italiana. Premesso ciò, quanto alla metodologia, avrebbe forse giovato escludere molti dettagli non così essenziali per la prospettiva del volume, affrontando più casi studio (come detto, qui otto in tutto, a fronte di varie centinaia – guardando al solo arco cronologico preso in esame dal volume – presenti nell’Archivo General de la Nación, Ramo Inquisición, di Città del Messico). Per futuri sviluppi della stessa linea sarebbe forse utile irrobustire l’analisi normativa, oltre che quella giudiziaria (volendo anche quella non inquisitoriale, del resto sempre della stessa matrice coloniale), così da rendere più profondo il respiro della ricerca rispetto alle interessanti domande che si pone.