

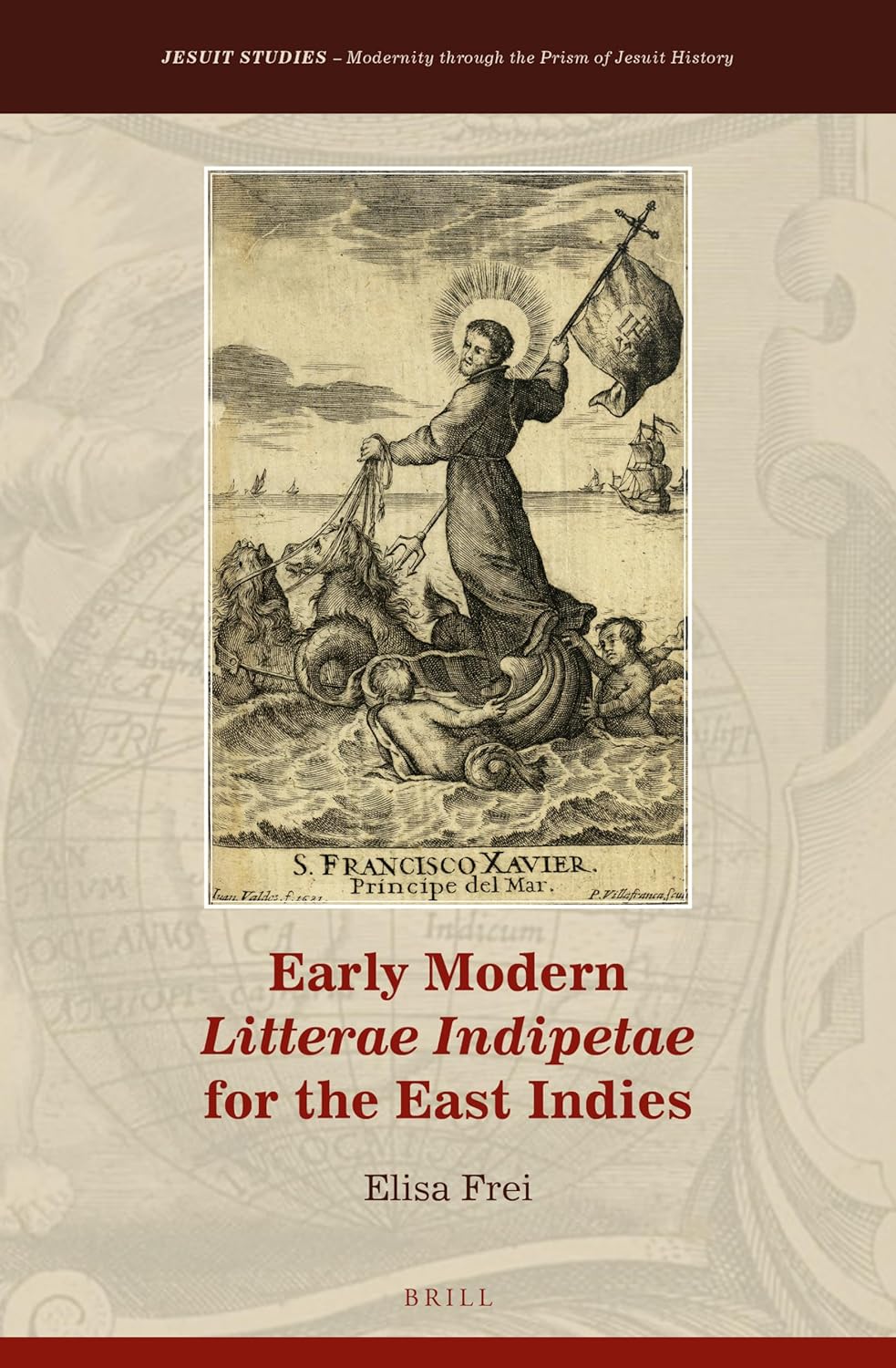
Reviewer Silvia Notarfonso - Università degli Studi della Repubblica di San Marino
CitationIl libro di Elisa Frei, Early Modern Litterae Indipetae for the East Indies, edito da Brill all’interno della collana Jesuit Studies, arriva alle stampe alla fine di un quinquennio particolarmente prolifico per lo studio delle indipetae: i recenti contributi, tra gli altri, di Pierre-Antoine Fabre, Girolamo Imbruglia, Emanuele Colombo, Camilla Russell, e della stessa Frei hanno contribuito a gettare una maggiore luce su questa tipologia documentaria, intimamente connaturata alla vocazione missionaria globale della Compagnia di Gesù. Un corpus di lettere imponente (oltre 24.000 conservate tra Roma e gli archivi provinciali dell’ordine) che, per la sua natura, ben si presta a ricerche interdisciplinari e che, auspicabilmente, incontrerà ulteriore interesse di studio nei prossimi anni anche grazie all’ambizioso progetto Digital Indipetae Database, promosso dall’Institute for Advanced Jesuit Studies del Boston College, che ha il merito di rendere disponibili digitalmente le lettere inviate al generale da gesuiti dell’Antica e Nuova Compagnia.
Cosa sono le indipetae? Il termine deriva dal latino Indias petere, chiedere le Indie, cioè i lontani territori di missione: si tratta delle lettere che gesuiti giovani e meno giovani indirizzavano al padre generale della Compagnia per essere inviati fuori dai confini europei, con l’obiettivo di servire l’ordine diffondendo la fede cattolica fra coloro che erano rimasti esclusi, sino a quel momento, dall’historia salutis. Una missione da perseguire a qualunque costo, vale a dire anche a costo della vita: il martirio costituiva anzi un orizzonte esperienziale auspicato e talvolta persino ricercato dagli indipeti o indiani, come erano chiamati i candidati alle missioni. L’idea di immolarsi per la causa diventa così un topos ricorrente nelle lettere al generale: alcune erano vergate dagli aspiranti missionari persino col sangue – come nel caso illustrato da Frei del gesuita ascolano Agostino Cappelli (1679-1715) – suggestivo espediente attraverso il quale i candidati manifestavano al generale la propria volontà di servire la causa della Compagnia fino all’ultimo respiro – o, per l’appunto, fino all’ultima goccia di sangue.
Come è stato messo in luce nelle pubblicazioni sul tema, già a partire dallo studio del critico letterario Gian Carlo Roscioni, nelle indipetae, “desiderio” è una parola chiave. Si tratta di un desiderio coltivato attraverso mesi e persino anni di preghiere e penitenze finalizzate al discernimento della propria missione. I giovani gesuiti si impegnavano cioè per mettere maggiormente a fuoco l’intenzione di prendere parte alle missioni extra europee, per alimentare ulteriormente quel desiderio di spendersi per la propagazione della fede. “Desiderio del desiderio”, per usare fuor di contesto un paradigma caro al Romanticismo tedesco: un desiderio che poteva essere persino preesistente rispetto all’entrata nella Compagnia (il cosiddetto desiderio anteriore), e infatti molti tra i candidati alle Indie dichiaravano di aver fatto ingresso nell’ordine proprio a motivo della vocazione missionaria.
In particolare, lo studio di Elisa Frei prende in esame le 1.500 lettere scritte dai gesuiti dell’Assistenza italiana intenzionati a partire per l’Asia in un arco cronologico compreso tra la seconda metà del diciassettesimo secolo e la prima del diciottesimo, durante gli anni dei generalati di Thyrso Gonzales de Santalla (1687-1705) e Michelangelo Tamburini (1706-1730).
Delle indipetae Frei fornisce da un lato un’analisi qualitativa, delineando la biografia dei candidati e il contesto famigliare e sociale – non trascurando il quadro geopolitico di riferimento – all’interno del quale, di volta in volta, le lettere sono state prodotte; dall’altro elabora e presenta però anche l’analisi quantitativa dei dati raccolti, resa visivamente attraverso i grafici in appendice, utili per definire, già a colpo d’occhio, alcune questioni: quante indipetae furono inviate a Roma dai gesuiti dell’Assistenza italiana nel periodo compreso tra il 1687 e il 1730, e più nello specifico a quale provincia appartenevano i candidati? Quanti tra gli indipeti “italiani” manifestarono una volontà specifica di partire per l’Asia? O ancora, quanti espressero un generico desiderio di servire come missionari nelle “Indie orientali” e quanti invece suggerirono una meta più circoscritta (Cina, Giappone, Filippine, ecc.)?
Il libro, che si articola in quattro capitoli, dapprima chiarisce lo scopo e la struttura delle indipetae, utilizzando un ricco paniere di documenti e mettendo in luce l’omogeneità nella forma e nella retorica che queste lettere hanno mantenuto nel corso dei secoli. Per questa ragione potrebbero essere definite una sorta di genere letterario a sé stante. Sono però anche lettere personalissime, che si sostanziano del vissuto del singolo gesuita: un tipo di componimento, allora, che risponde alle esigenze di un canone formale, ma che resta pur sempre una forma di scrittura del sé. Così, spesso tra le righe delle missive emergono ansie e preoccupazioni, il rapporto con i superiori della Compagnia, con genitori e fratelli che si oppongono all’ingresso in religione o alla partenza per le missioni, ma anche il sincero desiderio di abbandonare una vita percepita come troppo sicura per costruirne una nuova, travagliata ma intrepida, al di fuori dei confini della Christianitas.
Nell’illustrare le vicende personali dei candidati attraverso l’analisi della corrispondenza epistolare tra gli indipeti e il generale della Compagnia, Frei ricostruisce con dovizia di particolari le motivazioni, le strategie, le relazioni che questi gesuiti desiderosi di partire misero in campo per promuovere il proprio obiettivo. Il numero di lettere inviate dai candidati poteva talvolta raggiungere numeri a due cifre: è il caso, fra gli altri, del palermitano Ignazio Maria Romeo (1676-1724?), che, come riferisce l’autrice, spedì ai generali Gonzales de Santalla e Tamburini oltre trenta lettere – Emanuele Colombo ha definito questi prolifici scrittori di indipetae «indiani perseveranti». Ma, come emerge chiaramente dal volume, la corrispondenza non era l’unico espediente che i gesuiti avevano a disposizione per raggiungere e persuadere il generale: anche i colloqui orali a Roma potevano rivelarsi particolarmente utili a tale scopo, soprattutto nei casi in cui i candidati temevano che i superiori locali finissero, per ragioni diverse, con l'ostacolare la loro partenza per le missioni.
I rapporti degli indipeti con le gerarchie della Compagnia, non sempre semplici, non sempre distesi, sono oggetto di interesse del secondo capitolo, nel quale Frei insiste su tutti quei fattori che potevano favorire e avvantaggiare o – all’opposto – impedire la partenza dei gesuiti per le Indie. Per l’appunto, superiori e provinciali potevano costituire un ostacolo in tal senso, talvolta convinti dell’inadeguatezza del candidato o, all’opposto, risoluti a tenere in Italia un gesuita particolarmente stimato – un’evenienza questa, come osserva l’autrice, piuttosto diffusa in particolare nella Provincia siciliana. Non solo la famiglia spirituale, anche quella d’origine poteva però rappresentare uno scoglio per i candidati. Non di rado, infatti, genitori, fratelli e sorelle magari non sposate opponevano il proprio veto alla partenza degli aspiranti missionari, per ragioni economiche, di gestione del patrimonio famigliare o semplicemente perché preoccupati per la sorte dei propri congiunti.
Tuttavia, il desiderio di servire nelle missioni ad gentes, in territori lontani, esposti a rischi di qualsiasi sorta, difficilmente poteva essere messo a tacere, nutrito com’era da letture edificanti, da immagini, ma anche dalle preghiere e dagli esercizi spirituali che i gesuiti praticavano periodicamente. Uno degli elementi maggiormente rilevanti in tal senso erano per l’appunto le lettere dei missionari che avevano già servito nelle Indie, che costituivano una preziosa fonte di notizie, una finestra su mondi distanti e altrimenti sconosciuti ai giovani gesuiti europei. Prime fra tutte, le missive di Francesco Saverio, l’apostolo delle Indie per eccellenza, che, come ha osservato anche Emanuele Colombo nella sua recente pubblicazione sul tema (Quando Dio chiama. I gesuiti e le missioni nelle Indie, Bologna, Il Mulino, 2023), divenne una sorta di patrono degli aspiranti missionari. Spesso gli indipeti si rivolgevano proprio a lui per ottenere la grazia di veder esaudito il desiderio di partire: di questo rapporto privilegiato, fatto di preghiere e suppliche, ma anche di sogni, visioni, interventi miracolosi, si trova traccia evidente nella corrispondenza tra gli aspiranti missionari e il padre generale.
Nelle lettere, anche in quelle studiate da Frei, sono presenti per esempio anche riferimenti alle testimonianze di Alessandro Valignano (1539-1606), missionario in Cina e in Giappone, o agli scritti di Daniello Bartoli (1608-1685), uno dei più importanti storici della Compagnia. Attraverso questa variegata gamma di testi, che potevano essere fruiti individualmente oppure collettivamente – assai diffusa era la consuetudine di leggerli a voce alta durante i pasti – i membri dell’ordine alimentavano quindi il proprio desiderio delle Indie.
Nel terzo capitolo Frei ricostruisce efficacemente la rete relazionale e istituzionale entro la quale coloro che volevano partire andavano a inserirsi e con la quale dovevano necessariamente misurarsi: un network al vertice del quale troviamo senza dubbio il padre generale della Compagnia di Gesù, che, in ultima istanza, aveva la facoltà di accordare o negare al petente la possibilità di partire. Ma un network che si sostanziava anche dell’attività e delle iniziative dei procuratori che si facevano promotori in Europa delle missioni per le Indie. Entrare in contatto con un procuratore poteva voler significare – come l’autrice mostra attraverso una dettagliata analisi della casistica disponibile – una possibilità maggiormente concreta di veder esaudito il proprio desiderio di partire per le missioni ad gentes. È il caso, per esempio, di Kaspar Kastner (1665-1709), procuratore per le missioni cinesi, che favorì fra gli altri, la partenza di Agostino Cappelli, uno dei casi di studio ai quali è dedicato il quarto capitolo.
In quest’ultima parte del libro, Frei prende in esame le vicende di quattro candidati italiani per le missioni nelle Indie orientali, due dei quali, Cappelli e Ludovico Gonzaga (1673-1718), ottennero dal generale l’autorizzazione a recarsi in Cina. Agli altri due, il coadiutore temporale Carlo Sarti e Giovanni Berlendis, all’opposto, non fu invece accordato il permesso di partire.
Due esperienze, dunque, per così dire di successo, e due esperienze di fallimento con esiti differenti. Berlendis, che non riuscì mai a raggiungere l’agognato Giappone, si dedicò allo studio della teologia e ai ministeri della Compagnia fino alla morte, avvenuta a Napoli, mentre Sarti, frustrato per la mancata partenza, finì per rimpinguare le file dei cosiddetti dimessi, cioè di coloro che lasciarono l’ordine.
Come osserva l’autrice, l’enfasi posta sul desiderio di morire e patire torture, immolandosi per la causa della Compagnia, costituisce la cifra distintiva delle tre indipetae di Berlendis, che si segnalano per il particolare fervore e per la crudezza espositiva: una retorica, quella dell’orizzonte martiriale, che come abbiamo ricordato era di certo ricorrente nelle lettere dei candidati alle missioni nelle Indie, ma che diveniva così preponderante nelle missive del gesuita di Bari da risultare totalizzante e perciò sproporzionata.
Forse proprio questo elemento può aver giocato un ruolo non secondario nel determinare l’esito negativo della candidatura. Berlendis fantastica sulle torture che avrà da patire e nel cuore della notte o prima di andare a dormire – come egli stesso scrive al generale - rievoca queste truculente immagini mentali, crogiolandosi nella speranza che presto quei patimenti così vividamente vagheggiati possano realizzarsi al suo arrivo in Giappone.
Ma per le proprie vigne – e specialmente per quelle che si trovavano così lontane dalla cupola di San Pietro – la Compagnia aveva bisogno di operai equilibrati, dotati di senso della misura, perché dalla loro sopravvivenza dipendevano, in ultima analisi, la buona salute e la buona riuscita della missione. Il confine tra una ammirevole disponibilità a consumarsi santamente per la diffusione della fede e la ricerca incosciente di una morte violenta, magari evitabile, può essere, in quest’ordine di idee, più labile di quanto sembri: una questione, questa, che Frei ha messo in luce anche nelle sue ricerche su Antonio Criminali (1520-1549), controverso “protomartire” della Compagnia che perse la vita nell’India sud-orientale. Coinvolto negli scontri tra un esercito locale e i soldati portoghesi, il gesuita era andato incontro alla morte per mano delle milizie autoctone ricercandola attivamente, consegnandosi cioè spontaneamente ai propri aggressori. Una morte che se da un lato aveva suscitato subitanea devozione all’interno di alcune frange dell’ordine, allo stesso tempo aveva, per le ambigue modalità con le quali era avvenuta, sollevato non poche perplessità nella stessa Compagnia.
C'è un altro elemento di particolare interesse che emerge dalle pagine di quest’ultimo capitolo. Ricostruendo le vicende legate alla partenza e alla permanenza di Agostino Cappelli e Ludovico Gonzaga in Asia, l’autrice colloca la vicenda umana e missionaria dei due gesuiti entro la più ampia cornice della controversia dei riti cinesi e malabarici, che caratterizzò il dibattito tra Roma, la Compagnia e gli altri ordini coinvolti nelle missioni asiatiche (come francescani e domenicani) tra il XVII e il XVIII secolo. Il tema, come è noto, è stato oggetto di numerosi studi (si pensi, per esempio, alle ricerche di Nicolas Standaert, Sabina Pavone, o al volume The Rites Controversies in the Early Modern World edito da Brill nel 2018 e curato da Ines Županov e Pierre Antoine Fabre, per citare alcuni dei contributi più significativi e recenti).
Cappelli e Gonzaga avevano lasciato insieme l’Italia: mentre il secondo trascorse il resto della sua vita in Cina, il primo, dopo un periodo a Macao, poi fu destinato alle missioni del Madurai su esplicito invito del legato papale Maillard de Tournon. Un trasferimento che avvenne in un momento particolarmente delicato per la missione della Compagnia nell’impero celeste, a causa delle polemiche sollevatesi contro la strategia pastorale dell’accomodatio. Un terremoto istituzionale che – Gonzaga presagiva – avrebbe messo a repentaglio la sopravvivenza della stessa missione: anche per questa ragione il gesuita percepiva lo spostamento di Cappelli, che lasciando la Cina abbandonava una vigna particolarmente provata, come una sorta di tradimento.
Attraverso l’analisi delle lettere che Cappelli inviava ai propri confratelli dall’Asia, Frei definisce la posizione del gesuita nell’ambito della vicenda, mettendo in luce anche il rapporto tra il missionario e Tournon, la cui autorità, in quanto legato papale, secondo Cappelli, non poteva essere messa in discussione. Una riflessione che esula forse dal discorso sulle indipetae in senso stretto ma che restituisce, ancora una volta, il punto di vista di un singolo gesuita – uno fra i tanti operai attivi in prima persona nella vigna asiatica – su uno dei dibattiti più rilevanti e accesi del periodo, contribuendo a temperare ulteriormente l’idea – sempre meno condivisa dagli specialisti – di una posizione monolitica e unanimemente condivisa all’interno della Compagnia.
Si tratta di una delle opportunità più interessanti che lo studio delle vicende biografiche dei missionari, a partire proprio dalle indipetae, offre. Dialogando con la letteratura preesistente, Frei ribadisce la possibilità di usare queste lettere per ricostruire – come espressamente dichiarato nelle conclusioni del libro – non la “Storia”, ma una pluralità di storie e di esperienze individuali («not to write History, but to recount histories»), micro-casi che confluiscono però nel fiume, di più ampia portata, della storia della Compagnia, saldandosi, al contempo, con le dinamiche geopolitiche globali.