

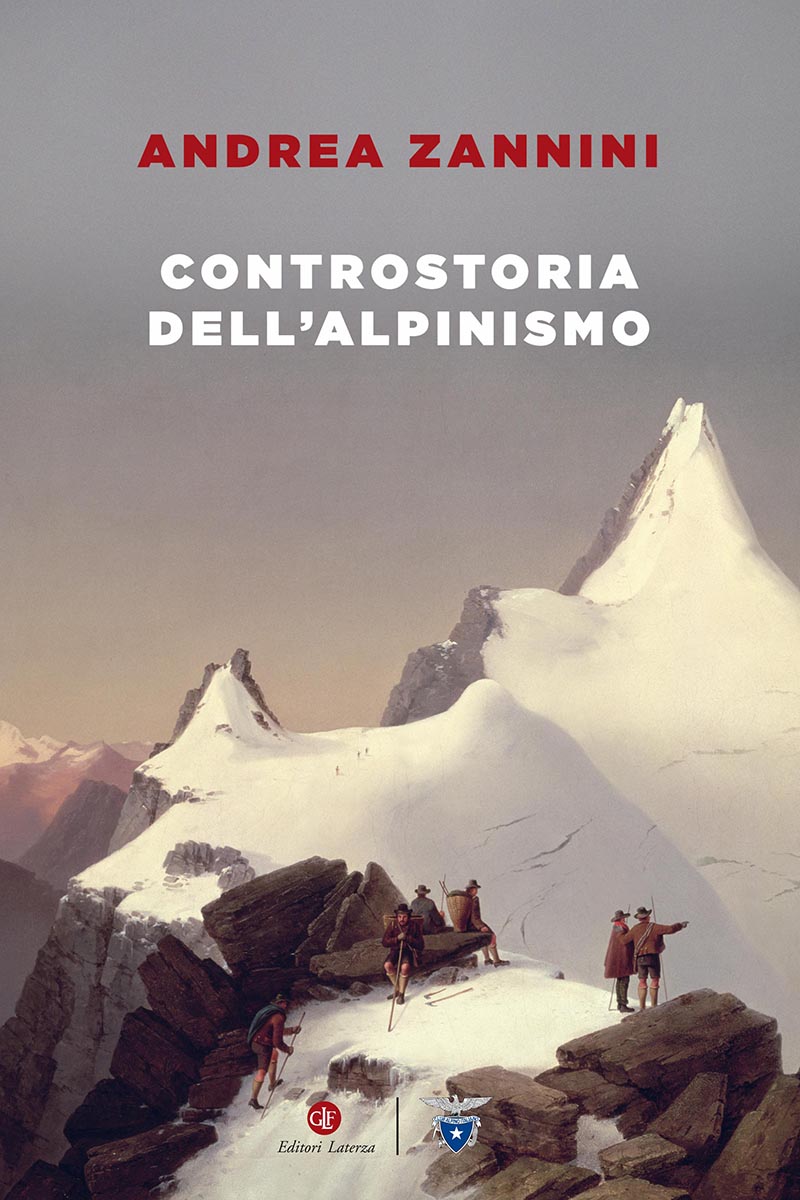
Reviewer Paolo Costa - FBK-ISR
CitationI. Monte Corno – Pareva che io fussi in aria (2024), diretto da Luca Cococcetta, è un film che coniuga documentario e fiction per raccontare una storia avvincente e, per la maggior parte degli spettatori, suppongo, sorprendente. Pochi sanno, infatti, che la cima più alta del Gran Sasso, il Corno Grande, è stata scalata da Francesco De Marchi, un esperto di fortificazioni, il 19 agosto 1573, a quasi settant’anni. L’ascesa è stata da lui stesso raccontata per filo e per segno in un resoconto inserito nel suo Trattato di architettura militare e pressoché ignorato, poi, per secoli dai suoi lettori. Sulla vetta, per altro, non era solo. Gli facevano compagnia, infatti, un cacciatore di camosci abruzzese, Francesco di Domenico, e un amico milanese, Cesare Schiafinato.
Si tratta di una piccola impresa alpinistica, ma chi l’ha vissuta in prima persona non l’avrebbe potuta descrivere come tale perché, per quanto ne sappiamo, sarebbero serviti altri due secoli perché le montagne smettessero di essere dei luoghi orridi o privi d’interesse e diventassero l’oggetto privilegiato della curiosità di una fascia privilegiata e influente della popolazione europea che inventò, per l’appunto, l’arte dell’arrampicata: la conquista dell’inutile.
Oppure no?
Che qualcosa non torni in questo modo convenzionale di inquadrare il rapporto degli esseri umani con gli ambienti montani è suggerito anche da una scena chiave del film di Cococcetta in cui, di fronte alla prima vera difficoltà e alla tentazione di gettare la spugna, non è il De Marchi bensì il cacciatore a pronunciare una delle frasi che si sentono spesso dire durante le escursioni in montagna: «Voi fate pure come volete, ma a questo punto io voglio arrivare in cima!». Strano, no? Perché mai un “montanaro” del Cinquecento, una volta intascata la cifra pattuita, avrebbe dovuto consumare un sacco di energie e mettere a repentaglio la propria vita per portare a termine un’impresa da ogni punto di vista “inutile”?
Per Andrea Zannini, che insegna storia moderna all’Università di Udine ed è l’autore del fortunato Controstoria dell’alpinismo, nella scelta del cacciatore abruzzese non vi sarebbe nulla di stupefacente. Il fenomeno che merita di essere indagato a fondo non è infatti lo slancio del di Domenico, bensì la riluttanza a riconoscere un’evidenza che da alcuni decenni sta sotto gli occhi degli studiosi più avveduti: l’alpinismo non è affatto un’invenzione moderna. È proprio per avvalorare questa affermazione che egli offre ai suoi lettori e lettrici non una “storia”, ma una “controstoria” dell’alpinismo, ossia un controcanto rispetto alla vulgata storiografica, la cui ambizione è cambiare il modo di vedere una pratica sportiva le cui origini, contrariamente a quanto si crede, non sarebbero emblematicamente moderne. Come si legge all’inizio del libro: «Il primo obiettivo di questo volume [è] dare un nome ai moltissimi (primi) salitori sconosciuti, guide e portatori che inventarono l’alpinismo, prima che dai club alpini e dalla letteratura specializzata se ne fissassero le regole, alla metà del XIX secolo […] Le Alpi e gli alpigiani si meritano finalmente una storia post-coloniale» (p. 15).
II. Quelli che stiamo vivendo sono tempi fuori dall’ordinario per storici e storiche di ogni latitudine: anni interessanti e spaesanti. Le perplessità sulle fondamenta stesse della ricerca storica si moltiplicano. I dubbi concernono in particolare il punto di vista di chi sostiene di avere i titoli per dire come sono andate veramente le cose. Si tratta di merito o non piuttosto di potere? Di conoscenza o di dominio di classe, genere o razza? Cresce in particolare l’aspirazione a raccontare le vicende umane con un intento riparativo, posizionandosi ai margini della storia ufficiale e invertendo le gerarchie tradizionali, ad esempio quella tra colonizzatori e colonizzati.
Questi sommovimenti non riguardano soltanto le vittime dell’imperialismo occidentale. Anche l’Europa, e l’Italia in particolare, hanno i loro centri e le loro periferie interne. La montagna, per esempio, è stata a lungo relegata ai margini simbolici, economici e culturali del processo di modernizzazione. Spopolate, depresse, arretrate, le terre alte sono rinate solo parzialmente nel dopoguerra come appendici ricreative delle metropoli e dei loro frenetici abitanti. Persino l’attività a prima vista più consona alla gente di montagna – l’alpinismo – è stata per secoli descritta come l’invenzione di spiriti creativi – scienziati, sportivi e artisti – provenienti dalle zone più civilizzate d’Europa. Da qualche anno, tuttavia, questo senso comune è insidiato da una nuova narrazione dei fatti incentrata sulle gesta di quanti – cercatori di cristalli, cacciatori, malgari, contrabbandieri, preti, o semplici cuori audaci – sono saliti sulle cime delle Alpi prima che la gente di pianura spiegasse loro che quelli erano posti belli e degni di essere visitati. Il libro di Zannini appartiene a questa nouvelle vague di storici incuriositi dai “controdiscorsi” o dalle “contronarrazioni” ostili al paternalismo che la gente di montagna ha dovuto sopportare con rassegnazione da quando i territori montani sono usciti dal cono d’ombra in cui erano stati confinati dalla cultura alta per secoli.
Per lo studioso veneziano le vette e la loro ascensione non sono un oggetto di studio estemporaneo. Non solo Zannini frequenta e studia le terre alte da molti anni, ma, come si legge nel suo sito personale, si è «dedicato con passione alla montagna, salendo circa 200 vie. È stato Presidente della Scuola d’Alpinismo “C. Capuis” del CAI di Mestre e Presidente della Commissione Nazionale Pubblicazioni del CAI. Ha scritto assieme a Fabio Favaretto la guida della collana Monti d’Italia Gruppo di Sella (1991). Ha decine di pubblicazioni di ambito storico-alpinistico e con Tonache e piccozze. Il clero e la nascita dell’alpinismo ha vinto il premio Leggimontagna nel 2005». Osservata contro questo sfondo, la sua Controstoria dell’alpinismo appare sia come un manifesto sia come un agile strumento di aggiornamento.
Ex negativo il libro è la confutazione teorica ed empirica della storia che siamo soliti raccontarci sulla nascita dell’alpinismo. Secondo Zannini non è vero che alla gente di montagna non era mai venuto in mente di salire sulle cime perché aveva cose ben più urgenti a cui dedicarsi e che è all’iniziativa di cultori disinteressati del vero, del bello, del giusto, cioè scienziati, artisti e idealisti, che si deve l’invenzione tra il Settecento e l’Ottocento dell’arte o pratica sportiva dell’arrampicata. L’equivoco è comprensibile, perché, come nota l’autore, «ciò che manca per ricostruire la vera storia della frequentazione normale e popolare delle cime delle Alpi è, naturalmente, la voce degli alpigiani», ma non è per questo meno grave. Per dissiparlo è necessario ricostruire la «ʽpercezione autoctonaʼ della montagna, cioè il punto di vista interno, da parte degli alpigiani, delle alte vette, che può essere contrapposto a quello esterno, dei […] visitatori occasionali di queste […] La storia dell’alpinismo popolare non può basarsi su narrazioni di prima mano: va ricostruita attraverso esili tracce» (p. 57).
La pars construens del ragionamento di Zannini parte dunque dall’assunto che qualsiasi fenomeno umano nasconde al proprio interno molte più sfumature di quante non ne affiorino se esso viene contemplato da una distanza di sicurezza. Al pari di Jon Mathieu, uno dei principali esponenti della nuova storiografia alpina, anche Zannini predilige le ricostruzioni chiaroscurali alle visioni in bianco e nero. Da questo punto di vista, l’alpinismo, anziché essere un’«invenzione della borghesia», appare piuttosto come «un’attività di loisir, di ricreazione e anche di sfida e di competizione già praticata nelle valli alpine dagli stessi alpigiani, di tutte le classi sociali, e di cui si ha notizia da molto tempo prima che le montagne fossero “visitate” da coloro che venivano dalle pianure e dalle città» (pp. 11-12). L’esempio più convincente, in proposito, è quello della caccia. Basta leggere i racconti di un montanaro “doc” come Mario Rigoni Stern, infatti, per rendersi conto che cacciare è sempre sia un’attività orientata allo scopo sia una «sfida fisica e psicologica» che in montagna può richiedere un impegno ben superiore a ciò che se ne ricava in cambio, tanto per lo sforzo atletico quanto per le difficoltà alpinistiche da superare. E in effetti, «molte delle ascensioni in età convenzionalmente considerata ʽnon alpinisticaʼ vedono protagonisti proprio coloro che, mischiando esigenze di sopravvivenza, spirito di avventura e diletto, si spingevano fino a creste e costoni per cacciare» (pp. 43-44).
Anche i montanari, insomma, potevano maturare la decisione di salire in cima alla montagna che avevano contemplato fin da bambini dalla finestra di casa, semplicemente per curiosità: per capire, cioè, che cosa si nascondesse lassù. «Il gioco, come hanno dimostrato centocinquant’anni di antropologia ed etnografia, assieme, ad esempio, alla festa, al dilapidamento dei beni o ad altri comportamenti considerati non ʽeconomiciʼ sono propri di qualsiasi società, anche di quelle basate sull’economia di sussistenza» (pp. 12-13).
Gli alpigiani, per di più, non erano affatto «genti rudi, selvatiche, briganti» (p. 41). Anzi, nei secoli avevano affinato le tecniche e inventato l’equipaggiamento necessario per fare fronte alle insidie dell’aspro ambiente montano. Come nota Zannini, «tutti gli attrezzi e le tecniche alpinistiche, almeno quelli della progressione su ghiaccio, dai ramponi agli alpenstock, alla corda utilizzata per unire i componenti della cordata e procedere in sicurezza, erano già noti ben prima dell’epopea del Monte Bianco, quando saranno definitivamente consacrati» (p. 75).
Una volta resa plausibile l’idea che gli alpigiani non avevano affatto bisogno di «stranieri» o «conquistadores», fossero essi scienziati o sportsmen, per conoscere e apprezzare il loro ambiente di vita, all’autore «basta volgere lo sguardo altrove, al di là dei consueti cliché» (p. 21) per accumulare fatti, testimonianze, congetture sulle scalate protoalpinistiche allo scopo di potenziare e rinsaldare il ritratto chiaroscurale della nascita dell’arrampicata moderna cui facevo riferimento sopra, «dilatando i tempi e rivedendo la periodizzazione» (p. 13). Ed è esattamente questo che avviene nella seconda parte del libro, là dove il ragionamento di Zannini diventa ricorsivo e meno avvincente.
III. Da un punto di vista strettamente teorico il successo dell’operazione decostruttiva inscenata da Zannini dipende dal modo in cui definiamo l’alpinismo. C’è un senso, infatti, in cui qualsiasi pratica sociale può esistere solo se è sostenuta da un immaginario che incorpori una visione dei modi più o meno corretti di svolgere la pratica stessa. Se per alpinismo si intende una pratica sociale di questo tipo è difficile dissipare l’impressione che esista uno scarto incolmabile tra l’alpinismo occasionale dei valligiani e l’alpinismo moderno, a dispetto delle evidenze empiriche che avvalorano la visione chiaroscurale. Certo, ciò che cambia è più la configurazione, il frame, entro cui si dispongono gli elementi che non gli elementi stessi. Da questo punto di vista, è verosimile che gli alpigiani vivessero qualcosa che pure erano sicuramente in grado di fare – una scalata – come un’eccezione, se non addirittura un’infrazione marginale alla regola incarnata dalla propria forma di vita. Insomma, più come un comportamento eccentrico che come un’attività di cui menar vanto.
Diversamente stanno le cose se l’alpinismo viene inteso come una capacità o un’abilità, un certo modo di “stare al monte”, in cui i confini tra escursionismo, alpinismo, arrampicata sono meno rilevanti di quanto non lo siano nell’alpinismo moderno. In questo caso, la prospettiva dischiusa dalla nuova storiografia, oltre a essere illuminante e rinfrancante, appare effettivamente come una forma di riparazione, un modo per rimediare a un’ingiustizia storica. Se per noi l’alpinismo sta a indicare una virtù, un grado di eccellenza nella relazione con l’ambiente alpino, non c’è dubbio che ai montanari spetta di diritto il primato in una simile “dignità”.
La transizione moderna dell’alpinismo da “gioco” a “spedizione” o “sport” non è tuttavia solo una metamorfosi quantitativa. E non è nemmeno un passaggio indolore, se lo misuriamo secondo il criterio della qualità della relazione umana con la montanità. C’è qualcosa di speciale nell’arrivare in cima a una montagna, senza sapere che ciò che si sta facendo è un gesto atletico che implica una “conquista”, che sembra irrecuperabile dopo la nascita delle imprese alpinistiche. Ed è un bene non facile da mettere a fuoco. Certo, anche per i più intraprendenti tra gli alpigiani giungere in vetta deve avere avuto il sapore di una sfida vinta, almeno nel senso di uno di quei compimenti che appaga il bisogno umano di chiudere il cerchio, di dare uno sbocco ai propri sforzi. In montagna, effettivamente, le cime hanno spesso la funzione di consentirti di poter dire basta: «ecco, ora puoi fermarti e tornare indietro senza frustrazione». Il gioco, d’altra parte, è anche un moto di ribellione contro l’inconcludenza dell’esistenza umana, contro il fatto, cioè, che nelle nostre vite troppe cose, compresa la vita stessa, s’interrompono piuttosto che finire. Il loisir, come nota giustamente Zannini, non è un’evasione dalla vita, ma un modo più compiuto, più gioioso di vivere l’esistenza, esattamente come avviene con la catarsi rituale.
Da questo punto di vista l’alpinismo degli alpigiani era un’attività non meno avventurosa dell’alpinismo moderno, ma era un’avventura probabilmente più diagonale che verticale. Se questo modo di riformulare la questione è corretto, il senso della discontinuità è destinato a rimanere tale e, pur nel prevalere del chiaroscuro, la tensione tra il bianco e il nero continuerà a essere ciò che restituisce il senso profondo della Grande Trasformazione moderna anche nelle terre alte.