

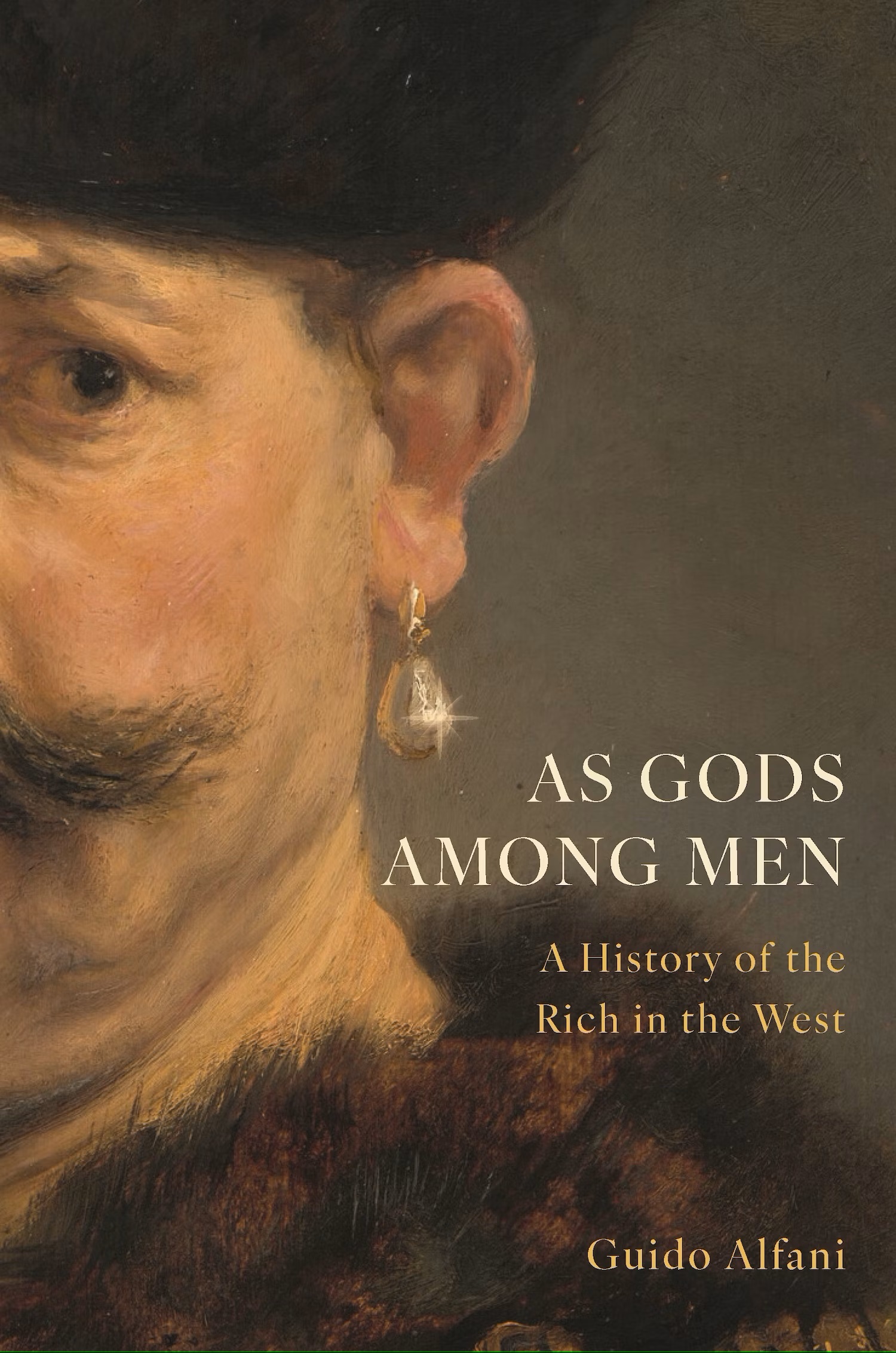
Reviewer Matteo Di Tullio - Università degli Studi di Pavia
CitationNegli ultimi anni, le ricerche sulla disuguaglianza economica e in particolare sulla distribuzione della ricchezza hanno visto una crescita esponenziale. Le diverse crisi degli ultimi decenni (e non solo quelle economiche e finanziarie) hanno certamente giocato un ruolo importante in tal senso. Gli studi prodotti, in effetti, hanno spesso posto l’accento tanto sulla possibile relazione tra distribuzione delle fortune economiche e il manifestarsi di questi eventi negativi, quanto su come questi ultimi abbiano favorito sperequazioni e polarizzazioni in termini distributivi. In buona sostanza, se fino a qualche decennio fa la ricerca economica si era interessata prevalentemente al reddito, ultimamente è la ricchezza ad essere posta sotto i riflettori. La distribuzione di quest’ultima – come hanno mostrato, ad esempio, gli studi di Branko Milanović e Thomas Piketty – infatti, ha conseguenze rilevanti non solo sui livelli di reddito, ma anche sul versante sociopolitico e sulla prevalenza di un certo modello di capitalismo.
Gli studi storici non sono rimasti esclusi da questo interesse, promuovendo diverse ricerche sia sulle società contemporanee, che relative a contesti preindustriali. A quest’ultimo ambito si è particolarmente dedicato Guido Alfani, che, grazie ai finanziamenti ottenuti dallo European Research Council, ha coordinato due pionieristici progetti di ricerca finalizzati, appunto, allo studio delle dinamiche di lungo periodo della disuguaglianza economica in Italia e in alcune regioni dell’Europa preindustriale («EINITE – Economic Inequality across Italy and Europe, 1300-1800») e al rapporto tra disuguaglianza e mobilità sociale negli stessi secoli («SMITE – Social Mobility and Inequality across Italy and Europe, 1300-1800»).
Il libro che presentiamo s’inserisce nel milieu appena richiamato e nel solco di questi progetti di ricerca, con l’obiettivo di tracciare una storia dei ricchi, non tanto come individui o gruppi famigliari, quanto piuttosto come categoria storica d’analisi. L’autore chiarisce fin da subito che il suo gruppo di riferimento si definisce solo ed esclusivamente «as a social-economic group distinguished by affluence, not on specific wealthy individuals or dynasties or on social classes (not even just on the ‘privileged’ classes) or, finally, on wealth inequality» (p. 3). Le indagini sulla storia di singole famiglie non mancano, e la storiografia, soprattutto quella marxista, ha già affrontato lo studio dei ricchi come classe sociale. Questo libro, tuttavia, vuole andare oltre i casi individuali o l’analisi di taglio sociologico, che per altro mal si adatta alle società preindustriali, per proporre un’indagine dei ricchi nel lungo periodo, fra antico e nuovo regime, definendo l’appartenenza a questa categoria in base alla ricchezza, vale a dire esclusivamente al livello di opulenza. Altresì, questo lavoro si propone di intrecciare diversi contesti geografici, per gettare uno sguardo trasversale sull’intero Occidente.
Il libro è strutturato in tre parti, composte da undici capitoli. Nella prima sezione («In the Hands of the Few») si caratterizzano i ricchi attraverso la definizione di ricchezza, qui considerata esclusivamente nella sua dimensione materiale e come patrimonio famigliare. In tal senso, dunque, si assume la famiglia come unità d’analisi e si esclude la ricchezza immateriale dalla composizione del patrimonio. Si tratta ovviamente di questioni complesse, che lo stesso autore discute nel libro, e che tuttavia non inficiano la solidità della ricerca, né la validità degli argomenti proposti. Nel volume, dunque, si definiscono i ricchi come coloro che possiedono grandi patrimoni, che si collocano al vertice della distribuzione delle fortune di una data società (il 5% più facoltoso della coorte osservata) e che superano di gran lunga (dieci volte) il livello medio di ricchezza dei soggetti inclusi nell’analisi. Per definire i contorni di questo gruppo nel lungo periodo, perciò, si presentano le dinamiche plurisecolari della disuguaglianza di ricchezza e della prevalenza dei ricchi nelle società occidentali, in alcuni casi risalendo fino al XV secolo. Il quadro che si ottiene è una generale tendenza alla crescita della disuguaglianza, interrotta da sporadiche fasi redistributive dovute a violenti shock che colsero impreparate società ed élites.
La seconda parte («The Paths to Affluence») si occupa di ricostruire i percorsi che hanno favorito l’accumulazione di grandi ricchezze. Per fare ciò, in prima istanza, si prende in esame la relazione tra grandi patrimoni e status nobiliare. È evidente che non tutti i nobili fossero ricchi, né che i ricchi fossero necessariamente titolati. Così come è chiaro che l’eredità di una fortuna non è garanzia del suo mantenimento nel tempo. La ricezione di un cospicuo patrimonio, però, aumenta notevolmente le proprie chances di entrare nel club dei ricchi ed è dunque evidente che spesso si producano processi di riproduzione dei vertici socioeconomici anche in funzione della diversa condizione di partenza.
Resta il fatto che, pur essendo in alcuni periodi e contesti limitata de jure o de facto, la mobilità sociale possa scombinare il quadro, cambiando le fortune individuali, in ascesa così come in direzione opposta. La mobilità ascendente è presa in esame nel capitolo intitolato «On Innovation and Technology», dove si analizzano in particolare le opportunità messe a disposizione dall’innovazione tecnologica o garantite da peculiari capacità imprenditoriali. Richiamando una dinamica schumpeteriana, il libro propone una lettura delle principali congiunture storiche che, fra tardo medioevo e contemporaneità, avrebbero creato le condizioni favorevoli all’ascesa di businessman innovatori, capaci di accumulare grandissime ricchezze. Gli esempi proposti spaziano dai mercanti-imprenditori delle città medievali agli innovatori dell’era informatica, passando per gli agenti del commercio internazionale proto-globalizzato d’età moderna e i magnati dell’industria pesante ottocentesca.
Oltre alla manifattura e al commercio, un altro potente canale di ascesa e di costruzione di grandi patrimoni è la finanza; anche se spesso i confini tra questi ambiti economici sono molto sfumati. Del resto, non diversamente da chi agisce prevalentemente in altri settori, anche le caratteristiche degli arricchitisi o dei già ricchi che agiscono nel campo finanziario possono adattarsi, mutatis mutandis, tanto alle società medievali, quanto a quelle contemporanee. Ad esempio, un po’ in tutte le epoche i grandi patrimoni finanziari destano un certo sospetto rispetto alle ricchezze accumulate altrimenti.
Definiti i possibili percorsi di creazione dei patrimoni, la seconda sezione si conclude con due capitoli destinati ad analizzare le pratiche di consumo e di risparmio («The Curse of Smaug: The Saving and Consumpion Habits of the Rich») e alla ricostruzione della prevalenza di fortune ereditate o create nelle diverse fasi storiche prese in esame («Making It to the Top: An Overview»).
La terza parte del volume è dedicata invece al ruolo dei ricchi nella società. Nello specifico si affronta anzitutto la persistente diffidenza dell’Occidente nei confronti dei ricchi e la difficoltà a concepire per loro un ruolo specifico e positivo. L’eccessiva ricchezza, al contrario, è considerata dannosa, almeno da una parte della società, perché i troppo facoltosi potrebbero garantirsi facilmente una posizione di privilegio politico, oltre a quello socioeconomico, incompatibile con forme di governo democratico o con il benessere collettivo. Forse anche per queste ragioni, i ricchi hanno tendenze di magnificenza, vale a dire a porsi come patroni di grandi opere; una propensione che tra età moderna e contemporanea ha teso a trasformarsi in munificenza e filantropia, con tutte le conseguenze del caso. Si entra così in questioni estremamente rilevanti e fortemente attuali, che toccano il rapporto tra ricchi, o meglio super-ricchi, e politica e quello del comportamento dei più facoltosi nei periodi di crisi. In quest’ultima parte del volume, muovendosi nel lunghissimo periodo che va dalla peste nera del Trecento alla pandemia di Covid-19, si analizzano i comportamenti di gestione e conservazione dei patrimoni, così come il diverso contributo loro richiesto (e concesso) per far fronte alle difficoltà generali.
Quello di Guido Alfani è un libro estremamente ricco, per alcuni versi denso, ma che si legge con piacere e facilità, grazie alla scrittura fluida e alla capacità di tratteggiare affreschi sempre nitidi. Le questioni studiate sono di grande rilevanza e affrontate con pertinenza e competenza per i diversi periodi storici presi in esame. Anzi, la scelta di leggere questo tema nel lungo periodo, pur prestando il fianco a qualche inevitabile semplificazione, appare molto convincente. L’ermeneutica del fenomeno proposta e la definizione delle sfide passate e presenti connesse alla relazione tra ricchi e società non sarebbero state possibili altrimenti, né avrebbero avuto la solidità che hanno. La narrazione, del resto, si muove su basi stabili, con numerosi e pertinenti esempi portati a sostegno dell’interpretazione generale. Insomma, As Gods Among Men è un libro certamente importante per spessore culturale e per le riflessioni che offre, tanto agli studi storici, quanto più in generale al dibattito pubblico.