

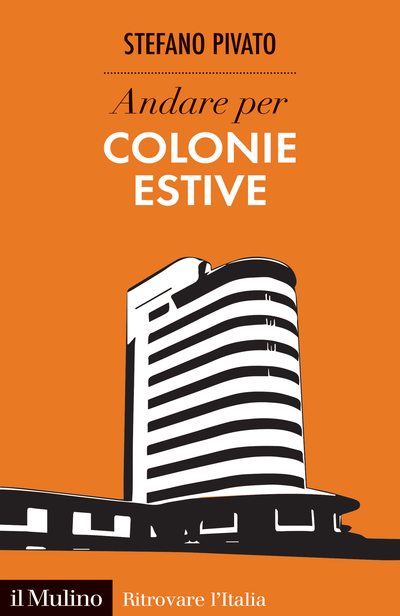
Reviewer Giorgio Lucaroni - FBK-ISIG
CitationPubblicato nella fortunata collana del Mulino Ritrovare l’Italia, Andare per colonie estive rappresenta l’ennesima dimostrazione di come, anche in ambito storiografico, si possano coniugare scorrevolezza narrativa e rigore scientifico, piacere della lettura e rispetto delle fonti. Mescolando abilmente memoria, estetica, politica ed economia, il volume offre uno sguardo panoramico sulla storia delle colonie estive proponendo un’indagine riccamente illustrata, geograficamente estesa, cronologicamente esaustiva. Oggetti architettonici non di rado di pregevole fattura, le colonie sono introdotte dall’autore come dei veri «monumenti parlanti del Novecento», custodi di una vicenda collettiva che si dipana dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta del XX secolo.
Suddivisa in sette capitoli, l’opera si presenta dunque come una storia della nazione per altre vie, un racconto a più voci centrato sul ruolo dell’infanzia, sulle pratiche educative, sui processi di costruzione identitaria tra età liberale, fascismo e Repubblica. Nate a cavallo tra i due secoli in una logica curativa e igienico/positivista, le colonie si evolvono fin dai primi anni Venti in strumenti di controllo e propaganda, spazi pensati per modellare i giovani e le giovani del regime. Che si tratti di strutture marine, montane, fluviali o lacustri, esse si diffondono come un prolungamento della formazione scolastica, spazi non soltanto sociali ma politici e per questo gestiti direttamente dal Partito Nazionale Fascista, dall’Opera Nazionale Balilla e, infine, dalla Gioventù Italiana del Littorio. In gran parte sopravvissute al secondo conflitto bellico e moltiplicatesi grazie all’interesse dell’assistenzialismo cattolico, e in particolare della Pontificia Commissione di Assistenza, le colonie preservano nell’Italia repubblicana una marcata impronta pedagogica declinata non più in seno alla disciplina e al cameratismo fascisti ma alla morale cristiana. Delle colonie si interessano anche grandi gruppi industriali fiduciosi di sottrarre al mutuo soccorso, ai partiti e al sindacalismo il tempo libero della classe operaia. Abbandonate tra gli anni Sessanta e Settanta quando verranno soppiantate dal turismo familiare e da una filosofia educativa ribaltata dal ’68, le colonie risaltano sulle coste e nelle valli italiane come rovine di un tempo perduto, patrimonio immobiliare ma anche memoriale che soltanto oggi pare ricevere inedite attenzioni sia da parte della storiografia sia da parte delle istituzioni.
Attingendo a fonti orali, diari, studi scientifici e rimandi agli immaginari cinematografici, sonori, sportivi dell’Italia novecentesca, Pivato conduce il lettore in un itinerario a tappe scandito da architetture futuristiche, grandi palinsesti naturali e artificiali, testimonianze. In prima battuta, l’autore si concentra sul litorale romagnolo ricostruendo l’intensa opera di edificazione promossa dal regime fascista. Nelle terre natali del duce, il volume individua decine di strutture contraddistinte dal forte impatto scenografico e dai chiari riferimenti politici: la forma a M, la torre littoria, le intitolazioni ai gerarchi, a Mussolini stesso e ai suoi familiari. Pur accantonando questa matrice monumentale, la sovrapproduzione edilizia sulla costa adriatica prosegue lungo tutti gli anni Cinquanta divenendo motivo di dibattito fra il fronte delle sinistre e la componente cattolica prima di subire l’avvento della villeggiatura come fenomeno di massa e il conseguente declino del soggiorno in colonia come necessità, bisogno privato ma anche pubblico.
Spostandosi verso ovest, Pivato indaga poi il versante tirrenico soffermandosi sulla storia del Calambrone, colonia/città nata dalla bonifica del parco di San Rossore e nota per le sue ardite progettazioni architettoniche in gran parte riconvertite in resort di lusso. Al singolo caso di studio del Calambrone, il volume fa seguire un’analisi più estesa sulla Versilia, terra votata a un turismo più elitario e sede del maggior numero di strutture edificate tra le due guerre. Vittime del passaggio del fronte durante il secondo conflitto bellico, le colonie tra Lucca e Massa Carrara formano oggi una sorta di «Spoon River» monumentale fatta di rovine e paesaggi naturali compromessi.
Proseguendo verso Nord, l’autore ripercorre le vicende delle colonie liguri evidenziandone la scarsa originalità architettonica e la pochezza di esempi. Fa eccezione la «Fara» di Chiavari – presente sulla copertina del libro – torrione futuristico inaugurato dallo stesso Mussolini e recentemente riconvertito in lussuosa residenza alberghiera. Valicato l’Appenino, il volume si confronta invece con le colonie montane. Poco praticate da un regime che propaganda il culto del corpo e della massa, le strutture montane si diffondono nel secondo dopoguerra beneficiando del pontificato del papa alpinista Pio XI. Lontano dalle sconcezze della vacanza marina, il soggiorno montano esalta lo spirito e l’esperienza religiosa proponendo un modello morale e pedagogico coerente con la militanza cattolica. Attraversando l’arco alpino, Pivato riporta alla luce le strutture erette in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto offrendo un focus specifico sulle colonie finanziate da grandi aziende quali la FIAT, l’ENI, la Olivetti e la Marzotto. Il singolo caso di studio torna nel sesto capitolo dedicato a Cremona e alle colonie fluviali promosse da uno dei gerarchi più potenti del regime: Roberto Farinacci. Edificate in tutta la provincia, le colonie cremonesi si presentano come costruzioni provvisorie, baracche in legno prive di camerate perché pensate per un soggiorno diurno. Un patrimonio immobiliare in gran parte perduto se si eccettuano le strutture in stile razionalista progettate da Carlo Gaudenzi oggi riqualificate in centro ludico ricreativo. Abbandono e incuria segnano la storia delle colonie nel centro Sud raccontata nel capitolo conclusivo. Erette in misura nettamente minore rispetto ai litorali toscani e romagnoli tanto dal regime quanto dall’Italia repubblicana, le colonie risaltano nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio, in Puglia, in Calabria e nelle isole come cattedrali nel deserto, ennesima attestazione di una questione meridionale che coinvolge anche la vicenda coloniale. Pur nella sua brevità, il volume offre dunque un quadro esaustivo e articolato su una storia ricca di ramificazioni, ancora oggi poco approfondita sul versante dei soggetti e delle istituzioni. Che il viaggio di Pivato possa essere allora di buon auspicio.