

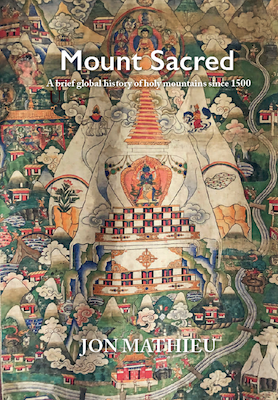
Reviewer Paolo Costa - FBK-ISR
CitationDa alcuni anni circola in Italia una proposta intitolata «Una montagna sacra per il Gran Paradiso». Nata per onorare i cent’anni dell’omonimo Parco Nazionale e sostenuta, tra gli altri, dal Club Alpino Italiano, dall’Alpine Club di Londra, e da nomi prestigiosi dell’alpinismo e della letteratura di montagna come Kurt Diemberger, Hervé Barmasse, Manolo, Enrico Camanni, Paolo Rumiz, Paolo Cognetti, Matteo Righetto. L’iniziativa si è posta l’obiettivo di sottrarre almeno una cima dell’arco alpino (nel caso in questione, il Monveso di Forzo) dalle brame di conquista degli esseri umani, spingendoli così a riscoprire il significato del limite.
Il carattere puramente simbolico di questo gesto, all’apparenza anacronistico, di «sacralizzazione» di un lembo del paesaggio è riconosciuto esplicitamente e persino rivendicato dai suoi promotori, che ne difendono nondimeno la valenza rivoluzionaria per una civiltà, cito le loro stesse parole, «avida di performance e povera di spirito» come quella occidentale tardo moderna.
Non è facile, tuttavia, capire che cosa possa significare sacralizzare una montagna in una società che viene comunemente descritta come ampiamente secolarizzata. Non stupisce, perciò, che i sostenitori del progetto si siano affrettati a sottolinearne il carattere «laico» (finalizzato cioè alla riverenza e alla contemplazione, non alla venerazione) e non «costrittivo» (senza, cioè, alcun divieto formale o sanzione). L’obiettivo, se capisco bene, è promuovere nuovi tipi di desiderio e, con essi, una diversa gerarchia dei valori nelle persone che, in numero sempre crescente, frequentano le località montane con intenti ricreativi.
Sono proprio fenomeni culturali del genere, allo stesso tempo familiari e opachi, che rendono prezioso il lavoro di studiosi scrupolosi come Jon Mathieu, professore emerito dell’Università di Lucerna, che da anni si occupa di storia delle Alpi e, più in generale, indaga i significati antropologici, economici, sociali delle terre alte in Europa e fuori dall’Europa.
Mount Sacred è la versione inglese di Mount Sacred. Eine kurze Globalgeschichte der heiligen Berge seit 1500 (Wien, Böhlau, 2023). Come chiarisce il sottotitolo, non si tratta di un libro voluminoso, ma di un’agile panoramica che, con una scelta stilistica che entra spontaneamente in risonanza con il proprio oggetto di studio, accompagna chi legge in un tour d’horizon che tocca i cinque continenti e alcune delle montagne sacre che ne hanno segnato la storia negli ultimi cinquecento anni.
La domanda che scandisce come un basso continuo la carrellata di Mathieu potrebbe essere formulata così: «Ok, le montagne stanno a cuore a molte persone oggi, ma quanto è giustificato il ricorso al lessico religioso per rendere ragione di questa passione?»
Facendo suo un celebre suggerimento di Ludwig Wittgenstein, per rispondere a questo quesito l’Autore si propone anzitutto di arricchire la nostra dieta di esempi. A questo scopo si mette sulle tracce di casi anche molto diversi di sacralizzazione delle terre alte che vanno dalle pratiche più tradizionali (i riti montani tibetani o le iscrizioni rupestri sullo Tai Shan) alle smaccate invenzioni teologico-politiche (i montagnards della Rivoluzione francese o la venerazione atea del monte Paektu nella Corea di Kim Il-sung), passando per i dolorosi conflitti identitari suscitati da processi storici traumatici come la secolarizzazione o il colonialismo (la polemica sulle croci di vetta sulle Alpi o la restituzione tardiva di montagne sacre agli indigeni d’America o Australia).
A quali conclusioni giunge Mathieu lungo la via? Parlando in generale, accumula più dubbi che certezze. Le sue genealogie del sacro in montagna sono quasi sempre ambivalenti, se non volutamente ambigue. Per prima cosa, il lettore viene ripetutamente sollecitato a prendere atto di una circostanza ben nota a chi si occupa di questioni ontologiche. Anche se a chi le frequenta abitualmente possono sembrare realtà, per così dire, autoevidenti, le montagne non sono affatto oggetti esperienziali immediati. Così, a seconda dei contesti un’altura può diventare o passare per sacra semplicemente perché è un luogo remoto e di difficile accesso (si pensi al monte Athos o alle Meteore per la tradizione monastica ortodossa) o più banalmente perché funge da ricettacolo di una pluralità di siti sacri (come capita in Africa sulle pendici del Kilimangiaro o in Australia intorno al monte Uluṟu). Un altro importante confine che sfuma mano a mano che l’Autore procede nella sua escursione storica è proprio la frontiera che divide il sacro dal profano – confine che tende a irrigidirsi nelle situazioni di conflitto, mentre è particolarmente fluido nelle fasi aurorali o nei periodi di transizione o codificazione di una tradizione.
In questo senso, mentre si metabolizza l’«ammonimento contro le incaute canonizzazioni» (p. 93), si viene spinti a prendere nota del residuo di contingenza che si sedimenta in qualsiasi attribuzione umana di valore non negoziabile – incluse quelle apparentemente meno antropocentriche. Per rendersene conto basta provare ad articolare l’intuizione, che si trova in forma solo embrionale nel libro, secondo cui la «Natura» può rappresentare un oggetto di particolare interesse solo entro una cornice religiosa creazionista, dove cioè viene sottolineato il carattere soprannaturale della divinità. Si può apprezzare così meglio il paradosso insito nelle proposte di chi suggerisce di sacralizzare le montagne come antidoto «spirituale» alla profanizzazione e conseguente strumentalizzazione della «Natura» favorite dalle religioni abramitiche.
Ridotto a una sola frase, il principale insegnamento che si può ricavare dall’opera di uno studioso che, in virtù della sua lunga frequentazione con la storia, ha un senso acutissimo della densità e indeterminatezza delle vicende umane, è che Mount Sacred, se esiste, non è alle nostre spalle, ma si staglia di fronte a noi come una possibilità sempre aperta, ma dall’esito incerto, di dare forma all’intuizione vaga che non possa essere tutto «qua».