

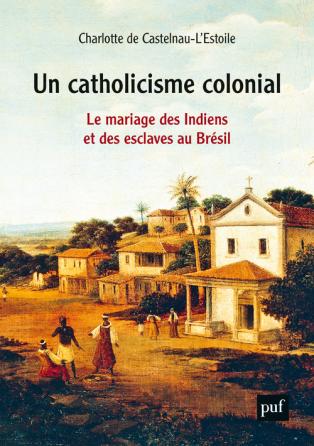
Reviewer Fernanda Alfieri - Università di Bologna
CitationDa alcuni anni a questa parte la storiografia ha posto in evidenza la crucialità del matrimonio per la regolamentazione delle società, e ha riconosciuto l’importanza del suo studio per la comprensione delle tensioni che le abitano. Il lavoro di Charlotte de Castelnau-L’Estoile conferma mirabilmente la rilevanza euristica della ricerca sull’istituto che da secoli, attraverso una normativa tesa fra tradizione e adattamento alle spinte del tempo, regola i rapporti all’interno della cellula sociale ritenuta originaria, e, con essa, condiziona gli equilibri sottili e in costante riassetto fra istanze individuali e comunitarie, religiose e secolari, materiali e immateriali. Volontà personali, interessi familiari, legami fra soggetti e gruppi, patrimoni, norme giuridiche e morali, istituzioni chiamate ad applicarle: tale è la posta in gioco nel farsi e disfarsi di un matrimonio da offrire a chi lo osserva una lente prismatica che forse non ha eguali per capacità di penetrazione e restituzione della complessità dei rapporti umani e dei contesti nei quali questi si giocano e si determinano.
L’oggetto di studio di Un catholicisme colonial è il matrimonio delle popolazioni originarie del Brasile (termine che, nella documentazione dell’amministrazione ecclesiastica da cui lo studio prende avvio, indica dal 1551 le terre d’America sotto il patronato del re del Portogallo) e delle popolazioni che fra XVI e XVIII secolo in quelle terre sono giunte come colonizzatrici o vi sono state forzosamente tratte. Siamo dunque nel pieno dell’organizzazione di una società coloniale basata sullo sfruttamento schiavista e del radicamento di un cattolicesimo romano che tenta di adattarsi alle peculiarità d’oltremare. A lungo la Chiesa, dalle gerarchie romane alla base locale, ha vissuto la situazione coloniale come uno stato temporaneo d’eccezione, nell’attesa fiduciosa di una stabilizzazione. In materia di normativa matrimoniale, focus principale dello studio di Castelnau-L’Estoile, questo ha dato vita a una sorta di laboratorio di sperimentazione di forme giuridiche che qui sono osservate nel loro prodursi e nel loro applicarsi a un mondo, popolato da amerindi, portoghesi e africani giunti come schiavi, che si costituisce in società. La storiografia ha per lungo tempo ricondotto il nucleo della formazione socioculturale del Brasile nell’organizzazione della casa-grande (la grande casa del padrone) e della senzala (la zona della proprietà dove alloggiavano gli schiavi) al cui vertice si situava il padrone-patriarca-proprietario che abusava arbitrariamente dei corpi delle proprie schiave, sotto lo sguardo condiscendente di gesuiti pronti a giudicare il tutto con una morale indulgente (così il classico dell’antropologo e storico Gilberto Freyre, Casa-Grande e Senzala, 1933). Come mostra Un catholicisme colonial, è invece soprattutto il matrimonio cristianamente inteso, inculcato da un clero impegnato nella conquista di anime e corpi, a plasmare le fondamenta della società coloniale brasiliana, e non tanto quella combinazione fra concubinato, poligamia e sfruttamento sessuale, con la complicità di un clero opportunisticamente morbido, illustrata dalla ricostruzione di Freyre. Si trattava, da un lato, di tentare di mantenere le caratteristiche essenziali del matrimonio cristiano (consensuale, monogamico, indissolubile, sacramentale); dall’altro, di adattarlo a unioni fra soggetti di diverse provenienze e appartenenze religiose (coloni che si univano a donne indigene, per esempio), oppure sottoposti loro malgrado a sradicamenti continui dalle loro terre d’origine e dalle loro famiglie, e a nuovi temporanei radicamenti (uomini e donne resi schiavi). Di questi ultimi si aggiunga che il loro stato status di persona non era riconosciuto su un piano giuridico, mentre lo era su un piano spirituale: se lo schiavo, infatti, non può disporre di sé, tuttavia è un essere umano dotato di anima, quindi da salvare (così come è da salvare l’amerindio idolatra, o il colono cristiano che vive nel peccato del concubinato). In un unico soggetto coesistono assenza di diritti su un piano civile (che escluderebbero lo schiavo dalla stipula di qualsiasi contratto, poiché prevede l’espressione di una volontà propria), e diritto alla salvezza su un piano ultraterreno (cui tutti, figli di un unico Dio, devono accedere). Questa compresenza pone un problema nuovo agli apparati ecclesiastici. Mancano, infatti, precedenti sufficientemente rilevanti sul piano giurisprudenziale nella storia del matrimonio europeo, la cui normativa molto deve al calco romanistico, ridimensionato dalla cristianizzazione medievale dell’istituto coniugale. Se il matrimonio romano escludeva gli schiavi, in quanto non soggetti di diritto, quello cristiano aspirava ad includere invece ogni essere umano, a condizione dell’osservanza di determinate condizioni (che fosse tra due individui di sesso diverso, al di fuori della cerchia immediata di parentela, requisiti fondamentali e indiscutibili di diritto naturale e divino). Soggetto a una crescente risignificazione religiosa, dal XII secolo il matrimonio entra stabilmente nel novero dei sette sacramenti, giocando un ruolo essenziale nell’economia della salvezza dell’anima, oltre che nell’economia delle cose. La prima normativizzazione sistematica da parte della Chiesa del matrimonio, realtà governata fino ad allora in primis dagli interessi di famiglie e clan, la contestuale produzione di un corpus ad hoc e di apparati di giustizia che lo applicassero, si è svolta nel quadro di una dinamica di accaparramento del monopolio della giurisdizione dell’istituto matrimoniale da parte delle autorità ecclesiastiche, e, con esso, del controllo della società. Come hanno mostrato gli studi di Georges Duby, evocati dall’autrice come riferimento insuperato per una storia sociale del matrimonio, fra XI e XIII secolo il matrimonio è stato infatti lo strumento tramite il quale la Chiesa ha tentato di imporre una visione cristiana del mondo e del suo ordine. Così, aggiunge Castelnau-L’Estoile, è avvenuto nella prima età moderna in contesto coloniale. E se ciò è stato possibile, è perché il matrimonio è dispositivo estremamente flessibile, concetto di lunga durata che tende ad uniformare in un unico modello la varietà inafferrabile delle relazioni umane, e al contempo pratica sociale applicata alla contingenza, capace di fare entrare le condizioni di vita più disparate nel suo schema. Lo schema astratto del matrimonio, a sua volta, si adatta infatti alle contingenze storiche e ambientali più specifiche (e qui il riferimento dell’autrice è il Reinhart Koselleck de L’Experience de l’histoire, Paris, 2017).
La messa a fuoco di un’area geografica come il Brasile coloniale, vista l’epoca considerata e i soggetti protagonisti delle vicende ricostruite, implica necessariamente un allargamento dello spazio di osservazione, che arriva ad assumere una dimensione globale. Non solo perché il Portogallo è punto di partenza dell’azione colonizzatrice e centro delle istanze di governo dei territori conquistati, non solo perché atlantica è la dimensione della tratta di esseri umani messi in schiavitù, non solo perché romana è la sede delle congregazioni cattoliche deputate al governo delle anime dei coloni e dei colonizzati, ma anche perché è messicano, indiano, cinese, il repertorio di esperienze acquisite dalla Chiesa missionaria che i membri del clero – europei, attivi in Brasile – utilizzano come riferimenti di orientamento.
Gli attori in campo sono, da un lato, le decine di uomini appartenenti al clero missionario e secolare operante in loco, che dal loro arrivo nella metà del XVI secolo tennero con Roma un rapporto di informazione e al contempo di richiesta di legittimazione delle prassi messe in atto in quelle terre incommensurabilmente lontane, ma non a tal punto da impedire la costruzione di un sistema di amministrazione burocratizzata del destino materiale e spirituale di migliaia, milioni di esseri umani; dall’altro, uomini e donne oggetto di questo imponente investimento di forze che il matrimonio, dispositivo di conversione e cura spirituale, contribuì ad assoggettare a un sistema governato da interessi che andavano ben oltre la salvezza delle anime. Un sistema coloniale di sfruttamento delle risorse materiali e umane, disponibili in loco e importate, trovò nella Chiesa di Roma e nei suoi emissari un agente di legittimazione e rafforzamento. Ovviamente, la questione non è nuova alla storiografia. Ma quello che, fino ad ora, mancava di uno studio dettagliato è l’intreccio di corrispondenze, relazioni, giornali di viaggio, suppliche, sentenze di processi matrimoniali, decisioni pontificie, ricostruito con passione fra biblioteche e archivi di Évora, Roma e Rio de Janeiro, che da un capo all’altro del mondo conosciuto, ha normato l’uso dei corpi di una massa indistinta di individui dotati, così, di una rilevanza senza precedenti agli occhi delle autorità preoccupate delle loro anime. Oggetto di cura spirituale (come già l’autrice aveva fatto emergere dallo studio precedente dedicato alla conversione degli schiavi, Les ouvriers d'une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil (1580-1620), 2000) e, insieme, di strumentalizzazione. Si pensi, una fra le molte decisioni pontificie prodotte sulla scorta delle sollecitazioni dei missionari locali, alla bolla Romani Pontificis providentia di Pio V (1571), che autorizzava i neofiti poligami a tenersi una delle mogli che si battezzasse con loro, anche se non era la prima moglie, a prescindere da quanto affermasse la dottrina precedente, e insieme, affermando la superiorità indiscutibile del potere apostolico sulle terre missionarie: una «veritable déclaration de tout-pouissance pontificale», afferma l’autrice (p. 108). Gregorio XIII avrebbe operato un parziale ritorno alla tradizione. Facendosi, ancora, latore dell’istanza dei missionari operanti con gli schiavi in Brasile, concedeva che gesuiti e ordinari potessero dispensare gli infedeli sposati, soprattutto maschi, provenienti da Angola, Etiopia e Brasile. Separati dal primo coniuge in quanto prelevati dalle loro terre o venduti ad altro padrone, una volta convertiti potevano risposarsi senza essere obbligati a dargliene notizia e a sondare la sua disponibilità a convertirsi a sua volta. E il nuovo matrimonio sarebbe rimasto valido, anche qualora si fosse scoperto che il primo coniuge, rimasto magari nel continente d’origine, si era convertito. Salva l’anima dello schiavo, salva l’anima degli attori in gioco nella sua compravendita, non più responsabili di una sua condotta morale fuori dagli schemi della legittimità coniugale. Lungo tutto il Seicento i pontefici avrebbero continuato a produrre normativa in materia di matrimonio ad hoc per le terre di nuova evangelizzazione, interpretando con elasticità la nozione di matrimonio cristiano e concedendo licenze al clero attivo in loco. Ma la storiografia negli ultimi anni ha teso a dare attenzione anche agli aspetti di iniziativa attiva nelle vicende degli individui resi schiavi e voce alla loro soggettività (si veda il bel libro della stessa autrice, Páscoa et ses deux maris: une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, 2019). Ecco allora, fra le carte della Congregazione de Propaganda Fide, allegata alla lettera di un gesuita italiano del 1708, una supplica scritta dai membri della «Confraternita del Rosario dei Neri» di Salvador de Bahia, riconosciuta dalla Corona negli anni Ottanta del secolo precedente, che chiede al pontefice di emanare una bolla che punisca con la scomunica i padroni che si oppongono al matrimonio cristiano dei loro schiavi. Gli scriventi, «servi etiopes» di entrambi i sessi (p. 338), lamentano che i loro padroni li forzano al celibato costringendoli a vivere nel peccato. Al di là della preoccupazione per le conseguenze morali di un mancato matrimonio, la cui manifestazione è dovuta nel quadro di quel contesto comunicativo (mediato dai membri del clero attivo in loco, rivolto alla somma autorità della Chiesa), è un fatto che per i soggetti resi schiavi l’accesso al matrimonio cristiano significa una possibilità di resistenza all’arbitrio totale dei padroni. Le donne della confraternita lasciano intendere tra le righe del memoriale l’abuso sessuale che si accompagna al loro nubilato forzato: il padrone ha tutto l’interesse a costringerle a non sposarsi, perché, dopo averne abusato a proprio arbitrio, può decidere di venderle senza curarsi di un loro eventuale legame coniugale, che comporterebbe anche la presenza di una giurisdizione di tipo spirituale su quel legame con la quale fare i conti. Inoltre, il matrimonio di uno schiavo con una donna libera generava prole libera; il matrimonio fra schiavi consente la costruzione di legami trasversali, che spezzano l’univocità del vincolo padrone-schiavo. Le suppliche di quel «malheureux petit troupeau» (p. 338) che si rivolgeva direttamente alla Santa sede, per mano dell’accorato impegno del gesuita, ebbero seguito? La loro stesura risale all’anno successivo al sinodo diocesano di Bahia e all'adozione delle relative Costituzioni, che qualificavano come peccato mortale la resistenza del padrone al matrimonio dello schiavo. Una stigmatizzazione morale che pesava nel foro interno ma che era priva delle conseguenze materiali che avrebbe avuto invece l’applicazione di una censura canonica. Le Costituzioni dell’arcivescovado di Bahia sarebbero rimaste in vigore fino al secolo successivo. A Roma si sarebbe molto discusso, fra congregazioni e ordini religiosi coinvolti nell’impresa dell’evangelizzazione d’oltremare, della deplorevole condizione di quelle anime, ma non si sarebbe mai offerta loro l’arma di difesa della scomunica dei padroni. Come è noto, la schiavitù in Brasile sarebbe stata abolita solo nel 1888.