

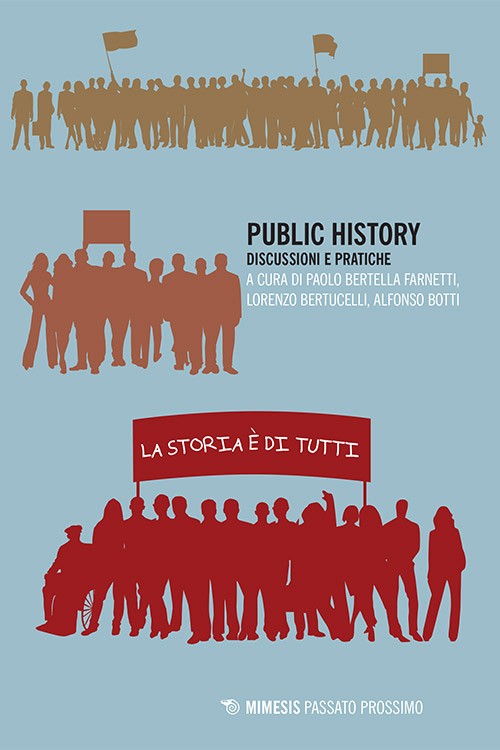
Reviewer Sara Zanatta - Fondazione Museo Storico del Trentino
CitationCome è possibile che una disciplina istituzionalizzata da quasi mezzo secolo nelle università americane abbia tanto faticato a farsi strada in Italia, e anche adesso che è diventata (quasi) di moda continui a far alzare il sopracciglio ai «puristi» o agli «historians» che non si considerano «public»?[1] Questo libro naturalmente non lo spiega, anche se Alfonso Botti nel suo saggio azzarda «l’ipotesi che il ritardo sia dovuto al prevalere del dibattito sull’uso pubblico della storia e che il recente interesse sia figlio di un disagio» (p. 99), quello verso il declino delle discipline umanistiche e il ridimensionamento del ruolo dello storico come intellettuale. Il volume, del resto, nasce sulla scia della prima conferenza dell’Associazione Italiana di Public History, tenutasi a Ravenna nel 2017, e propone una riflessione composita su questa disciplina «nuova», difficile da imbrigliare in una definizione univoca come pure da ridurre al rango di semplice materia. Da una parte, la public history è così legata alla storia culturale di un paese, e al radicarsi delle sue identità collettive, che la definizione del suo campo di pertinenza «rimane ambigua e contradditoria» (come emerge dai saggi del volume), nonostante il «bisogno globale di una decodificazione in termini professionali di un passato attivo nel presente» (p. 13). Dall’altra parte, essa è nata come movimento per rispondere a esigenze sociali e professionali – con tanto di manifesto programmatico, anche in Italia[2] –, e si configura al contempo come una metodologia e un approccio, un rincorrersi – per riprendere il titolo – di discussioni e pratiche (non solo comunicative, e spesso inconsapevoli) con una spiccata vocazione alla storia applicata.
I venti saggi che compongono il volume sono divisi in due parti: dopo la densa introduzione di Serge Noiret – che si è assunto l’onore e l’onere di togliere la public history dall’anonimato di una «disciplina fantasma»[3] – la prima parte affronta le questioni di natura epistemologica e metodologica, mentre la seconda tenta di gettare luce su alcuni campi di applicazione di questa disciplina nuova, tenendo insieme – come sottolineano anche i curatori nella prefazione – sia contributi che rientrano a pieno diritto nell’ambito della public history sia altri che la «lambiscono» o la «incrociano» (p. 7). Il rischio è quello di una lettura discontinua (complicata dagli estratti non tradotti di testi in inglese, francese e spagnolo) che lascia l’impressione di una disciplina ancora fortemente frammentaria per quanto riguarda gli ambiti di studio, come lasciano intuire anche i programmi dei convegni annuali.
La prima parte è la più riuscita e, a mio avviso, la più necessaria, considerato che la public history in Italia sta ancora consolidando una sua letteratura scientifica. I contributi di Paolo Bertella Farnetti e Thomas Cauvin fanno il punto sulla scuola anglosassone, a partire dal riconoscimento del valore pratico della storia al di fuori dell’accademia – come sottolinea la definizione data dal 'padre' della public history, lo storico dell’ambiente Robert Kelley[4] – per arrivare agli oltre duecento programmi che attualmente offrono le università americane fino alla recente internazionalizzazione delle sue pratiche e al sempre più stretto rapporto con il pubblico nell’analisi delle fonti. Anche Lorenzo Bertucelli, in uno dei saggi dedicati alla disciplina nel nostro paese, si sofferma sul principio della shared authority[5] attivata «nel percorso che porta dal fatto alla sua interpretazione, [... con] l’obiettivo di condividere con il pubblico la consapevolezza di tale costruzione» (p. 85) e introduce una chiave di riflessione tipicamente italiana, intorno alla quale si muovono anche i contributi di Maurizio Ridolfi, Marcello Ravveduto e Alfonso Botti. A partire dal dibattito sull’uso/abuso pubblico della storia, i tre saggi offrono un interessante spaccato di storia recente delle idee e mostrano come quanto concettualizzato da Nicola Gallerano nei primi anni Novanta si differenzi dalla definizione di public history.
La seconda parte, come detto, raccoglie contributi molto diversi per approccio, punto di vista, livello di approfondimento e avrebbe meritato una più ragionata scansione per temi (anche sulla falsariga dell’organizzazione seguita in altri volumi)[6]. Per quanto riguarda gli archivi, Cecilia Dau Novelli si concentra su storie di imprenditori, archivi interni alle aziende e centri di studio e ricerca nati anche in Italia a partire dagli anni Ottanta; Paolo Simioni presenta il caso di Home Movies, l’archivio nazionale dei film di famiglia con sede a Bologna, in particolare nella sua versione digitale (la piattaforma che permette di esplorare i fondi conservati in base a tema, periodo storico, provenienza). A proposito dell'immagine in movimento, Vittorio Iervese riflette sul rapporto tra documentario e public history, a partire dalle tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin; Marco Cipolloni offre invece alcune proposte di rilettura di un corpus cinematografico in cui storie del mondo naturale e umano vengono a contatto. Riguardo al ruolo sociale dello storico e alle sfide che la public history porta con sé, Antonio Canovi parte dall’esperienza del Musée de l’Histoire Vivante a Montreuil per riflettere sulla storia orale; Claudio Silingardi, a suo dire «public historian a sua insaputa», discute una fonte come la musica, con la quale gli storici tout court hanno sempre dimostrato scarsa dimestichezza; Adolfo Mignemi ragiona su come maneggiare le immagini fotografiche; Enrica Salvatori esamina le ripercussioni della rivoluzione digitale sulla figura dello storico; Manfredi Scanagatta legge la public history come «metodo sovrastrutturale» che utilizza il metodo storico e al contempo lo trascende facendosi azione creativa (p. 317). Riguardo all'ambito museale, settore centrale per la public history e luogo privilegiato di formazione professionale del public historian, Michelangela di Giacomo, al tempo impegnata nella realizzazione dei contenuti scientifici del non ancora inaugurato Museo M9 a Mestre, discute il modello del «museo di nuova generazione», ovvero il museo di narrazione con finalità di edutainment considerato «una risposta alla crisi delle identità collettive» (p. 270), mentre Aldo Di Russo utilizza gli esempi del Castello di Lagopesole, una roccaforte normanna e poi sveva, e della casa natale di Joe Petrosino per esemplificare la categoria di «museo narrante». Unico contributo sul reenactment, in particolare sull’esperienza dei gladiatori, è quello di Eric Teyssier, che dal 2010 organizza i Grandi giochi romani a Nîmes.
La speranza è che in un prossimo volume collettaneo – perché di testi come questo avremo ancora bisogno se si vuole continuare a dare spessore teorico alla disciplina – trovino voce non solo gli accademici ma anche i tanti e le tante public historians che lavorano nelle istituzioni storiche del nostro paese (qui sottorappresentati e sottorappresentate) e che ogni giorno si pongono «l’obiettivo ambizioso di portare all'attenzione del pubblico un metodo e un approccio critico al passato» (p. 93) e di rispondere al sempre più stringente bisogno di storia del tempo presente.
[1] Caustica, a dir poco, è la definizione che ne ha dato Franco Cardini, che la ha designata come il «nuovo contenitore trendy che in sostanza indica la storia spiegata a gente che non la sa da parte di altra gente che non la sa nemmeno lei, un po’ l’imparacchia, un po’ l’inventa». F. Cardini, In tv vince la fiction, ma i Medici dove sono finiti?, in «La Repubblica», 20 ottobre 2016, consultabile al link https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/10/20/in-tv-vince-la-fiction-ma-i-medici-dove-sono-finiti38.html.
[2] Il Manifesto della Public History italiana – consultabile al link https://aiph.hypotheses.org/3193 – è stato redatto nel 2018 e contiene indicazioni sul significato, gli obiettivi e il rapporto tra la tradizione italiana e la disciplina a livello internazionale
[3] S. Noiret, La Public History: una disciplina fantasma?, in «Memoria e Ricerca», 37, 2011, pp. 9-35.
[4] «In parole povere, public history significa l’impiego degli storici e del metodo storico fuori dall’accademia: nelle strutture governative, nelle aziende, nei media, nelle società storiche, fino a divenire un lavoro autonomo», R. Kelley, Public History: Its Origins, Nature, and Prospects, in «The Public Historian», 1, 1978, 1 p. 16-28, qui p. 16.
[5] M. Frisch, A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History, New York, State University of New York Press, 1990.
[6] Penso ad esempio a: F. Sayer, Public History: A Practical Guide, London, Bloomsbury Academic, 2015.