

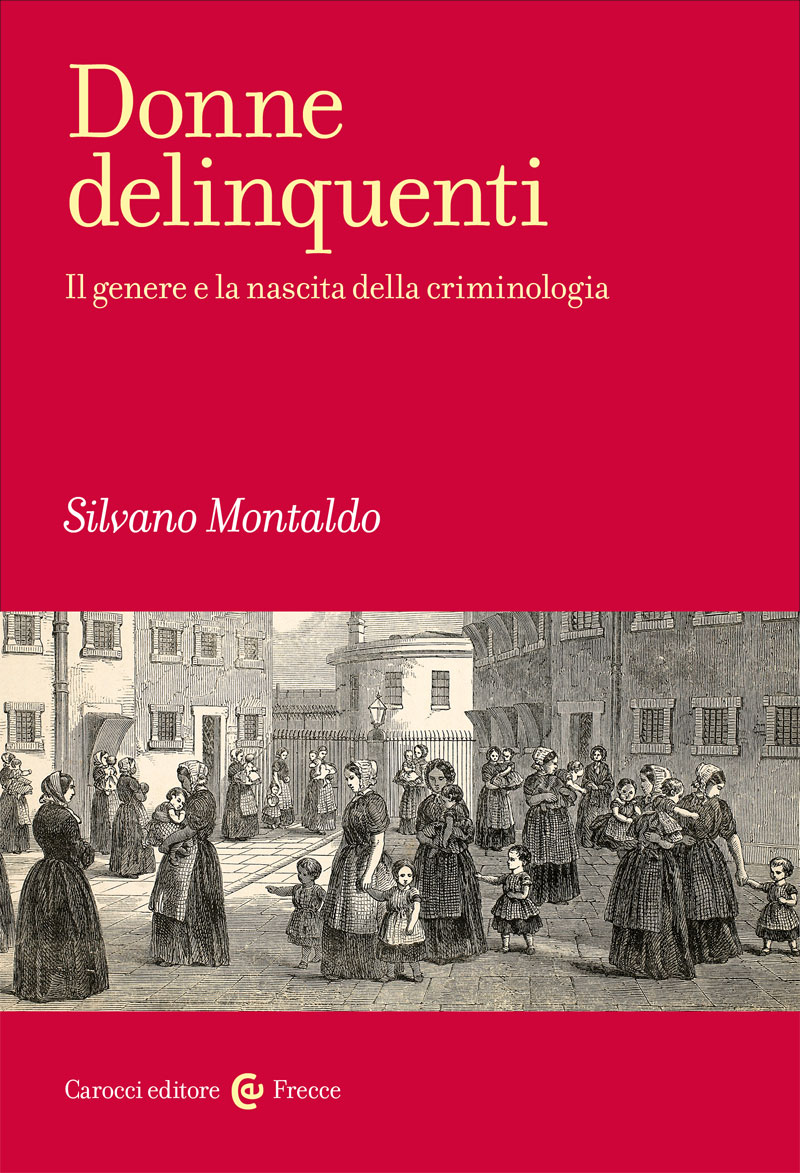
Reviewer Marco Meriggi - Università di Napoli
CitationSoltanto in parte il titolo che l’autore ha dato al libro restituisce la ricchezza del suo contenuto, e ciò è dovuto al fatto che nei capitoli che ne scandiscono l’andamento – che, pure, sono legati da un fil rouge unitario – vengono sviscerati molti temi, alcuni dei quali dotati in parte di un ubi consistam autonomo.
Al centro dell’attenzione si colloca comunque la frastagliata linea di sviluppo della criminologia europea (e, nell’ultimo capitolo, anche statunitense) di ispirazione positivistica dagli anni Trenta dell’Ottocento all’inizio del secolo seguente. Il tema, in Italia, viene abitualmente ricondotto soprattutto alla figura di Cesare Lombroso e al suo trattato L’uomo delinquente (1876). Qui l’autore ne restituisce invece anche la polifonia della genesi, guidando il lettore attraverso una vicenda contraddistinta dal pluridecennale tentativo di coniugare con successo il metodo delle scienze naturali con lo studio della società umana e in particolare con quello dei suoi aspetti patologici; primo tra essi, il crimine.
È degli anni Trenta la formalizzazione, in Francia, del concetto di classes dangereuses, ovvero di quei settori della popolazione che con il loro comportamento deviante mettono a repentaglio l’ordinato funzionamento della società; la sua normalità. Uno dei modi nei quali la nascente criminologia tende a spiegarne la natura è quello di rintracciarne una possibile matrice atavistica. Di qui la grande fortuna della frenologia, della misurazione dei crani e dello studio della conformazione degli encefali dei detenuti, alla ricerca di un nesso statisticamente dimostrabile tra propensione al delitto e identità biologica. Negli anni Settanta Cesare Lombroso conquista, in questo contesto, una transitoria celebrità internazionale e pretende di presentarsi come il padre fondatore di una scienza – la criminologia, per l’appunto – che vanta in realtà, al momento della pubblicazione del trattato dello studioso operante a Torino, già molti dibattiti precedenti, di cui nei due capitoli iniziali del volume ci viene offerta una ben calibrata illustrazione. Alla fortuna di Lombroso, e poi alla parabola discendente di quest’ultima, il volume dedica i quattro capitoli successivi, attingendo efficacemente a molte fonti inedite conservate in istituzioni italiane, francesi, statunitensi e indagando su molti temi che si prestano bene a illustrare prima le aspettative, poi le disillusioni caratteristiche della stagione positivistica.
Intorno alla fine del secolo, alla teoria lombrosiana del «delinquente nato», che aveva riscosso in precedenza consistenti consensi, si tendeva a non dare più credito e la scuola antropocentrica si avviava verso il declino. In Italia per esempio il mondo dei giuristi – come dimostra il Codice penale del 1890 – si rifiutò di recepire le proposte avanzate dall’antropologia criminale in tema di soggettività del delitto, mentre andavano guadagnando contestualmente posizioni modelli di interpretazione del crimine sociologici, piuttosto che antropologici, e si tendeva a riconoscere nei condizionamenti indotti dall’ambiente sociale il ruolo prevalente nella genesi del comportamento criminale che le ricerche di Lombroso avevano invece preteso di attribuire all’atavismo. Nel medesimo torno di tempo, ai congressi internazionali di antropologia criminale tenutisi a Parigi nel 1889 e l’anno seguente a San Pietroburgo le teorie dell’italiano vennero sistematicamente demolite, sulla base di ricerche statistiche che offrivano risultati del tutto diversi da quelli ai quali egli era pervenuto. Lombroso e la sua buona fama ne uscirono fortemente ridimensionati.
Nel decennio seguente, tuttavia, auspice la collaborazione con Guglielmo Ferrero, che sposò sua figlia Gina, Lombroso compose «un nuovo trattato. Per risorgere» (questo il titolo che Montaldo dà al capitolo 5, in cui ne esamina la genesi e le idee-chiave). Si trattava de La donna delinquente (1897). In questa sede egli attenuò un poco l’ossessione antropometrica che aveva ispirato la sua attività di ricerca nei decenni precedenti. Tematizzando la criminalità delle donne, rinverdì tuttavia una serie di pregiudizi sulla supposta natura femminile che, attingendo ovviamente a un retroterra culturale di risalenza millenaria – ancora fortemente radicato in un paese socialmente arretrato come l’Italia – si allineavano in sostanza alle tesi darwiniane sulla donna come uomo non completamente evoluto. Convinzione di Lombroso era che il «genio femminile» fosse comunque da ritenere «una strana eccezione della natura»; un’idea condivisa anche dal genero. Persuaso a sua volta che la donna fosse da considerare quasi come un bambino, a proposito della propria moglie (nonché figlia di Lombroso) Ferrero osservava con compiacimento come ella non avesse nulla «della solita stupidità della donna», aggiungendo: «non porta nemmeno orecchini» (p. 196).
Il tema del volume a quattro mani non era tuttavia genericamente la donna, bensì specificamente la donna delinquente. E dal momento che i tassi di criminalità femminile risultavano infinitamente più bassi di quelli relativi alla criminalità maschile, l’attenzione si concentrava soprattutto sulla prostituzione, equiparata tout court a un crimine; un crimine, per altro, da intendersi come solo femminile, dal momento che la compartecipazione maschile al fenomeno veniva rubricata all’interno della cornice della «naturalità» dell’impulso sessuale maschile e, dunque rassicurantemente inserita nello schema della doppia morale. La prostituzione era anzi considerata da Lombroso, in quanto fenomeno di devianza dalle norme socialmente condivise, come la specifica forma femminile del crimine, l’esempio più diffuso tra le donne di una degenerazione che negli uomini si esprimeva invece nel delitto (p. 212). Anche se con meno enfasi, ci si trovava così di fronte a una riproposizione del tema del «delinquente nato», ora nella fattispecie della «prostituta nata», sulle base delle suggestioni derivanti dalla teoria della «regressione atavica» e del contestuale conferimento alle donne del rango di «esseri moralmente incompleti» (p. 220). Con questi presupposti era davvero arduo immaginare un processo di emancipazione femminile – ovvero, l’inserimento delle donne in un mondo relazionale e professionale fino ad allora graniticamente maschile – che comportasse la contestuale emancipazione della società dalla struttura patriarcale o, nella migliore delle ipotesi, paternalistica, caratteristica delle società europee meno avanzate. Singolare contraddizione – argomenta persuasivamente Montaldo – per uno studioso che era nel frattempo approdato al socialismo e che però, pur con qualche ambivalenza e oscillazione, restava dell’idea che alle donne il mondo delle professioni liberali e quello della partecipazione alla politica dovessero restare preclusi, perché – come avevano sostenuto altri voci nel dibattito italiano degli anni Ottanta – «la donna troppo libera» e, dunque, sottratta alla sua missione di allevamento della prole e di cura della sfera domestica, «diverrebbe facilmente libertina» (così Giuseppe Ardini, autore a sua volta nel 1883 di un trattato su la donna delinquente e la legge penale).
Molti altri sono i nodi tematici proposti in questo libro, come accennavo in apertura di discorso. Tutti interessanti, essi si prestano bene a esemplificare la volatile pretesa della criminologia ottocentesca di proporsi quasi come una scienza generale della società, a partire dalle talvolta avventurose misurazioni di alcune delle sue patologie.