

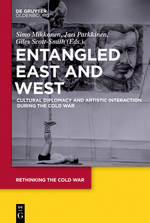
Reviewer Stefano Pisu - Università di Cagliari
CitationIl volume è diviso in tre sezioni centrali, anticipate da una ricca introduzione storiografica e metodologica e seguite da un contributo specifico che contiene al contempo delle conclusioni più generali sull’opera in sé. Nell’introduzione – Exploring Culture in and of the Cold War – i curatori spiegano le ragioni storiografiche e i presupposti metodologici alla base del volume. Uno dei motivi di fondo è contribuire all’affermarsi di un filone di studi – in realtà consolidato da più anni – che ha messo in discussione l’immagine monocorde della Guerra fredda quale espressione dell'esclusiva rivalità fra le due superpotenze americana e sovietica, costantemente sull’orlo di un conflitto militare di tipo nucleare. In questo senso il volume, con una serie di nuove ricerche, espande la dimensione geografica e geopolitica dell’antagonismo Est-Ovest – riservando maggior spazio al contesto europeo –, nonché il suo ambito, spostandolo sul terreno della cooperazione e del confronto culturale e artistico. Dal punto di vista metodologico i curatori affermano nettamente che il tradizionale approccio politico allo studio della Guerra fredda – incentrato sulla politica estera, sulle relazioni interstatali e sulle questioni strategico-militari – non può essere ritenuto più sufficiente: «In contrast, the Cultural Cold War, focusing on the arts, everyday life, education, and how social activity in both East and West was affected by the Cold War, greatly expands the traditional area of Cold War studies» (p. 2).
La prima parte del volume – Visual Aesthetics and Diplomacy – è dedicata ai modi in cui le arti visive si sono intrecciate a questioni diplomatiche. Clarkson esamina l’interazione sovietico-britannica circa la mostra «Art in Revolution» del 1971 che ebbe il merito di far conoscere la prima avanguardia sovietica al pubblico occidentale e che costituisce un caso esemplare della negoziazione fra attori ufficiali e non nello scambio culturale Est-Ovest. L’avanguardia è presente anche nel contributo di Malich, la quale indaga le influenze dell’architettura sovietica su quella olandese del secondo dopoguerra: l’autrice ne individua le origini nelle esperienze dei professionisti che negli anni Trenta erano stati invitati in URSS e che, pur restandone in generale delusi, ne sperimentarono in patria alcuni tratti (la standardizzazione delle abitazioni e le città funzionali). Vowinckel conduce invece il lettore nel campo della fotografia come strumento di diplomazia culturale, investigando l’uso delle immagini del muro di Berlino fatto dagli Stati Uniti nella Germania occidentale e come in quelle esposizioni il confine fra diplomazia e propaganda sia stato molto labile. La prima parte del volume si conclude con il contributo di Vilen: tramite la vicenda della Statua della Pace al porto di Helsinki, la cui erezione era stata oggetto di scontro fra la destra e la sinistra finlandese con il coinvolgimento della stessa URSS, emerge la rilevanza delle politiche memoriali nella storia delle relazioni fra i due paesi.
La seconda parte del volume – Literary and Scholarly Diplomacy – investiga il ruolo dei rapporti accademici e tra i singoli individui nelle relazioni internazionali, che sta diventando un terreno di studio sempre più fecondo negli studi sulla cooperazione/competizione, in particolare rispetto ai paesi impegnati nei processi di decolonizzazione. Shchekina-Greipel prende in esame l’esperienza di Lev Kopelev – traduttore di letteratura tedesca, dissidente emigrato dall’URSS e accolto nella Germania Ovest – nell’ambito degli scambi culturali e accademici tedesco-sovietici. Il fatto che poi Kopelev continuò a interagire con intellettuali sovietici dimostra come la questione dei dissidenti sovietici fosse una questione molto delicata per le autorità di Mosca giacché l’emigrazione forzata rappresentava spesso un aggravamento del problema a livello internazionale, piuttosto che una sua risoluzione sul piano interno. Tsvetkova affronta in modo comparato le politiche sovietiche e americane nei confronti delle aperture di proprie università all’estero, mostrando che, mentre gli USA miravano a espandere le idee liberali tramite i sistemi di istruzione all’estero, l’URSS cercò diffondere le idee marxiste dal punto di vista sia dal punto di vista organizzativo dell’offerta formativa. Zhuk rivela il ruolo degli «americanisti» sovietici, ovvero personale accademico specializzato in storia, politica e cultura degli Stati Uniti, quali fonte di informazioni per la dirigenza del Cremlino. Lo studioso mostra l’importanza di quelle figure quali filtri della cultura americana, alta e popolare, in Unione Sovietica, con particolare riferimento all’epoca brežneviana.
Nella terza parte del volume – Diplomacy in Music and Performing Arts – si esamina la funzione svolta dalla musica negli scambi culturali durante la Guerra fredda, in cui emerge la rilevanza del fattore economico e commerciale nell’ambito degli scambi culturali. Kondrashina considera il peso della discografia sovietica in quanto insieme prodotti culturali esportabili e vendibili. L’industria discografica costituì inizialmente un elemento dello sforzo propagandistico sovietico all’estero per poi vedere il suo ruolo complicarsi a partire dagli anni Sessanta, quando dovette interloquire con soggetti privati aventi interessi sostanzialmente commerciali, come la EMI. Zora entra ancora più nello specifico, mostrando come le agenzie sovietiche cercassero di rendere popolare la musica sovietica nel mondo anglofono dopo la Seconda guerra mondiale e in che misura abbiano dovuto scontrarsi sia con freni interni – di natura burocratica – sia con problemi esterni, legati agli scopi economici delle compagnie occidentali interessate. Johnson, Oiva e Salmi si concentrano, infine, sulla visita di Yves Montand in URSS nel 1956. Nonostante il temporaneo blocco delle iniziative culturali da parte dei paesi occidentali in URSS – dovuto all’invasione dell’Ungheria Montand decise di proseguire il proprio tour che stava riscuotendo un grande successo popolare.
Il contributo di Giles Scott-Smith conclude il volume con un’analisi del volo del giovane Mathias Rust sulla Piazza Rossa nel 1987. Lo studioso si avvale di quell'episodio per mostrarne il carattere simbolico, sia come superamento privato e individuale delle frontiere geografiche e geopolitiche Est-Ovest nella fase finale del bipolarismo, sia come «trasgressione» storiografica dei confini tradizionali degli studi sulla Guerra fredda. Una trasgressione che, a dire il vero, perdura ormai da diversi anni e che forse non dovrebbe nemmeno più essere considerata tale, tenuto conto di quanto gli studi sul ruolo della cultura nella Guerra fredda si siano legittimati non soltanto con la qualità delle ricerche svolte, ma altrettanto attraverso il loro inserimento e la loro citazione nelle più ampie sintesi storiografiche sull’argomento.