

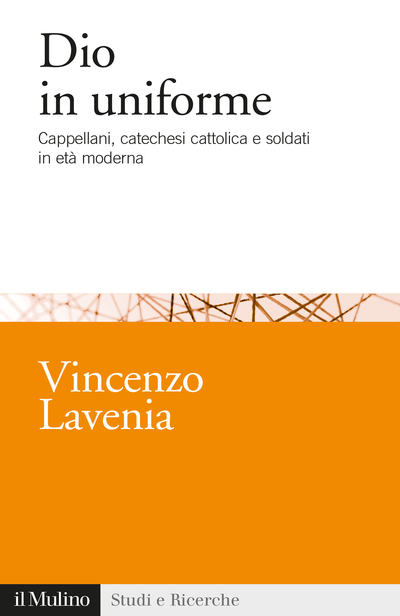
Reviewer Marco Bellabarba - Università di Trento
Citation«Per chi deve morire il buon soldato cristiano»? Per quale causa, e con quale giustificazione morale, può perdere la propria vita o sottrarre quella di altri, infliggere dolore e morte, senza che la propria anima si perda?
I lettori del libro di Vincenzo Lavenia scorgeranno questi interrogativi allargarsi nell’Occidente cristiano dai primi anni del Cinquecento fino allo scoppio del Primo conflitto mondiale, in un susseguirsi di domande radicali e di altrettanto radicali risposte, che interrogano le coscienze dei contemporanei e in fondo le nostre, chiamate ogni giorno a fare i conti con la guerra, le sue conseguenze, i motivi che si invocano per giustificarle in nome di ideali o di interessi di potere molto concreti.
All’estremità dell’arco temporale considerato dal libro si colloca una vicenda che rende efficacemente il senso del valore e dell’attualità dei temi sui quali si concentrano tutti i capitoli di Dio in uniforme.
È il 1° agosto del 1914, una giornata di caldo opprimente a Berlino, e una folla immensa si è riunita sull’Alexanderplatz in attesa di qualche comunicazione. Il giorno precedente i bollettini ufficiali hanno proclamato lo «stato di pericolo di guerra» contro la Russia. Finalmente da un balcone si affaccia un portavoce del Kaiser e annuncia che il Reich tedesco ha deciso la mobilitazione generale. I presenti, che sono stati in silenzio fino a quel momento, intonano spontaneamente un canto. Non il patriottico e ufficiale «Deutschland über alles», ma un canto corale luterano, il «Gott tief im Herzen», che di solito si canta nel corso delle funzioni religiose, quasi a precedere la messa solenne officiata il giorno dopo, domenica, dal cappellano di corte Bruno Doehring, in occasione della dichiarazione di guerra alla Francia [1]. Il 4 agosto, finalmente prende la parola il Kaiser; Guglielmo II, in un discorso preparato dal teologo luterano Adolph von Harnack, ricorre a motivi religiosi per provare la giustezza della guerra e il «destino manifesto» del popolo tedesco: la pietà religiosa dei suoi sudditi e il loro attaccamento alla fede li renderà in grado di superare sui campi di battaglia qualsiasi nemico.
Questa simbiosi di primo acchito così stridente tra religione e guerra non è solo tedesca, e tanto meno solo luterano-protestante. A Parigi, come a Londra, a Roma, o a San Pietroburgo, tutti i proclami ufficiali cercano di mettere le mani sul loro Dio, cattolico, anglicano, ortodosso o protestante. Ovunque la guerra è subito trasformata in guerra santa e un’ombra di misticismo patriottico rende qualsiasi sacrificio accettabile d’ora in avanti per uomini e donne convinti di trovarsi nel mezzo di una crociata combattuta in nome di valori religiosi.
Perciò, in questa atmosfera di travolgente misticismo bellico, il celebre appello di papa Benedetto XV pronunciato nel 1917 contro l’«inutile strage» non può che cadere inascoltato, o peggio, essere rifiutato duramente. È un papa «crucco» secondo la definizione tagliente del presidente della repubblica francese Clemenceau, o all’opposto un papa «francese» per il capo di stato maggiore tedesco Ludendorff. I figli cristiani di Benedetto XV combattono da una parte e dall’altra del fronte dei fronti, credendo tutti di stare dalla parte di chi combatte per l’umanità e la giustizia contro l’inciviltà e la barbarie. D’altra parte, anche all'interno dello stesso clero cattolico sono davvero in pochi a condividere le posizioni neutraliste del pontefice.
Impegnato nella cura dei soldati che giungono dal fronte con malattie psichiche e nervose, c’è il padre francescano Agostino Gemelli, futuro fondatore dell’Università cattolica di Milano, che dirige con il grado di maggiore del Regio Esercito italiano l’Ufficio di psichiatria di Milano. Convinto interventista, come la maggior parte della corporazione psichiatrica, Gemelli trae da quell’esperienza un libro, una sorta di manuale psichiatrico pratico, Il nostro soldato, edito nel 1917, nel quale egli disegna un lucido e assai patriottico profilo del buon combattente; che è il soldato in grado di difendersi dalla violenza e dall’orrore dei combattimenti agendo sulla propria personalità, fino al punto da cadere in uno «stato di lieve oscuramento psichico» che gli permette di eseguire gli ordini come un automa, senza alcun rimorso di coscienza [2]. E per chi combatte una guerra moderna, gli stessi valori di eroismo e di amore di patria sono meno importanti della passività e della disciplina: la sua stessa coscienza individuale, ogni forma di scrupolo, di dubbio, devono scomparire di fronte all’assuefazione alla violenza, che per Gemelli è una forma di terapia formativa.
Con le parole del medico, ufficiale del regio esercito e padre francescano Agostino Gemelli siamo arrivati alla fine del percorso tracciato nel libro di Vincenzo Lavenia, una lunga storia di uomini – i cappellani – e di saperi teologico-giuridici, con cui i poteri politici e religiosi dell’Europa moderna tentarono di costruire un’idea di guerra che potesse legittimare l’impiego della violenza contro il nemico, ma che, allo stesso tempo, sapesse edulcorarne la ferocia, e disciplinare gli atteggiamenti e i pensieri di chi era chiamata a farla, ufficiali e soldati prima di tutto.
L’aveva scritto benissimo, molte volte, Paolo Prodi: «la guerra ha giocato un ruolo centrale nella genesi dello Stato occidentale» e ne ha costituito un carattere essenziale, persino nei non lunghi intervalli di pace. Gli Stati moderni hanno vissuto «in guerra e per la guerra»; hanno dovuto organizzarsi per sostenerne il carico, sempre più pesante, che li ha obbligati assai presto a forme di mobilitazione delle risorse fiscali, materiali e umane, hanno mosso verso il centro le strutture del potere [3], e sono stati costretti giustificare quelle guerre prima sacralizzando lo ius ad bellum e in un secondo momento disciplinando lo ius in bello, le pratiche, i comportamenti, ciò che era lecito o non lecito fare da parte dei soldati.
«Invero i soldati di Cristo combattono tranquillamente – aveva scritto San Bernardo di Chiaravalle agli inizi del XIII secolo – le battaglie del loro Signore, non temendo affatto di peccare quando uccidono i nemici né di perdere la vita, in quanto la morte inferta o subita per Cristo non ha nulla di delittuoso, anzi rende ancora più meritevoli di gloria». Tra l’esaltazione della guerra medievale (come santa e giusta) e la sua progressiva disciplina in età moderna corre un rapporto carico di tensioni e di mutamenti continui, ma anche di analogie di ricomparse inaspettate. Nel corso del XVI e XVII secolo teologi e missionari cattolici si sono affannati a raccomandare al soldato di Cristo di essere gentile e virtuoso, di leggere buoni libri e istruirsi nella fede, perché solo grazie a questa disciplina interiore egli può perdere la propria vita o sottrarre quella di altri, infliggere dolore e morte senza che la propria anima si perda. Ma nel 1914 il culto della morte per la patria sembra riproporre schemi di legittimazione della guerra antichissimi, che auspicano coscienze dei soldati riempite solo dalle immagini dei propri ufficiali in modo che le loro azioni siano involontarie e perciò facili, incoscienti e quindi sicure.
Nei momenti cruciali di ogni guerra – sembra ricordarci il libro di Vincenzo Lavenia – l’appello a morire per un Dio o una patria qualsiasi, inevitabilmente torna a farsi sentire.
* Una versione di questo testo è stata presentata in occasione del conferimento a Vicenzo Lavenia del premio in onore di Paolo Prodi presso la Fondazione Bruno Kessler il 5 dicembre 2019.
[1] L’episodio è ricordato nel saggio di A. Gregory, Beliefs and Religion, in J. Winter (ed), The Cambridge History of the First World War, III: Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 418-444.
[2] Il libro di A. Gemelli, Il nostro soldato. Saggio di psicologia militare, Milano, Treves, 1917 è citato da A. Grillini, La guerra in testa Esperienze traumi di civili, profughi e soldati nel manicomio di Pergine Valsugana (1909-1924), Bologna, il Mulino, 2018, in particolare pp. 171-172.
[3] Ad esempio in P. Prodi, Un’identità in movimento: l'Europa come rivoluzione permanente, in «Quaderni di sociologia», 55, 2011, 55, pp. 23-40, consultabile al link https://doi.org/10.4000/qds.643