

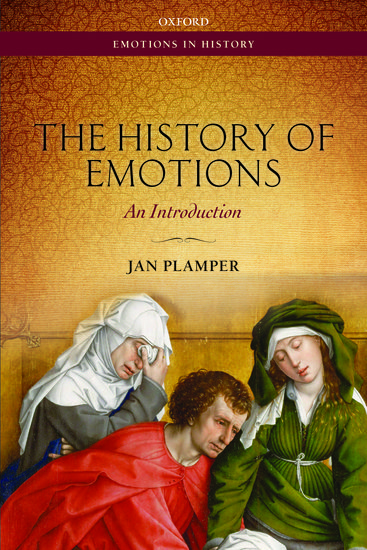
Reviewer Fernanda Alfieri - FBK-ISIG
CitationLo studio di Jan Plamper sulla storiografia delle emozioni condotto presso il Max-Planck Institut für Bildungsforschung era apparso nel 2012 con il titolo Geschichte und Gefühl. Grundlagen der Emotionsgeschichte. Il testo si proponeva di illustrare le basi di una storiografia dalla genesi ambigua. Se la sfera dei sentimenti e delle passioni è stata oggetto di una risalente attenzione storiografica, tuttavia solo da pochi anni ne definisce esplicitamente un campo specifico, dotato di centri di ricerca e mezzi di diffusione dedicati. E l’esistenza della stessa collana Emotions in History, ospitata dalla prestigiosa casa editrice oxoniense, di cui il testo di Plamper costituisce ora il terzo titolo, è significativa di un avvenuto processo di canonizzazione disciplinare.
Di questo campo consolidato ma ancora in movimento il volume che qui si recensisce si propone più ambiziosamente come introduzione e come porta d’accesso, non limitandosi quindi ad una semplice traduzione della versione originale – significativamente, nella lingua della circolazione globale – con aggiornamento bibliografico. Alla sua origine si presume vi sia stata la nuova necessità di fare il punto di una produzione storiografica, di cui si dà conto nel primo capitolo, che ha conosciuto e conosce una enorme proliferazione e che, come l’autore anticipa in introduzione, è stata ed è tutt’altro che omogenea quanto a metodi e visioni. La divisione primaria e cruciale, su cui il volume imposta la trattazione dedicandovi i due nutriti capitoli centrali, è fra relativisti, inclini a guardare alle emozioni come culturalmente costruibili e decostruibili, e universalisti, che pensano invece le emozioni come elementi essenziali, incardinate come innatismi biologici in ogni essere umano a prescindere da latitudini, epoche, culture. L’antico dilemma (culturalismo vs determinismo biologicista) è rinvigorito dall’auge delle neuroscienze, che a partire dalla decade of the brain 1990-1999, così detta per i cospicui finanziamenti per la ricerca sul cervello stanziati dal governo statunitense (poi rinnovati, e si aggiungano quelli dell’europeo Human Brain Project dal 2013) hanno contribuito a diffondere con successo anche fra i non addetti ai lavori un’antropologia riduzionista. La storia tenderebbe tradizionalmente a situarsi sull’altro versante, ma Plamper intravede «genuine possibilities for cooperation» (p. 297). La stessa storiografia ha mostrato sin dai primi anni Duemila segnali di esigenza di compensazione, o forse di superamento, della sensibilità postmoderna per l’elemento discorsivo, invocando una nuova attenzione per la dimensione dell’esperienza. Un desiderio di tangibilità, e in qualche modo di certezze (secondo Plamper molto ha contribuito l’11 settembre) avrebbe favorito la ricezione presso gli storici di categorie quali quella di «embodiment» coniata dal neuroscienziato Antonio Damasio, che invita a considerare l’atto cognitivo (che il senso comune ascrive all’elemento razionale) come intriso di emozioni ad esso funzionali e necessarie, e il corpo come luogo in cui l’emozione – a questo punto, ingrediente cruciale di ogni esperienza umana – si incarna. Il corpo non è, quindi, solo il veicolo di trasmissione empiricamente tangibile delle emozioni (gesti, espressioni facciali, secrezioni), ma anche il loro incubatore e il loro rielaboratore. E ciò che si elabora nel corpo non è soltanto una questione di biologia, o di «natura», ma anche di cultura. Nella sua Storia dei diritti umani (2007), la storica Lynn Hunt ipotizzava che pratiche come la lettura individuale, sempre più diffuse nella Francia del Settecento, avessero provocato delle modifiche fisiologiche nei cervelli di uomini e donne del secolo, modifiche che sfociarono in (o costituirono la base di) sentimenti diffusi di autonomia individuale e di empatia.
Sulla stessa linea d’onda è lo studio del medievista Daniel L. Smail, che l’anno dopo invitava a guardare all’organo cerebrale come oggetto di studio storico ideale: lì risiedono l’origine, il mezzo e il fine dei processi di cambiamento. La chiave di volta è, in entrambi gli studi, la nozione neurobiologica di «plasticità» che dà il cervello come entità in costante mutamento, sulla scia di stimoli di varia origine. Anche il cervello, quindi, ha una storia, e nell’avere una storia, nell’essere soggetto alla storia, a sua volta contribuisce a farla. Per quanto aperto a questi tentativi di incorporazione – per l’appunto – delle neuroscienze nella storia, Plamper invita però alla cautela, proponendo innanzitutto agli storici di dare il tempo alle nuove ipotesi formulate dalle scienze del cervello di essere confermate (ché in molti casi ancora di ipotesi si tratta), senza cedere alla tentazione di cercare sensazionalismi o agganciarsi a trend culturali nel tentativo di riscattare la propria disciplina da una temuta marginalità. E, del resto, le stesse neuroscienze hanno sviluppato al loro interno una corrente di critici (critical neurosciences) che tendono a ridimensionare la tendenza, nella maggior parte dei casi spinta dai media, a presentare certe acquisizioni come l’ultima, indiscutibile parola sul genere umano. A questo proposito la citata nozione di plasticità appare come cruciale: oltre a fornire alla storia un oggetto non discorsivo ma al contempo «culturale» benché organico, serve alle neuroscienze a tenersi distanti dal rischio di produrre nozioni essenzialistiche, di sostenere un’idea di umano come fisso e oggettivo. Un’altra recente acquisizione contribuirebbe allo scioglimento di eventuali rigidità, ovvero l’idea che i processi che si svolgono in determinate aree della corteccia cerebrale non sono mai slegati fra loro, ma in necessaria e funzionale risonanza. Secondo Plamper, questo incoraggia anche gli storici ad avere uno sguardo olistico sugli individui, considerando la molteplicità di motori che possono aver spinto a determinati atteggiamenti. Non si tratta mai, insomma, di scelte rigorosamente razionali o di impulsi integralmente irrazionali, ma di una «‘cogmotive’ or ‘cogaffective’ mixture» (p. 246).
Infine, la nozione di empatia, secondo la quale la nostra condizione emotiva tende ad essere isomorfica con quella di altri soggetti, può impedire alle neuroscienze di cadere nella trappola di un cerebrocentrismo individualista (la persona considerata in quanto organo, separata dal contesto) e, dando come inevitabili gli effetti dell’ambiente sociale, dare voce in capitolo alle scienze umane.
Due autori in particolare, secondo Plamper, hanno contribuito al superamento della dicotomia tra costruzionismo e universalismo. Nel 2001, William M. Reddy incorpora life sciences, antropologia e psicologia cognitiva nel concetto di emotive, indicante uno speech act che allo stesso tempo descrive, esprime e opera un cambiamento emotivo. Gli emotives sono inscritti in particolari emotional regimes, che li assegnano a determinati rituali o pratiche simboliche, e che li legittimano o inducono in situazioni precise, rendendoli prescrittivi. Poiché diversi e contradditori regimi emotivi coesistono tra loro, il soggetto si trova a «navigare» fra di essi (Navigation of feeling è il titolo dell’opera di Reddy). Monique Scheer, in uno studio del 2012, include il corpo nella dimensione di fatto logocentrica di Reddy, facendo proprie la teoria filosofica di «extended mind theory» e quella sociologica, riconducibile a Pierre Bourdieu, di habitus come incorporazione in senso letterale di pratiche (tutto il corpo pensa e sente). In questo sistema mente-corpo interamente coinvolto nel processo cognitivo ed emotivo, l’emozione può essere variamente indotta, nominata, comunicata, regolata, e, per lo storico, possono essere vari gli ambiti in cui cercarne le tracce. Se lo sforzo teorico c’è stato, e, come dimostra lo stesso lavoro di Plamper, è tutt’altro che concluso, la ricerca empirica è invece ancora in gran parte da fare. Il volume si conclude proponendo alle ricerche future un ventaglio di ambiti da esplorare, dalla storia giudiziaria a quella politica, a quella economica. La bibliografia in conclusione al volume, suddivisa per ambiti disciplinari, dà conto della molteplicità di prospettive interpellate da Plamper per comporre una cornice che resta volutamente aperta.