

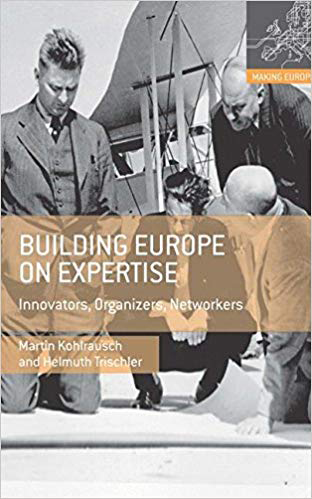
Reviewer Giovanni Bernardini - FBK-ISIG e European University Institute
Citation«Fare l’Europa» è un’espressione allegorica entrata nel linguaggio comune per indicare il processo di integrazione continentale seguito alla Seconda guerra mondiale, guidato dai governi dell’epoca e da quelli che li hanno seguiti, fino al recente allargamento agli ex stati del blocco socialista. Tale fenomeno politico sembra avere catalizzato l’attenzione al punto da marginalizzare una dimensione ben più materiale attraverso cui lo spazio fisico e sociale europeo, e di conseguenza quello mentale dei suoi cittadini, è stato reso più omogeneo a partire almeno dal XIX secolo. In altri termini, c’è una storia alternativa dell’Europa contemporanea che reca nel suo nucleo la tecnica e la tecnologia, e che ha assunto un carattere ingegneristico nell’accezione più ampia: una sua indagine è particolarmente utile per comprendere le continuità di lungo periodo indipendentemente dalle rotture prodotte da conflitti e mutamenti politici. Questo è quanto sostengono Johan Schot e Philip Scranton, curatori della serie editoriale «Making Europe», promossa da eminenti istituzioni di ricerca come la European Science Foundation e la Foundation for the History of Technology di Eindhoven. Una serie che comprende sei volumi, ciascuno affidato a una coppia di autori scelti tra i maggiori esperti del tema, incentrati sui modi in cui produttori e consumatori, innovatori e realizzatori di infrastrutture, cartelli industriali e operatori della comunicazione hanno contribuito (in modo spesso non intenzionale) a conferire all’Europa i lineamenti mutevoli che essa ha assunto nel tempo. Un progetto indubbiamente ambizioso e pionieristico; mentre gli ultimi due volumi sono ancora in preparazione, quanto già prodotto lascia emergere una molteplicità di narrazioni e una ricchezza di spunti con cui la storiografia a venire, e auspicabilmente anche il dibattito sulle sorti dell’Europa, dovranno necessariamente dialogare in futuro.
Il volume qui preso in esame affronta il tema dell’Europa delle competenze (se è lecito tradurre in questo modo l’inglese expertise), dell’innovazione tecnologica e dei saperi tecnici. Quanto ai due autori, Martin Kohlrausch è docente di Storia politica europea a Leuven in Belgio, mentre Helmut Trischler è direttore di ricerca al Deutsches Museum di Monaco. Altri studiosi hanno rintracciato le radici del complesso e inesauribile rapporto tra la tecnologia e lo spazio europeo nella prima età moderna o persino in quella medievale; in questo caso i due autori racchiudono la vicenda tra le due date simboliche del 1851, epoca della «Grande esibizione dei lavori dell’industria di tutte le nazioni» (o più brevemente della prima fiera mondiale della tecnica) e il 2000, ovvero l’anno in cui l’Unione Europea licenziò l’ambiziosa «Agenda di Lisbona» che entro dieci anni voleva fare dell’Europa «la più dinamica e competitiva economia del mondo fondata sulla conoscenza».
Data la vastità del tema e del periodo presi in esame, è opportuno l’avvertimento iniziale che spiega come l’accezione di «Europa» qui impiegata trascenda la cartografia politica o naturale del continente, per includere «significati sociali, connotazioni culturali e identità sociopolitiche». I destini e l’estensione dell’Europa della conoscenza e della tecnica impongono di considerare piuttosto i confini che essa ha raggiunto nel tempo con l’influenza diretta o indiretta su altre parti del globo, dalle colonie e gli ex imperi, fino alle entità politiche e sociali che hanno intrapreso percorsi di emulazione del Vecchio Continente. In tal modo il volume apre a una serie di valutazioni sulla trasmissione delle idee e sulla loro contaminazione attraverso soggetti politici altrimenti considerati non comunicanti: è questo il caso dei regimi radicalmente diversi che costituivano l’Europa del periodo tra le due guerre, come anche dei due blocchi ideologici e militari in cui il continente è stato diviso dopo il 1945. Quanto alla categoria di «esperti tecno-scientifici» al centro del volume, essa è tratteggiata in termini ampi per includere «professionisti qualificati che, pur non essendo degli scienziati, hanno attinto a principi scientifici per il loro lavoro», ottenendo un riconoscimento pubblico delle loro competenze e un’«influenza politica e sociale»: una definizione che anticipa un particolare interesse per le interazioni tra gli «esperti» e gli attori sociali e politici che richiedevano le loro conoscenze.
Al di là delle ragioni simboliche, l’inizio della trattazione dalla metà del XIX secolo è giustificato dall’importanza acquisita allora dalla scienza e dalla tecnologia in termini di visibilità e riconoscibilità sociale, testimoniata dalla nascita di università e accademie scientifiche secondo un processo di emulazione a catena tra i paesi europei ben documentato nel primo capitolo. Subito emerge una tensione fondamentale che pervade l’intero volume tra la dimensione nazionale e transnazionale. Alla prima fa riferimento la decisione di coltivare e promuovere l’educazione tecno-scientifica e di coinvolgere in modo sistematico i «tecnici» nell’edificazione dello Stato moderno, delle sue infrastrutture e della sua comunità. D’altro canto, è soprattutto dopo il tornante del secolo che la dimensione transnazionale sembra affermarsi sia come continuo processo di emulazione e appropriazione, sia di transito delle idee e degli stessi esperti da uno Stato all’altro, veri «apostoli» della modernizzazione e del progresso. In questo senso, uno dei passaggi più affascinanti del libro riguarda il processo di affermazione degli esperti tecnici come nuova elite nazionale, con il conferimento di prerogative e riconoscimenti simbolici precedentemente interdetti alle professioni materiali. Le sempre più frequenti esposizioni internazionali diventano così occasioni di sfoggio e di competizione tra le nazioni per dimostrare una superiorità precedentemente legata allo sviluppo delle arti e delle lettere: «il varo di navi o il completamento di dighe divennero eventi potenti e altamente emblematici in cui la tecnologia era affermata come impresa nazionale, in cui le vecchie elite rendevano omaggio alla nuova classe tecnica». In questo senso, la sovrapposizione tra le missioni nazionali proclamate durante la Grande guerra e il contributo determinante della tecnica alla sua condotta è valutata come un’evoluzione quasi naturale dei processi maturati in precedenza.
Grande attenzione è riservata dal volume al periodo tra le due guerre, paradossale compendio tra la più grande fiducia nei confronti delle capacità educatrici e liberatorie dei saperi tecnici, e il connubio tra questi ultimi e nuovi regimi politici devoti, prima ancora che al bellicismo, a progetti di ingegneria sociale con conseguenze drammatiche. «Il contratto faustiano», ovvero la disponibili- tà offerta da molti tecno-scienziati, convinti che soltanto esperienze politiche totalitarie offrissero spazi e risorse all’applicazione integrale dei loro progetti, è indagata nel dettaglio dai due autori. Tuttavia, il desiderio di rimarcare la pur evidente distinzione tra regimi totalitari e non ha condotto a sottovalutare progetti simili (seppure di portata ben più ridotta) anche nei paesi democratici, ad esempio in materia di eugenetica o di controllo del ciclo vitale dei lavoratori.
Con una provocazione presumibilmente intenzionale, la parte del libro dedicata al secondo dopoguerra si apre con un lungo paragrafo dedicato al recupero da parte degli alleati di quegli esperti che avevano fatto le fortune dei regimi fascisti in molti campi. Successivamente, il libro esamina l’interazione tra il processo di integrazione politica dell’Europa (dapprima occidentale) e quello della cooperazione tecno-scientifica attraverso esempi storicamente rilevanti quali il CERN, l’Euratom e la cooperazione in materia nucleare, e infine l’esplorazione dello spazio promossa dall’ESA. Sebbene sia difficile riassumere i risultati di un panorama talmente variegato, gli autori sembrano indicare che all’integrazione politica non ha corrisposto un processo assimilabile per la collaborazione scientifica, che invece ha seguito percorsi diversi di «integrazione nascosta», spesso settoriale e derivante dall’iniziativa privata piuttosto che da stimoli politici. A questa naturale incongruenza sono forse dovuti i risultati poco incoraggianti delle politiche dell’Unione Europea volte a fare dell’Europa una «società della conoscenza» distinta, omogenea e riconoscibile. Dati alla mano, gli autori suggeriscono che sia stato un processo di globalizzazione naturalmente prodotto dai nuovi mezzi di comunicazione e dalle possibilità di movimento a prevalere su un’europeizzazione politicamente voluta e (con un paradosso) progettata da tecnici. Dall’excursus gli autori sembrano trarre la conclusione che, fintantoché persisteranno speranze e sogni di mutamento della società per mezzo dei saperi tecnici, l’Europa continuerà a rappresentare una «potenza mondiale della conoscenza» anche nel mutato contesto internazionale. Maggiore scetticismo essi riservano ai tentativi della politica di selezionare, omologare e indirizzare gli sviluppi di tale potenziale, anche sulla base dei molti inquietanti precedenti «patti faustiani» ricordati nel libro.