

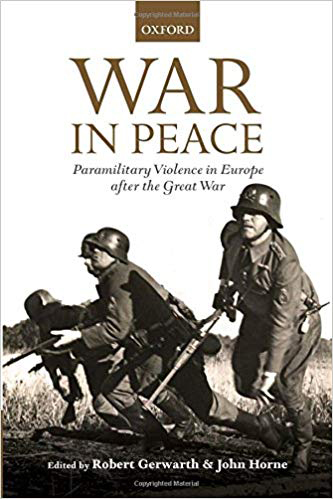
Reviewer Marco Mondini - Università di Padova- Isig
Citation«Quando finisce una guerra? Quando è terminata la Grande Guerra?» si chiedono Stéphane Audoin-Rouzeau e Cristophe Prochasson introducendo nel 2008 un volume (Sortir de la Grande Guerre) dedicato alla transizione del post-1918. Si tratta di una questione solo apparentemente semplice. Come oltre vent’anni di storia culturale di guerra hanno messo in luce, il termine ufficiale delle ostilità nelle guerre nazionali, industriali e di massa dell’Europa del XX secolo ha coinciso raramente con il ritorno allo status quo della vita civile, e quasi mai con l’arrestarsi della violenza. Il novembre 1918, in effetti, non porta affatto la pace sul continente. Al contrario, gli armistizi del primo conflitto mondiale, così come l’apertura della conferenza di Parigi, e in qualche misura persino la sua conclusione con la sigla dei trattati di pace (le «false paci» e le «precarie tregue» che Elie Halévy già intuiva nel 1914), ebbero più spesso il ruolo di detonatori di altrettanti conflitti, non tradizionalmente combattuti e quasi mai dichiarati. Rivoluzioni e contro rivoluzioni, guerre di indipendenza, conflitti etnici e guerre civili attraversano buona parte del continente europeo dal 1917 (inizio della Rivoluzione russa) almeno al 1923, quando il fallimento del putsch hitleriano pare segnare la fine della stagione più virulenta della violenza politica interstatale. Non si tratta di una periodizzazione assoluta, e soprattutto non valida per tutto il continente: i tempi della guerra greco-turca, virtualmente terminata con il collasso dell’ideale neo-bizantino nel 1922, non sono quelli della guerra sovietico-polacca, di fatto chiusa nell’estate 1920. Tuttavia, un fattore comune di questi anni è l’esplodere delle organizzazioni paramilitari e l’emergere del loro ruolo nella vita pubblica, sia come attori delle «guerre in tempo di pace» negli stati dell’Europa centro-orientale (Germania, Austria, Polonia, paesi baltici, Finlandia, Ungheria, Cecoslovacchia, Russia) sia sul fronte della lotta politica armata nei paesi usciti sconfitti dal conflitto (Germania, Austria, Ungheria) o vittoriosi (Italia, Gran Bretagna – nello specifico della guerra civile irlandese – e in misura minore Francia). Ad esse è dedicato questo volume collettaneo curato da Robert Gerwarth e John Horne, che riassume i risultati di un gruppo di studio radunatosi in due importanti convegni a Dublino (2008 e 2010). Per «violenza paramilitare», nella definizione fornita dai curatori, si deve intendere la pratica di organizzazioni armate che «espandono o rimpiazzano l’attività di formazioni militari convenzionali» (p. 1). Il contesto privilegiato in cui le organizzazioni paramilitari possono svilupparsi è, in primo luogo, un vuoto di potere dello Stato e la crisi del «monopolio della violenza legittima»: è ciò che succede nell’Italia tra 1919 e 1922, nella Germania di Weimar dei primi anni o nella fragile repubblica austriaca. Ma la «violenza paramilitare» può anche rivelarsi un’espressione extralegale di politiche statuali. Nell’impossibilità di utilizzare la forza armata statale per i vincoli imposti dagli alleati, i Freikorps tedeschi agiscono inizialmente come supplenti del potere legittimo: concorrono alla stabilizzazione del governo repubblicano di Berlino e ne difendono i confini nelle guerre ‘clandestine’ sui confini orientali e in Slesia.
I quattordici saggi raccolti da Gerwarth e Horne coprono molto bene lo spettro delle differenti situazioni politiche e dei diversi contesti geografici in cui la violenza paramilitare si sviluppa come caratteristica primaria delle «guerre nella pace» europee. Una prima sezione (Revolution and counter-revolution) è dedicata all’affermarsi delle organizzazioni paramilitari e degli eserciti privati nel caos della guerra civile russa. La «matrice sovietica», per così dire, è la fucina del modello dell’organizzazione armata di stampo politico, ma anche la culla di una psicosi collettiva (Bolschevism as Fantasy recita il titolo di un saggio a quattro mani degli stessi curatori). Una seconda sezione (Nations, Borderlands and ethnic Violence) è dedicata alle diverse «guerre dopo la guerra» in cui le formazioni paramilitari occupano un ruolo protagonista combattendo per la revisione dei confini decisi dalle potenze vincitrici (Turchia, Polonia, Germania) o per la sopravvivenza (o la «resurrezione») di nuovi stati nazionali (Ucraina, Irlanda).
War in peace non è tuttavia solo una solida raccolta di casi di studio spesso relativamente ignoti, è anche un brillante laboratorio in cui vengono utilizzate e discusse almeno due fondamentali categorie di analisi della storia culturale di guerra. La prima, «smobilitazione culturale», è una chiave di analisi particolarmente efficace per interpretare la transizione dalla guerra alla pace nel XX secolo: nei paesi coinvolti dai conflitti nazionali e industriali si piegano alle esigenze della guerra non solo gli apparati economici e politici, ma anche i panorami mentali, attraverso forme di «arruolamento dell’immaginario» che sono in larga parte spontanee e prepolitiche. Alla fine del 1918, le «culture di guerra» sono tuttavia molto più difficili da smobilitare di quanto lo siano uffici e strutture logistiche. E nei casi delle «guerre in tempo di pace», in cui le formazioni paramilitari prosperano e diventano protagoniste, è evidente il fallimento della smobilitazione culturale: al di là dei trattati e del ritorno ufficiale alla normalità prebellica, in Germania, in Polonia, in Italia o in Turchia si continua a predicare la necessità di una guerra per sconfiggere i nemici della nazione esterni e interni, per difendere i suoi sacrosanti diritti, per combattere il male che minaccia di impadronirsene. Lo «spirito di crociata» viene costantemente ri-mobilitato anche sul terreno della contesa politica: i «bolscevichi» tedeschi o italiani non sono semplici avversari ma «antipatrioti», e come tali vanno annientati. La seconda categoria ad essere discussa è «brutalizzazione». È stato soprattutto George Mosse a rendere popolare la convinzione che il fallito ritorno alla pace (interna) fosse la conseguenza dell’incapacità delle società postbelliche di superare e in qualche modo sublimare l’esperienza traumatizzante del conflitto moderno. La prima critica mossa a tale ipotesi è la sua applicabilità relativa. La teoria di una politica brutalizzata dall’esperienza bellica funziona in alcuni casi nazionali, ma non in altri (Gran Bretagna e Francia, soprattutto); eppure, si chiedono i curatori, l’esperienza di guerra fu più o meno la medesima presso tutti i paesi. Un fattore ulteriore da chiamare in causa è allora la «mobilitazione del potere della sconfitta» (mobilizing power of defeat). Laddove il risultato del conflitto 1914-1918 (o dei suoi strascichi) è l’umiliazione dello Stato nazionale e la messa in discussione delle sue legittime e tradizionali élites dirigenti, sia in termini sostanziali (come in Germania) che apparenti (l’Italia della «vittoria mutilata»), la gestione del ‘ritorno a casa’ (sociale e culturale) dei combattenti è molto più problematico, e spesso impossibile. La sopravvivenza di solidi regimi parlamentari è, in tale contesto, un brillante «contro esempio», come suggerisce John Horne (Defending Victory: Paramilitary Politics in France 1918-1926).
Un’annotazione finale va riservata al caso italiano, qui affidato a Emilio Gentile (Paramilitary Violence in Italy). Il saggio di Gentile riassume molto efficacemente il problema della violenza armata e dell’organizzazione paramilitare come fenomeno intrinseco al movimento fascista e poi al PNF, seguendo una linea interpretativa già autorevolmente tracciata venticinque anni fa nella Storia del partito fascista. Vale però la pena di sottolineare che il caso italiano della «fallita transizione» alla pace non è semplicemente sussumibile nella genesi e nello sviluppo del fascismo. Benché Gentile abbia ragione nel sostenere che il fascismo italiano fu, sotto il profilo dell’organizzazione della violenza armata come strumento politico, un pioniere, sta di fatto che i militanti delle squadre fasciste non furono né i primi attori di una violenza strutturata e di natura paramilitare né, per un lasso di tempo relativamente lungo (cioè fino all’estate 1920) i più efficaci. Che nell’Italia appena uscita dalla Grande Guerra si dovesse riprendere le armi per una nuova crociata «contro i nemici interni» lo sostenevano, ben prima e più autorevolmente di molti esponenti del piccolo movimento mussoliniano, gli esponenti della vasta e confusa galassia patriottica: fu Piero Calamandrei, per non fare che un esempio noto, a parlare pubblicamente di «vittoria tradita» e ad esortare a continuare la guerra contro i «traditori della patria». La percezione di una «pace fallita» e quindi di un «ritorno impossibile» per i combattenti fu molto più che il frutto di una abile congiura propagandistica, e la convinzione che lo Stato nazionale uscito dal Risorgimento stesse effettivamente perendo sotto i colpi della «rivoluzione rossa» e a causa di un vuoto di potere delle istituzioni legittime permeava non solo i segmenti della borghesia nazionalista. La legittimazione della violenza paramilitare «patriottica» in Italia affonda in un clima generale di ri-mobilitazione delle culture di guerra che va molto oltre il movimento fascista, benché poi da quest’ultimo sia stato abilmente sfruttato.