

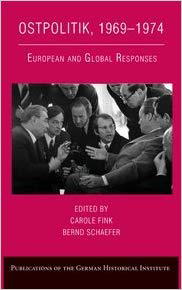
Reviewer Giovanni Bernardini - FBK-ISIG e European University Institute
CitationStrano destino, quello della diplomazia. Raramente essa cattura l’attenzione dell’opinione pubblica, scoraggiata da formalismi e rituali che paiono materia da iniziati, e dall’apparente assenza di risultati tangibili nel breve periodo. Prova ne sia il misto di diffidenza e indifferenza che solitamente i contemporanei riservano a estenuanti negoziati multilaterali in campo europeo e mondiale, pure suscettibili di produrre mutamenti sostanziali per l’esperienza di vita quotidiana.
Tra le rare eccezioni, un caso a se stante è rappresentato dalla Ostpolitik condotta dai governi social-liberali della Repubblica Federale Tedesca tra il 1969, anno della nomina di Willy Brandt alla Cancelleria, e le sue dimissioni, occorse in circostanze drammatiche nel 1974. Le ragioni di tale ‘successo’ sono certamente rintracciabili nelle implicazioni morali che sottintendevano alla «nuova politica orientale», e alla rilevanza delle conseguenze che essa produsse nel breve come nel lungo periodo per l’intera Europa. Ad un’ulteriore indagine di quei negoziati, e dei loro riverberi sullo scacchiere internazionale, è dedicato il volume curato da Carole Fink e Bernd Schaefer. Il libro in buona misura mantiene quanto promesso dai curricula dei due curatori: Fink ha già posto in passato la sua conoscenza della storia contemporanea al servizio di importanti volumi collettanei, quali 1968: A World Transformed (1998) e 1956: European and Global Perspectives (2006). Per quanto riguarda Schaefer, la lunga esperienza al German Historical Institute di Washington lo ha spronato a ‘sprovincializzare’ la vicenda tedesca nel dopoguerra, come dimostra un numero speciale del bollettino dell’istituto che già nel 2002 anticipava le tematiche del libro in questione.
L’opera racchiude contributi incentrati sulle ripercussioni che la Ostpolitik ebbe presso «alleati ed avversari» (prima parte), e su alcune «risposte globali» al sorprendente incedere della «nuova politica orientale» che mutò il corso delle relazioni internazionali della Repubblica Federale Tedesca (seconda parte). Come è noto, nel 1969 Willy Brandt divenne il primo cancelliere socialdemocratico del dopoguerra, supportato da una coalizione social-liberale; per la prima volta dal 1949 restava fuori dal governo l’Unione Cristiano Democratica (CDU), artefice incontrastata dell’ancoraggio del paese alle istituzioni atlantiche ed europee occidentali. In breve tempo il nuovo governo mostrò un attivismo senza precedenti, rimettendo in discussione alcuni ‘dogmi’ che avevano caratterizzato il ventennio precedente. Furono soprattutto normalizzate le relazioni con Mosca e con tutti i paesi dell’Est, e i due stati tedeschi sancirono il loro riconoscimento reciproco, aprendo la strada all’ammissione di entrambi alle Nazioni Unite nel 1973.
Nell’introduzione i due curatori concordano nell’attribuire un duplice valore alla Ostpolitik, secondo una linea interpretativa avallata nel complesso dagli altri autori del libro. Ad un primo livello, la politica perseguita da Brandt mirava al riconoscimento delle responsabilità per gli orrori del regime nazista e all’accettazione della realtà europea emersa dal conflitto mondiale (aspetto evidenziato nei saggi di Andrey Edemskiy, Krzysztof Ruchniewicz, Oldrich Tuma sui rapporti di Bonn con Mosca ed alcuni paesi del «socialismo reale»). Tuttavia, l’ottica di lungo periodo mostra anche la valenza strumentale e propositiva della «nuova politica orientale»: il riconoscimento dell’ordine postbellico era inteso come premessa necessaria ad un suo cambiamento, alla creazione di un diverso sistema di sicurezza che allentasse la morsa della Guerra Fredda sull’Europa, restituisse ai suoi popoli una maggiore sovranità sui propri destini a scapito della ‘tutela’ delle superpotenze, e infine lenisse gli effetti della divisione della Germania, fino a prefigurare una sua pacifica riunificazione. I saggi di Holger Klitzing e Marie-Pierre Rey dimostrano quale grado di apprensione riservassero a questa politica anche governi ‘amici’ di Bonn, come l’amministrazione statunitense di Nixon e la presidenza francese di Pompidou: all’ombra del plauso generalizzato, la rinnovata ‘libertà di manovra’ tedesca generava non pochi sospetti e diffidenze, anche a Ovest.
I saggi di Schaefer e di Milan Kosanovic inducono a considerare quanto, per il governo social-liberale, «regolare i conti col passato» significasse portare la statura politica del paese a collimare con la sagoma di gigante economico che esso si era da tempo ritagliato. Ecco la ragione per cui la Ostpolitik mutò anche i rapporti politici di Bonn rispettivamente con Pechino e Belgrado, regimi accomunati da condizioni del tutto peculiari sullo scacchiere internazionale, ma anche dal bisogno estremo di promuovere i contatti economici e commerciali con l’Occidente. In particolare, Kosanovic ha buon gioco nel proporre la soluzione elaborata da Brandt e dal maresciallo Tito all’annosa questione delle riparazioni di guerra come una delle chiavi di lettura dell’intera Ostpolitik. Infatti, la trasformazione delle riparazioni in un ingente prestito con condizioni vantaggiose per Belgrado, ma che di fatto incentivavano un cospicuo incremento dei rapporti economici bilaterali, rispondeva appieno al proposito di Brandt che «il futuro del suo paese avesse la precedenza sul suo terribile passato».
Fink volge invece la propria attenzione ai mutamenti delle relazioni tra Bonn e Tel Aviv, gravate da evidenti eredità storiche. La volontà espressa più volte dal governo Brandt di imprimere al rapporto un carattere di «normalità», e di mantenere un approccio «equilibrato» alla situazione medio-orientale, furono motivo di preoccupazione e recriminazione per Israele. Tuttavia, la prospettiva di lungo periodo aiuta a comprendere quanto gli artefici della Ostpolitik intendessero fare della Repubblica di Bonn un «attore globale più indipendente ed assertivo» che in passato, anche a costo di offrire il fianco ad accuse di eccessiva disinvoltura nei confronti del recente fardello storico. Non dimenticare il passato, insisteva Brandt, non poteva significare rimanerne prigionieri.
Una menzione particolare merita il contributo di William G. Gray, già autore dell’imprescindibile Germany’s Cold War (2007), storia ragionata della «Dottrina Hallstein». In questo caso Gray utilizza la lente della questione nucleare pacifico/militare per rileggere non soltanto la Ostpolitik, ma l’intero mutamento di significato della proiezione internazionale della Repubblica Federale Tedesca prima e dopo il tornante del 1969: alle recriminazioni per un’esclusione dal «club atomico» di fatto già sancita dagli eventi, il governo social-liberale sostituì una conduzione politicamente più raffinata dell’adesione tedesca alla politica di non proliferazione, e al contrario una gestione ben più spregiudicata del potenziale tecnologico del paese, al fine di aumentarne l’influenza economica e politica in aree extraeuropee.
A completare il volume figurano i saggi di Meung-Hoan Noh, Amit Das Gupta e Tilman Dedering, centrati sull’influenza che l’esempio della Ostpolitik esercitò rispettivamente sui rapporti tra le due Coree, sul subcontinente indiano, e sul Sudafrica. Seppure non sempre convincenti, date le differenze incommensurabili tra gli scenari geopolitici presi in esame e la necessità di una ben più ampia trattazione specifica di questi ultimi, i contributi non possono essere ridotti a mera curiosità intellettuale, se non altro perché ribadiscono chiaramente quanto vasta sullo scenario globale fosse la proiezione dei tanti riverberi prodotti dal prisma della Ostpolitik.
Il libro rappresenta dunque un’operazione riuscita, in primo luogo per la pluralità di chiavi di lettura e spunti di riflessione che esso offre a chi desidera approfondire una fase cruciale della storia tedesca del dopoguerra. Tuttavia, esso finisce anche per segnalare l’urgenza di una ricostruzione complessiva e articolata del peso esercitato dalla Ostpolitik nel ridefinire le relazioni della Repubblica Federale Tedesca con il mondo, e soprattutto con il suo passato, presente e futuro. Una ricostruzione necessaria per evitare che la «nuova politica orientale» rimanga un collage iconografico certo significativo, come quello posto a corredo del libro qui preso in esame, ma irrimediabilmente statico e frammentario.